Pubblichiamo uno stralcio del libro “Per una medicina
umanistica. Apologia di una medicina che curi i malati
come persone”, di Giorgio Israel, edito da Lindau e arrivato
da pochi giorni in libreria.
Non si tratta neppure lontanamente di mettere in discussione
i progressi e le conquiste della medicina
occidentale e di sottovalutare i suoi indiscutibili meriti.
(…) I suoi trionfi si ripetono ogni giorno quando consegniamo
al medico il fascicolo degli esami di laboratorio,
le radiografie, le ecografie, le Tac, i test genetici, che disegnano
in modo sempre più approfondito e minuzioso
la geografia fisiopatologica del nostro corpo. Ma quei fogli
non sono una chiave incantata che permette di accedere
in modo immediato alla comprensione dello stato
del paziente che sta di fronte al medico. In primo luogo,
egli deve chinarsi a lungo su quei risultati analitici: è un
obbligo che deriva proprio dalla scelta “scientifica” assunta.
(…) Può sembrare una predica superflua e presuntuosa
ricordarlo, ma non lo è quando si constata che
troppo spesso la valutazione del risultato analitico si riduce
a un mero confronto con un insieme di intervalli di
normalità codificati una volta per tutte in modo troppo
generico e impersonale. In secondo luogo, non basta fissare
lo sguardo e la mente sulle carte. Occorre che lo
sguardo del medico si levi verso il paziente, verso la persona
in carne e ossa che gli sta di fronte. Ricordare anche
questo non è una predica superflua e fastidiosa, perché
questo sguardo si solleva sempre di meno e sempre
di più il paziente si trova di fronte a un apparato anonimo,
il “sistema sanitario” che lo esamina con un tipo di
rapporto che assomiglia sempre di più a quello di una
macchina con un’altra macchina.
(…) Potremmo limitarci a criticare certi eccessi della
medicina scientifica moderna e le sue estreme manifestazioni
contemporanee osservando che, distruggendo di
fatto la figura del medico e riducendolo a una figura di
tecnico operativo che applica un insieme di protocolli
standardizzati, essa distrugge allo stesso tempo una modalità
di intervento che ha un ruolo ineliminabile: il rapporto
interpersonale, il rapporto umano tra paziente e
medico in cui il secondo risponde alle domande e alle
esigenze poste dal primo, in funzione del suo “sentirsi
malato”. Se si riduce la malattia all’“essere malato” del
medico-scienziato o medico-tecnico, annullando la considerazione
del “sentirsi malato” che ci viene proposta
dal paziente, si trascura la sofferenza personale, si disumanizza
la medicina, trasformando l’ospedale in officina
di riparazione totalmente spersonalizzante e, in definitiva,
angosciosa. In fondo, basterebbe dire questo, e lo abbiamo
detto più volte. Ma si può dire molto di più. E cioè
che la spersonalizzazione e la mera quantificazione, l’abolizione
del vissuto del malato, rappresentano un approccio
riduttivo dal punto di vista della razionalità e
concettualmente sbagliato. Nel caso della medicina, concepire
l’oggettivismo scientifico in termini radicali, e
cioè come riduzione di ogni aspetto soggettivo a caratteristiche
oggettive impersonali e generali, è un errore grave
dal punto di vista concettuale. La scientificità della
medicina non può essere la stessa di quella della fisica.
Affrontare il problema della malattia o della salute di
una persona non ha nulla di analogo allo studio del moto
di un elettrone o di un pianeta o delle proprietà di un
campo elettromagnetico. (…) L’unico modo di realizzare
la scientificità della medicina è di tener conto che il suo
oggetto sono dei soggetti, e dei soggetti considerati nella
loro individualità e particolarità, portatori di una storia
personale situata in modo irripetibile nello spazio e nel
tempo. La risposta a questa sfida la medicina la possiede
ed è la clinica, che è proprio la caratteristica operativa
che più la contraddistingue rispetto a ogni altra attività
conoscitiva e pratica. La clinica è indissolubilmente
legata alla considerazione della soggettività, della persona
e delle sue “richieste” – del suo sentirsi malato, e
non soltanto del suo essere malato. (…)
E’ del tutto evidente che il desiderio di ridurre la medicina
a una scienza meramente oggettivista in analogia
con le scienze “esatte” è spesso dettato da due fattori:
dalla pigrizia – è molto più semplice esaminare quanto
più possibile meccanicamente dei risultati analitici che
non farsi carico di un esame complessivo e complesso
della persona che ci sta di fronte – e dalla soggezione
esercitata dalle scienze “esatte”, come se adeguarsi al loro
metodo fosse l’unico modo per conquistarsi un biglietto
d’ingresso al salotto buono della scienza. Insisto
sul verbo “ridurre”, perché ritengo che una siffatta visione
sia riduzionista non soltanto nel senso oggettivo
della parola, ma anche nel senso valutativo: essa comporta
cioè un’amputazione della ricchezza della medicina,
che non può essere vista soltanto come una “scienza”
fra le altre, ma rappresenta qualcosa di molto più complesso.
Si ripropone qui spontaneamente la vecchia caratterizzazione
della medicina come “arte”. Sappiamo
bene quanto questa definizione sia oggi criticata e persino
infastidisca chi l’accusa di essere la manifestazione
di discorsi fumosi che hanno come unico scopo (o effetto)
quello di porre una barriera tra la medicina e la
scienza, quasi che la medicina fosse un’attività estetica
come suonare il pianoforte, dipingere un quadro o danzare.
Questa è una tipica manifestazione della consueta
soggezione nei confronti delle “vere” scienze; ma è anche
un deplorevole oblìo di che cosa significa “arte” in
questo contesto. E’ un oblìo del tutto analogo a quello
che abbiamo visto nel caso dell’idea di “natura”, nel contesto
della concezione dinamico-funzionalista. “Arte” qui
sta per “tecnica”, ovvero per un complesso di capacità
pratiche sostenute dalla conoscenza, ma non identificabili
come mera conoscenza teorica. Come ha giustamente
osservato Grmek, “la medicina non è mai stata e non è
neppure oggi una scienza. I Greci la chiamavano iatrikè
téchne, in contrapposizione a epistéme, considerandola
come una specie di attività artigianale che opera la sintesi
tra scienza, tecnica e arte”. Quindi, la medicina non
è una scienza come la chimica o la fisica, ma è una pratica
che utilizza tutte le scienze, un’arte della vita che fa
uso di scienze di varia estrazione. (…)
Riteniamo quindi di poter concludere osservando che
all’abbandono della clinica non può sopravvivere nessuna
forma di medicina, neppure quella scientifica. E forse
a maggior ragione questa. Che la clinica resti al centro
della medicina è la condizione perché possa sopravvivere
una medicina razionale nel senso pieno del termine,
e quindi anche degna di essere considerata scientifica.
La medicina rischia quindi di (…) mutilarsi se aderisce
all’ideale oggettivistico. Una medicina che abbia
“cura” della persona non può essere meccanicista, ma
deve essere risolutamente umanistica. Essa non può
aderire a una visione della malattia come mero “guasto”
di una macchina umana, o come una perturbazione abnorme
dei parametri caratteristici dello stato di salute.
Come ha osservato Canguilhem, “la vita di un vivente riconosce
le categorie di salute e di malattia soltanto sul
piano dell’esperienza, che è innanzitutto un fatto affettivo,
e non sul piano della scienza. La scienza spiega l’esperienza
ma non l’annulla per questo”.
Giorgio Israel
© Copyright Il Foglio 23 febbraio 2010
 Dépistage prénatal : Les marchands de risques, par Alexandra Benachi, Roland Gori, Odile
Dépistage prénatal : Les marchands de risques, par Alexandra Benachi, Roland Gori, Odile  Buisson...
Buisson...



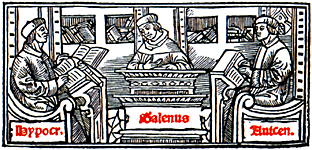 Questi mutamenti della figura del paziente e del medico vengono sempre più spesso giustificati come una conseguenza positiva e benefica di un'evoluzione inevitabile, e cioè del fatto che la medicina assume sempre di più i connotati di un'attività scientifica fondata su basi rigorosamente oggettive. Insomma, la riduzione dello spazio concesso agli aspetti soggettivi e interpersonali sarebbe un male minore rispetto al progresso consistente nel fatto che la medicina diventa sempre di più una "scienza" basata su protocolli analitici solidi e oggettivi.
Questi mutamenti della figura del paziente e del medico vengono sempre più spesso giustificati come una conseguenza positiva e benefica di un'evoluzione inevitabile, e cioè del fatto che la medicina assume sempre di più i connotati di un'attività scientifica fondata su basi rigorosamente oggettive. Insomma, la riduzione dello spazio concesso agli aspetti soggettivi e interpersonali sarebbe un male minore rispetto al progresso consistente nel fatto che la medicina diventa sempre di più una "scienza" basata su protocolli analitici solidi e oggettivi.

