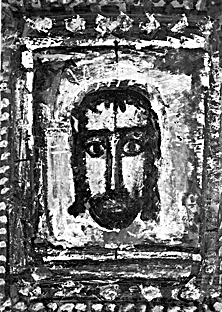DISCERNERE
Uno sguardo profetico sugli eventi
Il teologo Cottier contesta Fackenheim e sostiene che Dio non resterà muto
Non mi riferisco direttamente all’opera
di Fackenheim ma alla
presentazione che ne dà Riccardo De
Benedetti.
Una prima difficoltà è capire il significato
di ontologico applicato all’evento
della Shoah. Probabilmente
vuol esprimere non soltanto l’unicità
della Shoah ma la sua funzione di
principio strutturante la storia, di
punto di riferimento per tutti gli altri
avvenimenti. Ne riceve una posizione
trascendente.
E’ probabile che l’affermazione abbia
anche il senso di denuncia critica
delle grandi filosofie razionaliste, come
quella di Hegel, che relativizzano
l’evento, e specialmente l’evento carico
di male, facendone un momento
dello sviluppo della storia come processo
razionale e necessario. Tale critica,
se questo è il caso, era già stata
formulata da Kierkegaard. Davanti alla
mostruosità della Shoah, le spiegazioni
razionalistiche sono totalmente
inadeguate e derisorie.
Infine, positivamente, l’aggettivo
ontologico vorrebbe sottolineare che
si tratta, con la Shoah, di un male assoluto,
faccendone una specie di entità.
Ma così si profila all’orizzonte
l’ombra dell’antico dualismo. Infatti,
la Shoah ci mette a fronte di una dimensione
abissale del male. Spontaneamente
si pensa all’interrogazione
piena di ansia di Giobbe, la quale
sfocia su un atto di speranza eroico.
Ma tale non è la via scelta da
Fackenheim.
Il pensiero di Fackenheim è un’espressione
di spicco della “religione
della Shoah” così chiamata e analizzata
da Alain Besançon. La tragedia
della Shoah che ha colpito il popolo
ebraico e che ha ferito in maniera incancellabile
la sua memoria, è unica,
a tal punto che il paragone con altre
tragedie è rigettato come una blasfemia.
“Nell’abisso che si spalanca
manca Dio”: non si tratta di un silenzio
temporaneo, ma di un fatto dato
come irreversibile. Per i cristiani come
per gli ebrei fedeli alla religione
dei loro padri, la Shoah è unica, perché
il popolo che colpisce è il popolo
eletto da Dio. In questo senso, il crimine
contro questo popolo è simultaneamente
un crimine contro il Dio
dell’Alleanza. La “religione della
Shoah” fa dell’esperienza del silenzio
di Dio vissuta da tante vittime innocenti
una categoria metafisica. La
relazione a Dio diviene estranea alla
definizione dell’unicità dell’evento.
Rimane soltanto “la fedeltà a se stesso
del popolo ebraico”.
Davanti a questa secolarizzazione
radicale, non possiamo non porre la
domanda patetica: qual è il fondamento
di questa fedeltà, se non c’è
più la fedeltà di e al Dio dell’Alleanza?
E’ necessario a questo punto ricordare
da quale ideologia i persecutori
e gli assassini del popolo ebraico
hanno tratto la loro ispirazione. Il dio
del nazismo, immanente alla natura e
alle sue forze irrazionali, è un dio pagano,
un idolo, che non poteva non
combattere il Dio della rivelazione.
Dalle profondità tenebrose della natura
divinizzata e delle sue energie
biologiche, proviene la divisione dell’umanità
in razza superiore e razze
inferiori, schiavi o razze non degne di
sopravvivere. L’affermazione della
razza superiore, grazie alla forza, della
sua superiorità, equivale ad una
elezione. La razza superiore è la razza
eletta. La guerra di conquista è per
lei un diritto, diritto di essere fedele
a questa elezione. L’eliminazione del
popolo dell’Alleanza considerato come
un concorrente, è un corollario di
questa mostruosa pazzia. Così l’ideologia
nazista rappresenta una parodia
satanica dell’elezione divina del popolo
ebraico.
Pio XI, dichiarando che noi cristiani
siamo spiritualmente dei semiti e
pubblicando l’enciclica “Mit brennender
Sorge” (redatta dal futuro Pio
XII) aveva denunciato una impostura
che offendeva la santità di Dio stesso.
Che dei cristiani abbiano utilizzato
il simbolo della croce come se fosse
la giustificazione della persecuzione
degli ebrei è uno scandalo per la quale
la chiesa domanda perdono. Ma
per la fede cristiana la croce è lo strumento
che l’amore di Dio ha scelto
per la nostra redenzione. L’articolo
tocca un tema centrale, oggetto di un
malinteso dolorosissimo fra ebrei e
cristiani. Lo fa nella logica della “re-
ligione della Shoah”.
Se la Shoah, come l’interpreta
Fackenheim, è il centro della storia,
questo significa che si sostituisce a
Cristo. Ma come, se Dio ne è assente,
tale evento può avere un valore redentore?
O non c’è redenzione o la redenzione
diviene l’autoredenzione
dell’uomo, della quale Dio è stato
espulso. Siamo nella logica dell’umanesimo
ateo. Per Fackenheim, leggiamo,
“Hegel è il pensatore cristocentrico
per eccellenza”. Ma Hegel rappresenta
in realtà una gnosi cristologica,
nella quale la fede in Cristo non
può riconoscersi.
La redenzione è oggetto di fede.
Per i cristiani, il suo fondamento è la
persona stessa di Cristo, che per il
dono di sé ha offerto all’umanità la liberazione
dal peccato. L’opera della
nostra redenzione si sviluppa nel
tempo della storia, nella lotta spirituale
contro le forze del peccato, prima
nel nostro cuore ma anche nel
mondo. La vittoria definitiva sul male
non sarà data all’interno della storia
presente, ma al di là.
“Cristo è risorto dai morti primizia
di coloro che sono morti”, scrive Paolo
ai Corinzi (1 Corinzi 15, 20), precisando
che se la nostra speranza in
Cristo fosse soltanto per questa vita,
siamo da commiserare più di tutti gli
uomini. Non abbiamo quaggiù una
città stabile, ma siamo pellegrini in
cerca della città futura. Lassù tutto
sarà rivelato e vedremo come l’amore
di Dio ha sconfitto ogni male.
Il domenicano George Cottier
è cardinale, teologo emerito
della Casa pontificia
© Copyright Il Foglio 3 aprile 2010
Fackenheim vola nei cieli dell’ontologia, ma la storia non è finita con la Shoah. di Giorgio Israel
qualcuno ha preteso, un libro
che sviluppa una “teologia dell’Olocausto”.
Come dice l’autore “non ci
può essere una disciplina di questo tipo”.
Ma c’è – egli aggiunge – “una teologia
che è sfidata dall’Olocausto e
che, evitando ogni tipo di fuga, salva la
propria integrità auto-esponendosi ad
esso”. La questione è delicata perché
una teologia ebraica nel senso stretto
del termine non esiste. Difatti, nell’ebraismo
gli eventi divini sono momenti
di un percorso interminato e
proiettato verso la fine dei tempi e
verso la redenzione messianica. Questo
percorso vive nella tensione continua
tra il sistema dei precetti, la cui
osservanza garantisce in modo quasi
automatico di restare entro i confini
di una vita irreprensibile, e l’ammonimento
profetico contro il rischio
dell’automatismo: la confusione tra
formalismo e morale. E’ una tensione
che riecheggia anche nel Talmud
quando, chiedendosi perché mai fu
distrutto il Secondo Tempio proprio
in un periodo in cui il popolo seguiva
in modo irreprensibile i precetti, si dice
che “Gerusalemme fu distrutta unicamente
perché vi si seguiva scrupolosamente
la legge della Torah”.
L’ebraismo ha tratto la sua forza
dall’operare continuo di questa tensione.
Se il Talmud ha enfatizzato il
primo termine le correnti mistiche e
messianiche hanno riproposto il messaggio
profetico, fino alla sua forma
più recente rappresentata da Teodoro
Herzl e dal sionismo. La Kabbalah
rappresenta ciò che più nell’ebraismo
è vicino alla teologia, sebbene si tratti
più che altro di teosofia e di esplorazione
delle forme della vita divina,
al fine di colmare l’abisso tra uomo e
Dio attraverso un percorso di avvicinamento
mistico.
Forse la Kabbalah più “teologica”
(ma sempre in un senso molto speciale)
è quella cui fa riferimento il titolo
del libro di Fackenheim: “Tiqqun”. E’
la Kabbalah cinquecentesca di Safed,
soprattutto quella di Isaac Luria. Gershom
Scholem ne ha approfondito le
motivazioni individuandole nel terribile
dramma che fu per l’ebraismo l’espulsione
dalla Spagna nel 1492.
Fackenheim, con molta superficialità,
considera questo dramma come un
evento di rilievo minore della Shoah.
Invece esso fu un cataclisma epocale.
Come osserva Scholem, ci volle un secolo
perché fosse assimilato, dando
poi luogo alla Kabbalah di Safed che,
a sua volta, ispirò una drammatica
speranza di redenzione che culminò in
un’esplosione vulcanica di messianismo
di cui fu principale esponente fu
il falso messia Sabbatai Zevì. Furono
eventi le cui ondate si propagarono fino
al Settecento.
La dottrina di Luria affrontò in modo
audacissimo il problema del male
identificandone addirittura l’emergere
in un “errore” cosmico avvenuto
nell’atto creativo del mondo. La creazione
del nulla era spiegata con un atto
di “autocontrazione” (tsimtsum) di
Dio, una sorta di “esilio” divino con
cui Egli fece posto a uno spazio finito
e vuoto in cui doveva propagarsi l’emanazione
generatrice del mondo.
Durante il processo emanativo i “vasi”
che trasmettevano la luce divina
non ne sostenennero la potenza e si
ruppero in frammenti, così che molte
scintille della luce divina si diffusero
in un’esplosione cosmica e restarono
imprigionate negli strati inferiori del
mondo del male. Il compito del popolo
ebraico è ricercare ovunque le
scintille divine per estrarle e farle
ascendere ai livelli superiori, in vista
di una riparazione universale (Tiqqun).
Trovano così senso sia il dramma
della “prigionia” del bene che l’esilio
del popolo ebraico condannato
alla dispersione per il compito di ricercare
i frammenti dispersi fino alla
redenzione finale.
Il Tiqqun è però un evento destinato
a compiersi alla fine della storia, in
coincidenza con l’avvento messianico,
da costruire giorno per giorno nella
pratica con cui l’ebreo riconosce i
suoi errori e i suoi peccati e ad ogni
istante ricomincia daccapo: la Teshuvah.
Quest’ultima è la riparazione a
misura d’uomo, Tiqqun è l’evento conclusivo,
che costituisce la riparazione
della vita divina, dell’errore avvenuto
nell’atto creativo.
Nel pensare il Tiqqun come atto di
riparazione del mondo dall’evento metastorico
rappresentato dalla Shoah,
Fackenheim rischia di proporre una
teologia apocalittica che già una volta
minacciò di dissoluzione un ebraismo
che, dopo essere stato colpito nel 1492
dalla dispersione e dalla distruzione
(tra roghi, conversioni forzate e marranismo),
era caduto nello smarrimento
provocato dal falso messianismo e dalla
conversione finale di Sabbatai all’islam.
In realtà, Fackenheim fa molto
di più: egli propone il Tiqqun nella
cornice di un’ontologia di un Olocausto
di cui dichiara l’assoluta unicità:
un evento la cui riparazione è necessaria
affinché il mondo possa riprendere
il suo cammino che si è arrestato
per l’enormità dell’accaduto ma che in
realtà sembra possa compiersi soltanto
all’interno dell’ebraismo.
Di fronte al librarsi di Fackenheim
nel cielo dell’ontologia, ci si vergogna
quasi di scendere sul triviale terreno
dello storiografia per contestare la tesi
dell’assoluta unicità della Shoah.
Ma, in fin dei conti, è proprio
Fackenheim ad avvalorare questa tesi
sul piano storico. Solo che lo fa con
pochi e scarni argomenti, dati come
ovvi. Le sue righe sbrigative sfigurano
dinanzi alla profondità con cui un
Vassili Grossmann ha esplorato il senso
del legame profondo tra Lager e
Gulag. Quindi, Fackenheim prende un
incerto volo verso l’ontologia, e intesse
un dialogo esclusivo proprio con
quella tradizione della filosofia la cui
pretesa di costituire una scienza assoluta
dell’essere è una radice dei mali
che hanno colpito la civiltà europea.
Viene da chiedersi perché mai
Fackenheim dialoghi in modo povero
e piattamente recriminatorio con Spinoza;
perché scelga qualsiasi interlocutore
filosofico salvo che Husserl, ovvero
colui che trovò la forza e la speranza,
anche negli ultimi anni quando
ebbe la Gestapo sotto casa, di proporre
una via d’uscita per salvare la vocazione
filosofica europea liberandola
dalle impasses dei grandi sistemi
ontologici. Viene da chiedersi perché
non dialoghi con un filosofo cristiano
così attento al tema della memoria come
Paul Ricoeur; e perché senta così
poca consonanza con le correnti dell’ermeneutica
(Lévinas incluso) e della
fenomenologia. E viene da rispondere
che egli si è chiuso da solo in una
sterile prigione pretendendo che le
aporie teologico-filosofiche suscitate
da Auschwitz siano un fatto inedito
nella storia storia, e ricercando il “Tiqqun
filosofico” (come lo chiama) nel
posto sbagliato.
Ontologizzando la Shoah
Fackenheim legittima la domanda di
De Benedetti se egli non stia proponendo
“un tentativo di sostituzione del
cristocentrismo”. Chi scrive non ha il
timore di De Benedetti di urtare suscettibilità
e ritiene che, sì, dal punto
di vista ebraico questa di Fackenheim
è un’“eresia” cristologica. Col tentativo
di fare della Shoah il sostituto di
Cristo (nello stile di un moderno sabbataismo)
e col presentare il Tiqqun
come un heideggeriano ritorno al “da”
del “Dasein” ebraico, Fackenheim
congeda l’ebraismo. Difatti, egli dice:
“Senza una tradizione recuperata non
c’è futuro per gli ebrei”. Tutto qui? A
questo si riduce il Tiqqun che dovrebbe
riparare il mondo? In effetti, si riduce
a questo perché il cataclisma ontologico
arrestando la storia imprigiona
anche l’ebraismo mutilandolo della
sua dimensione profetica che alla
storia appartiene irrevocabilmente.
Ma la storia non si lascia arrestare da
nessuna sentenza circa il carattere ontologicamente
inassimilabile e insuperabile
di un evento.
Giorgio Israel è docente di Storia
della matematica all’Università
La Sapienza di Roma
e studioso di problemi dell’ebraismo
© Copyright Il Foglio 3 aprile 2010
Il rabbino che studiava Gesù. L'esegesi neotestamentaria di Israel Zolli
di Anna Foa Il libro Il Nazareno di Eugenio Zolli apparve nel 1938, pubblicato dall'Istituto delle Edizioni Accademiche di Udine. Israel Zolli, che poi diventerà Eugenio, era all'epoca rabbino capo a Trieste e non era ancora subentrato - lo avrebbe fatto un anno dopo - nella cattedra rabbinica romana al rabbino David Prato, cacciato nel 1938 perché sionista. Pochi mesi dopo la pubblicazione di questo libro, le leggi razziste di Mussolini fecero di Zolli, nato a Brody, in Galizia, ma cresciuto in Italia, un apolide, e lo catapultarono negli anni duri della persecuzione. Sette anni dopo, nel febbraio 1945, sollevando un grande scandalo nel mondo ebraico italiano e molto clamore anche in quello non ebraico, Israel Zolli si convertì al cattolicesimo, prendendo con il battesimo il nome di Papa Pacelli e divenendo così Eugenio Zolli.
Un volume su Gesù Cristo - riproposto in un'edizione curata da Alberto Latorre Il Nazareno. Studi di esegesi neotestamentaria alla luce dell'aramaico e del pensiero rabbinico (Milano, San Paolo, 2009, pagine 618, euro 42) - scritto da un rabbino di primo piano, dunque, destinato poco dopo, nonostante questo libro e il vago sentore ereticale che lo circondava già da molti anni, a diventare il rabbino maggiore della Comunità romana. Una prefigurazione del suo percorso posteriore, un'anticipazione del suo successivo battesimo? Oppure, un percorso di studi esegetici ampiamente condiviso in ambito ebraico, un'attenzione verso la figura di Gesù Cristo propria, a partire dalla seconda metà dell'Ottocento, a molta parte del pensiero esegetico ebraico europeo? È quest'ultima la prospettiva in cui lo colloca, nella sua ampia e preziosa postfazione, il curatore Alberto Latorre, analizzando gli studi ebraici e cristiani sul Cristo in quei decenni cruciali del primo Novecento e contestualizzando in quest'ambito il lavoro di Zolli.
Il rabbino triestino scrive su Gesù e sui rapporti tra il primo cristianesimo e la cultura rabbinica del tempo con accenti e tesi non dissimili da quelle dei suoi maestri al Collegio Rabbinico di Firenze, Chayes e Margulies, e suscitando molte minori polemiche di quante non ne avesse suscitate il libro di Joseph Klausner su Gesù il Nazareno, che al suo apparire in ebraico a Gerusalemme nel 1921 fu attaccato tanto dagli ebrei ortodossi che dai cristiani, come ricorda, in un interessante brano di un suo romanzo ripreso da Latorre nella sua postfazione, il nipote di Klausner, lo scrittore Amos Oz.
Un ambito di studi molto frequentato dagli studiosi ebrei di tutt'Europa, e in particolare da quelli di area tedesca, eredi della Scienza del Giudaismo e legati alle correnti riformate, che sottolineavano fortemente l'ebraicità di Gesù e mettevano in rilievo le corrispondenze tra l'ebraismo rabbinico e il primo cristianesimo. Ma prediletto anche dagli studiosi cristiani, particolarmente protestanti, nella Germania del xix secolo, nell'ambito della scuola di Tubinga e delle successive scuole di teologia liberale, e fatto proprio, all'inizio del nuovo secolo, dagli studiosi modernisti. Un contesto, questo legato al metodo storico-critico di esegesi biblica, di grande interesse dalle due parti, di cui Latorre delinea qui con attenzione le coordinate culturali e storiche.
Se questo era il clima culturale in cui nasceva il poderoso studio di Zolli, bisogna anche dire che si trattava di un clima a cui scarsissimi furono gli apporti del mondo ebraico italiano. Fanno eccezione il Collegio rabbinico di Livorno, dove nella seconda metà dell'Ottocento insegnò Elia Benamozegh, il Collegio rabbinico di Firenze, con il suo nucleo di maestri di provenienza dalla Galizia, e Trieste, città culturalmente e fino al 1918 anche politicamente asburgica, aperta a tutte le correnti culturali mitteleuropee, non ultima, con Weiss, quella psicanalitica. Con Firenze e con Trieste strettissimi furono i rapporti di Zolli, che a Firenze aveva compiuto i suoi studi e a Trieste fu rabbino per vent'anni. Lontano da queste correnti culturali più ampie e legate all'esperienza di studi tedeschi, e all'impronta lasciata su di essi dal movimento riformato ebraico, era la cultura ebraica italiana, che non condivideva l'attenzione per la figura storica, per le categorie ebraiche della sua predicazione, e in genere per le radici ebraiche del cristianesimo. Un taglio più tradizionale e parrocchiale, che accomunava in quel momento storico l'ebraismo italiano agli studi di esegesi cattolica, anch'essi assai distanti, tranne che per alcune figure maggiormente legate al modernismo, dall'impostazione esegetica storico-critica diffusa nel resto d'Europa.
Nel suo volume, che raccoglieva contributi in parte già pubblicati nelle riviste di Raffaele Pettazzoni, Studi e materiali di storia delle religioni, e di Ernesto Buonaiuti, Ricerche religiose, Zolli procedeva utilizzando, oltre il metodo storico-critico, l'analisi comparativa delle religioni. Nelle conclusioni, lo studioso si discostava significativamente tanto dall'esegesi ebraica consolidata quanto dai dogmi della Chiesa cattolica. Egli sottolineava fortemente la somiglianza della predicazione di Gesù con l'ebraismo, postulava una stesura originaria dei Vangeli in ebraico e aramaico, negava che il termine nazareno derivasse da Nazaret - un argomento, questo, usato da quanti sostenevano la non storicità di Gesù - e faceva derivare l'eucaristia da un'evoluzione del seder pasquale ebraico.
Inoltre nel testo sembrava apparire fra le righe un riconoscimento della messianicità di Cristo. Ci sarebbe certamente stato di che suscitare le reazioni opposte di ebrei e cattolici. Tuttavia, queste reazioni non vi furono. Secondo Latorre, il mondo cattolico non aveva intenzione di attirare l'attenzione su un volume "di così difficile decifrazione e inquadramento", in un momento in cui la crisi modernista si era da poco ricomposta e in cui il clima antisemita rendeva pericoloso ogni dibattito su temi così scottanti. La Chiesa preferì così passare sotto silenzio o quasi il volume (se si eccettuano le recensioni sostanzialmente positive da parte dei gesuiti de "La Civiltà Cattolica"), rinunciando perfino a utilizzare in chiave apologetica un testo in cui un illustre rabbino sembrava adombrare la messianicità di Cristo.
Quanto alla mancanza di obiezioni da parte ebraica, il contesto storico in cui apparve il libro, quello delle leggi del 1938, non spingeva a sollevare questioni tanto delicate, soprattutto nei mesi cruciali fra 1938 e 1939 in cui, mi sentirei di aggiungere, nella Chiesa non mancava chi, come padre Gemelli, sembrava auspicare un incontro tra le dottrine razziste e la Chiesa cattolica. Il volume fu invece molto apprezzato dal mondo accademico italiano e straniero. Entusiastica fu, nel novembre del 1938, la recensione di Ernesto Buonaiuti su Ricerche Religiose.
Al di là delle questioni strettamente esegetiche, il volume pone allo sguardo del lettore di oggi numerose questioni strettamente storiche e ci rimanda numerosi interrogativi sulla vicenda di Israel/Eugenio Zolli e sulla natura stessa della sua conversione. Una conversione certamente frutto di una scelta meditata, l'esito di un percorso lungo e difficile, ma anche una conversione che si limita a spostare accenti ed enfasi, ma non sembra cambiare sostanzialmente la qualità del discorso di base: un'analisi rigorosamente critica dei testi biblici, che lo sollevava al di sopra di ogni ortodossia, che lo portava ad accentuare i legami storici fra ebraismo rabbinico e cristianesimo e a cogliere nella figura dell'ebreo Gesù la chiave di questo complesso momento di passaggio e trasformazione.
Il Nazareno appartiene alla fase ebraica dei lavori di studioso di Zolli, ma i cambiamenti introdotti dalla conversione nei suoi lavori critici sono stati assai scarsi, e motivati forse solo da ragioni di obbedienza e prudenza. Fra Wissenschaft e modernismo, si dipanava così il percorso religioso e scientifico, due momenti indissolubilmente intrecciati, dell'opera di Zolli. Una figura di confine, che gli ebrei, giustamente feriti dalla sua defezione, non capirono, e che la Chiesa nel dopoguerra, in un momento distante anni luce dalle aperture ebraico-cristiane, preferì lasciare in disparte. Il Nazareno è il frutto più alto di questo essere sul limite, fra le diverse ortodossie.
(©L'Osservatore Romano - 20 febbraio 2010)
Chabad. Gli ebrei «d’assalto»
senza dubbio uno dei fenomeni più importanti dell’ebraismo contemporaneo. Sottovalutato, come accade spesso con i grandi cambiamenti che si giocano negli stretti confini di una confessione religiosa, senza sforare troppo in ambito profano. Si tratta di Chabad – acronimo ebraico di Saggezza, Comprensione e Conoscenza – il movimento degli ebrei Lubavitcher, chiamati così dal nome della cittadina nell’attuale Russia da cui prese inizio la loro storia oltre due secoli fa. È il gruppo chassidico divenuto, nella seconda parte del ’900, non solo il più numeroso, con oltre 200mila aderenti, ma quello di gran lunga più dinamico e in espansione, all’insegna di una missione ben precisa: riavvicinare all’ortodossia ebrei agnostici o non praticanti, riportare una presenza ebraica viva in comunità ridotte al lumicino, iniziarne di nuove là dove l’ebraismo non era mai arrivato o quasi, diffondere – anche con l’uso assai spigliato dei mezzi di comunicazione – la propria spiritualità. Questo è ciò che è avvenuto per esempio in Cina, dove Chabad è arrivato nel 2001, trovando pressoché il vuoto; in meno di 10 anni è diventato il perno di una comunità di 1500 anime a Shanghai, aprendo centri in altre sei città. | ||||
 | ||||
 EBREI CHABAD POSANO CON L’ALLORA PRESIDENTE USA BUSH RABBINI DI CHABAD PRESSO IL LORO QUARTIER GENERALE DI BROOKLYN, A NEW YORK, PER IL LORO RADUNO ANNUALE LARAS: «HANNO PORTATO NUOVA LINFA. MA IL FUTURO RESTA INCERTO»
Avvenire 14 febbraio 2010 | ||||
PICCOLE E GIUSTE. Così un gruppo di ragazzine svizzere rimproverò per lettera il Consiglio federale che respingeva gli ebrei in fuga.
Egregi Signori Consiglieri Federali,
non possiamo fare a meno di
dirvi che noi alunne siamo profondamente
indignate che i profughi vengano
ricacciati così spietatamente verso
una sorte tragica. Si è forse dimenticato
completamente che Gesù ha detto:
‘Ciò che avete fatto al più piccolo
tra voi, lo avete fatto a me’. Non ci saremmo
mai immaginate che la Svizzera,
l’isola di pace che pretende d’essere
misericordiosa, avrebbe ributtato
come bestie oltre la frontiera questi
miseri esseri infreddoliti e tremanti.
Non succederà anche a noi quanto è
accaduto al ricco che ha ignorato il
povero Lazzaro? A cosa ci servirà poter
dire: Sì, nell’ultima guerra la Svizzera
si è comportata bene, se poi non
avremo nulla da mostrare di buono
che la Svizzera abbia fatto in questa
guerra, in particolare per gli emigranti?
(…) Quando ci è stato chiesto di
raccogliere contributi siamo state
pronte a farlo per la nostra Patria (…).
Per questo ci permettiamo di pregarvi
di accogliere questi poverissimi
senza patria. Vi salutiamo con stima e
con sentimento patriottico”.
Seguono le firme.
Il Consiglio federale è il governo
centrale svizzero. Gli esseri scacciati
come bestie sono gli ebrei che tentano
di entrare nel paese, le autrici di
questa lettera venti alunne quattordicenni
della II C della Sekundarschule
di Rorschach, una cittadina del
Cantone Sangallo. La data è il 7 settembre
1942, in piena fase di chiusura
dei confini. E’ il primo atto di una
storia imprevista, dove si avvicendano
ministri, poliziotti, insegnanti, autorità
scolastiche, genitori. La racconta
un bellissimo libro in uscita, ricco
di dati e fatti nuovi (Silvana Calvo, “A
un passo dalla salvezza. La politica
svizzera di respingimento degli ebrei
durante le persecuzioni 1933-1945”,
Zamorani), in cui si guarda alle istituzioni
e ai cittadini attraverso la lente
delle normative e dei comportamenti
verso gli ebrei.
Nell’Europa di quegli anni la Svizzera
non rifulge. Certo, è un paese accerchiato
da regimi totalitari o collaborazionisti,
vive di banche, valuta
pregiata, esportazioni, e non può permettersi
di rompere i suoi canali di
commercio e scambio. Non ha un
esercito imponente, e il Terzo Reich
potrebbe invaderla in pochi giorni –
Belgio e Olanda hanno mostrato che
dichiararsi neutrali è una ben povera
difesa. Tutto vero: la Svizzera è un bilico,
può far conto solo su se stessa,
non dispone di risorse infinite. Deve
adattarsi.
L’altra faccia è che si tratta di un
paese dove le istituzioni funzionano,
nessuno fa la fame, si possono trovare
beni di consumo, sigarette, farmaci,
oggetti che altrove sono un ricordo.
Un paese che ha una milizia popolare
addestrata, un sistema di fortificazione
alpina, un popolo con forti sentimenti
patriottici. E una lunga tradizione
di accoglienza agli esuli politici.
Ma non agli ebrei, che premono
dai confini austriaco, tedesco, poi
francese e italiano, e che – sostiene
un documento ufficiale – non sono in
alcun modo assimilabili ai politici,
per i quali la porta è, se non aperta,
socchiusa. Vanno ributtati indietro al
luogo di provenienza, a volte sono letteralmente
passati di mano, da gendarme
svizzero a gendarme tedesco, a
milite di Salò, a poliziotto italiano o
francese. Come agli altri stati europei,
alla Svizzera la sorte degli ebrei
non importa affatto. Storia nota.
Sola, meravigliosa eccezione è la
Danimarca occupata, dove nell’ottobre
1943, appena si viene a sapere
che i tedeschi stanno preparando deportazioni
di massa, scatta l’azione
congiunta delle istituzioni e dei cittadini,
che riescono a traghettare nella
sicura Svezia più del 90 per cento dei
7.695 ebrei danesi, e tedeschi rifugiati
– che fatica trattenersi dal raccontare
la vicenda per intero! Hannah
Arendt scriverà che l’esempio della
Danimarca, unico stato insignito come
tale del titolo di “Giusto tra le nazioni”,
avrebbe dovuto essere proposto
agli studenti di scienze politiche,
per far capire a quali risultati può
arrivare una lotta non violenta, sorretta
da una buona coesione sociale,
dal riconoscimento popolare nelle
istituzioni. E dalla convinzione che
l’uguaglianza non è un principio negoziabile.
In Svizzera finisce invece per esserlo,
se non in linea teorica, nei fatti.
Per una terra d’asilo, è una scelta
stridente, che il governo cerca di far
passare con una campagna di organizzazione
del consenso. Si comincia da
quel caposaldo politico/simbolico che
consiste nel dare un nome alle persone
– per gli ebrei il termine ufficiale
è “emigranti”, non profughi o rifugiati,
che alludono al dovere di accoglienza.
Si continua insistendo sui pericoli
per l’ordine pubblico, sulla
scarsità di risorse, sull’assistenza gravosa,
sul sovraffollamento – ma secondo
i dati raccolti nell’Appendice del
volume, i “profughi civili” sono stati
51.219, di cui 21.304 “profughi ebrei” e
6.654 “emigranti ebrei”; e del loro sostentamento
si sono fatti carico i correligionari
svizzeri.
Si gioca anche la carta degli stereotipi,
e non importa se si contraddicono
a vicenda: gli ebrei sono troppo
legati fra loro, ma nello stesso
tempo straordinariamente abili nell’infiltrarsi.
Peseranno come parassiti
sui bilanci, o all’opposto faranno
carriera e denaro ai danni degli svizzeri
– allo sterotipo dell’ebreo avido
e astuto non si rinuncia neppure in
situazione estrema. Ma il successo è
parziale.
Nonostante le limitazioni introdotte
con la guerra, la Svizzera resta un
paese democratico, dove la stampa
ha buoni margini di libertà e le notizie
circolano. Con il risultato che ormai
si sa a quale destino vadano incontro
gli ebrei respinti; e che nascono
reti di aiuto composte di cittadini,
associazioni ebraiche e non, membri
delle istituzioni – poliziotti, diplomatici,
esponenti dei governi cantonali,
guardie di frontiera. Una piccola minoranza
periodicamente scardinata
dalla polizia, ma capace di salvare
delle vite.
A Rorschach, paese di confine, l’idea
della lettera matura quando le
alunne leggono su un giornale il racconto
di un respingimento particolarmente
brutale; in passato qualcuna
ha assistito a scene simili. Decidono
in fretta, scrivono sentendosi doppiamente
nel giusto. Perché amano la
Svizzera, e perché si richiamano a
una ragione che giudicano superiore
a quelle della politica: “E’ possibile
che voi abbiate ricevuto l’ordine di
non accogliere ebrei, ma questa è certamente
la volontà di Dio, e noi dobbiamo
ubbidire più a Lui che agli uomini”.
Il secondo atto è truce. Gli uomini
del Consiglio federale si scandalizzano,
si allarmano. Con ragione:
una parte dei cittadini sta aiutando
gli ebrei a entrare nel paese in violazione
della legge, altri lo sanno e tacciono.
Ora protestano persino i bambini;
peggio, le bambine. Brucia l’accenno
a ordini venuti dall’esterno,
che ricorda l’espulsione degli anarchici
a fine Ottocento: “Elvezia il tuo
governo schiavo d’altrui si rende”, dice
un verso di “Addio a Lugano”.
Il ministro per la Sicurezza interna
Eduard von Steiger, lo stesso uomo
che aveva coniato la metafora “la barca
è piena”, trasformò la lettera delle
ragazzine di Rorschach in un affare
di stato. Prepara una lunghissima risposta,
squadernando l’intera gamma
dei valori cristiani e civici – tranne il
dovere della solidarietà con i disperati.
La discute con i colleghi, decide
di non spedirla per non dare troppo
rilievo al caso, e di aprire invece
un’inchiesta a Rorschach per scovare
gli istigatori. Ci sono genitori aperti,
forse addirittura socialisti, saranno
loro. C’è un insegnante presunto antimilitarista,
sarà lui, e si progetta di
incriminarlo penalmente. L’ultimo
pensiero è che la ragazzine abbiano
fatto da sole. A conferma – rubo il titolo
a Simona Vinci – che dei bambini
non si sa niente. Vale in parte anche
per la Shoah. Nella letteratura e
nella storiografia c’è molto sui piccoli
prigionieri, quasi il vuoto sui piccoli
soccorritori. Che pure ci sono stati.
Bambini che accompagnavano gli
ebrei alla frontiera, che portavano
messaggi; che nei ghetti polacchi facevano
sopravvivere le famiglie con
piccoli furti e commerci. Bambini che
mentivano alle SS: “Qui non c’è nessuno”.
Alla fine si dovrà riconoscere che
gli istigatori non esistono. Interrogate
pesantemente, alcune ragazzine si
spaventano un po’, altre si scusano
per i termini più severi, ma non
“abiurano” affatto.
La storia viene messa a tacere: ma
dopo questa e altre lettere, il governo
deve ammorbidire per vari mesi la
sua politica – variare le disposizioni
per l’asilo a seconda del clima nazionale
è una costante. Come è una costante
il tentativo di evitare che i respingimenti
avvengano sotto gli occhi
della gente, a costo di lasciare che i
profughi penetrino per qualche chilometro
in territorio svizzero: per passare
dalla norma giuridica alla norma
etica, la spinta decisiva è spesso l’incontro
faccia a faccia con la sofferenza
dei perseguitati.
Decenni dopo, alcune ex ragazzine
rievocano la vicenda con una tranquillità
che sembra la versione adulta
della lucida freschezza di allora.
Sfido chiunque a non innamorarsi di
questa storia.
E un po’ anche dell’autrice, che
non è un’accademica o una giovane
studiosa in carriera, ma una signora
svizzera in pensione da un impiego
pubblico e con un grande amore per
la ricerca. Sebbene non l’abbia mai
vista, la immagino mentre raccoglie
bozze di lettere, lettere, verbali di interrogatori,
commenti della stampa,
dichiarazioni politiche; mentre segue
le tracce delle sovversive di Rorschach.
E mentre impara il mestiere nel
rapporto magistrale con il suo docente.
Che è Fabio Levi, autore di una
quantità di opere di storia degli
ebrei, e ora de “La persecuzione antiebraica.
Dal fascismo al dopoguerra”
(Zamorani, Torino). Una raccolta
di saggi che andrebbero recensiti
uno per uno, ma che nascono tutti dal
desiderio di riconsiderare le cristallizzazioni
più comuni fra gli storici (e
non solo).
Il primo bersaglio è l’identificazione
generalizzata e univoca degli
ebrei con il destino di vittime. Per
quanto esistano, scrive Levi, aspetti
di continuità fra la persecuzione del
1938 - ’45 e le norme discriminatorie
precedenti all’emancipazione, ci sono
state fasi e situazioni relativamente
propizie alla formazione di soggettività
diverse. Con l’affermazione dei
principi liberali, possono moltiplicarsi
i modi di essere e sentirsi ebrei:
osservanti, credenti, agnostici, patriottici
o meno, bendisposti oppure
ostili verso i matrimoni misti. E, non
diversamente dal resto degli italiani,
fascisti, antifascisti, politicamente indifferenti.
Persino nella condizione
di vittime assolute del ’38-’45, ci sono
reazioni e strategie di sopravvivenza
diverse, da chi tiene unita la famiglia
– quel che Bettelheim imputava ai
Frank – a chi sceglie di dividerla perché
da soli o in coppia è più facile
trovare rifugio. Anche se quasi sempre
ci si salva per caso, ogni vittima
ha una storia propria.
C’è poi, ed è ben radicata, una doppia
convinzione: che alla spietatezza
dei vertici abbia corrisposto una relativa
tolleranza delle amministrazioni
periferiche; che l’inefficienza delle
istituzioni abbia giocato a favore degli
ebrei. Visione ottimistica la prima,
pseudoromantica la seconda, che idoleggia
il disordine e che i fatti provvedono
a smentire: l’inefficienza poteva
giovare, così come poteva dare spazio
a ricatti, arbitri, inganni.
Un terzo snodo è la riflessione sulle
diverse letture del rapporto Italia/
Shoah. Il mito nazionale del buon
italiano oggi è moribondo, come è naturale,
visto che al tempo del fascismo
e della guerra erano moribondi
il senso della giustizia e dell’onore:
in Italia hanno vissuto opportunisti,
eroi veri, veri miserabili. Basti pensare
al funzionario che nel 1938 va a
scrutare le lapidi del cimitero ebraico
di Milano per scoprire le quote di
sangue “sbagliato” di un cittadino.
Ma dicono molto anche l’adesione
plebiscitaria dei professori universitari
(1237 su 1250) alla richiesta di
giurare fedeltà al regime, il silenzio
di fronte alle leggi razziste del ’38, la
tranquilla accettazione, salvo casi
isolatissimi, delle cattedre tolte ai titolari
ebrei – il tradimento dei chierici
ha una lunga storia. Del resto, la
stessa resistenza è poco sensibile alla
condizione degli ebrei – e parecchi
ebrei fanno la resistenza sentendosi
in primo luogo antifascisti.
Levi, che non è certo incline a demonizzare
gli italiani e ne valorizza
anzi l’opera di soccorso, mostra però
che a guerra finita il paese non sembra
molto interessato a farsi perdonare.
Dichiarandosi tutt’altra cosa dal
regime, la repubblica rigetta ogni responsabilità
per il passato e centellina
riassunzioni e risarcimenti, seguita
da banche, sindacati, organizzazioni
imprenditoriali. La restituzione dei
beni va a rilento, ai professori rientrati
si nega la vecchia cattedra.
A volte si dice che gli italiani amano
sentirsi buoni piuttosto che giusti.
Questo libro, argomentatissimo e a
tratti sorprendente, suggerisce anche
che la “bontà” dura poco e costa poco:
giusto il tempo e lo sforzo di esternare
quel profluvio di buoni sentimenti
verso le vittime, che all’indomani
della liberazione infastidiva
Giacomo Debenedetti, il primo a raccontare,
in “16 ottobre 1943”, il dolore
degli ebrei italiani.
Il Foglio 30 gennaio 2010
Ebrei Addio all’Europa?
Alla vigilia della Shoah, nel 1939, gli ebrei d’Europa erano circa dieci milioni.
La popolazione ebraica era già stata ridotta dall’emigrazione dalla Russia, quando fra il 1881 e il 1924 circa due milioni di ebrei avevano raggiunto l’America. Una parte di questi emigranti si erano fermati cammin facendo in Inghilterra e in Francia, dando vita ad un fitto proletariato ebraico, a Parigi come a Londra. Un’emigrazione più ridotta, ma sempre significativa, aveva portato in terra d’Israele, in successive ondate, migliaia di ebrei russi, destinati a divenire l’élite politica del nuovo insediamento sionista. Nei decenni tra la prima e la seconda guerra mondiale, il maggior numero degli ebrei europei risiedeva nella Russia sovietica e nei paesi dell’Europa orientale, la Polonia, la Cecoslovacchia, l’Ungheria, la Romania, la Bulgaria. La prima guerra mondiale, con le trasformazioni della mappa politica europea che aveva determinato, aveva comportato radicali modifiche anche nella mappa dell’ebraismo europeo. Ebrei prima cittadini dell’Impero austro-ungarico, e quindi tutti emancipati fin dal 1867, vivevano fianco a fianco con ebrei russi o romeni, privati fino ad allora di ogni emancipazione. Il rimescolamento delle nazionalità, nei nuovi Stati nati dalla dissoluzione dell’Impero asburgico, aveva favorito l’esplodere dei nazionalismi e il divampare degli antisemitismi.
In Europa occidentale, gli ebrei erano presenti in numeri assai più ristretti. Le maggiori comunità, quella francese e quella inglese, erano quelle che erano state interessate dall’immigrazione dalla Russia. In Italia gli ebrei erano una percentuale ridottissima della popolazione, circa l’uno per mille: da 39.000 al momento dell’unità d’Italia, erano passati a 45.000 nel 1940, con un aumento del 16% contro un aumento, nello stesso periodo, del 200% della popolazione ebraica totale e del 108% di quella dell’Europa occidentale.
L’antisemitismo crescente e poi il nazismo avevano intanto iniziato a provocare la fuga degli ebrei da una parte dell’Europa. Oltre trentamila ebrei, fra il 1924 e il 1926, avevano lasciato per la Palestina la Polonia dilaniata dalle violenze antisemite. Il 1933, con l’avvento al potere di Hitler, segna l’inizio dell’esodo dalla Germania dei cinquecentomila ebrei tedeschi che vi risiedevano (l’1% della popolazione). Prima del 1938, circa duecentocinquantamila ebrei avrebbero lasciato la Germania, molti dei quali per la Palestina (nel solo 1933, circa 35.000). Nel 1938, l’annessione dell’Austria obbligava gli ebrei che lo poterono a lasciare anche quel paese. Tra essi il vecchio Sigmund Freud, dopo che i nazisti gli ebbero devastato lo studio. A impedire l’emigrazione è ora la chiusura delle frontiere europee e americane ai profughi. Nel 1939, con il suo Libro Bianco, la Gran Bretagna bloccava anche l’immigrazione ebraica in Palestina.
Dieci milioni di ebrei sono così intrappolati in Europa quando Hitler scatena la guerra. Nel 1945, saranno scesi a circa quattro milioni. In realtà, la guerra introduceva una contraddizione fondamentale nella politica antiebraica di Hitler, volta a rendere il Reich privo di ebrei: con l’invasione della Polonia, infatti, altri due milioni di ebrei passavano sotto il dominio tedesco, con l’attacco alla Russia un altro milione. Se nel 1933 il Reich contava mezzo milione di ebrei, nel 1941 ne contava oltre tre milioni. Mentre Hitler faceva, nell’estate del 1941, la scelta dello sterminio, cominciava nelle città russe e polacche la creazione dei ghetti, dove gli ebrei vennero trasferiti in attesa di decidere la loro sorte, in condizioni tali da portarli alla morte per fame o per malattia. Nessun ghetto fu creato in Occidente, ma molti ebrei tedeschi ed austriaci furono deportati nei ghetti dell’Est. È il primo dei tanti, drammatici, spostamenti di popolazione ebraica che accompagnarono lo sterminio.
Tra il 1941 e il 1942, furono terminati di costruire i sei campi di solo sterminio, tutti in territorio polacco, e i numerosissimi campi di concentramento, presenti anche all’Ovest. Dai ghetti e dalle zone occupate si cominciano ad inviare gli ebrei ai campi, sui treni piombati che percorrono l’Europa. Man mano che la guerra è perduta per i nazisti, cioè dal 1944 in poi, ricominciano gli spostamenti dei prigionieri, spesso a piedi, nelle 'marce della morte'. I prigionieri di Auschwitz, in previsione dell’avanzata dell’Armata Rossa, sono trasferiti così nei campi tedeschi. La tenaglia alleata che libera l’Europa libera anche i sopravvissuti dei campi.
La fine della guerra non risolve subito il destino dei sopravvissuti: in un caos generale, in cui milioni di persone si spostano da un paese all’altro, i sopravvissuti ebrei, circa duecentocinquantamila, restano per mesi, se non per anni, nei campi di displaced persons , a volte ex campi di concentramento come Bergen Belsen.
Una metà di loro sceglierà di andare in Palestina, prima in un’emigrazione clandestina che passa anche attraverso i porti italiani, poi, dopo il 1948, liberamente. Gli ebrei dell’Est scelgono per la maggior parte di andarsene, come quelli polacchi, ancora alla prese in patria con l’antisemitismo. Solo quelli d’Occidente scelgono per la maggior parte di tornare. Così gli ebrei italiani, ridotti ormai, tra deportazioni, emigrazioni e abbandoni (ben 4000 conversioni in seguito alle leggi razziste del 1938), dai 45.000 che erano a meno di 35.000, dopo che fu cessato il passaggio attraverso l’Italia dei sopravvissuti, un numero ulteriormente abbassatosi negli ultimi decenni.
La Shoah distrugge così la maggior parte del mondo ebraico europeo: in quello orientale, ma anche in quello olandese e greco, la proporzione dei morti tocca il 90%, e anche gli altri Paesi occidentali pagano un tributo pesante. A partire dagli anni Sessanta, dei tre poli in cui ormai si è diviso l’ebraismo, quello europeo, quello israeliano e quello americano, i due ultimi sono decisamente preponderanti non solo nei numeri ma anche nella vitalità e creatività. L’Europa si limita a sopravvivere, senza che nemmeno una nuova immigrazione dai Paesi in via di decolonizzazione del Maghreb (in Italia dalla Libia, in Francia dall’Algeria) riesca a rivitalizzarne le comunità. L’egemonia ideale e politica di Israele è forte, e lo diventa ancor più dopo la guerra dei Sei giorni del 1967, e dopo l’elaborazione delle memorie della Shoah nell’Europa negli anni Settanta. Non a caso, il punto di riferimento di quei percorsi memoriali è il Mausoleo di Yad Vashem, a Gerusalemme. Si parla di 'fine della diaspora', si temono il declino demografico sempre più vistoso, gli esiti dei matrimoni misti, la mancanza di prospettive dell’ebraismo europeo.
La fine del comunismo, nel 1989, stenta a riunire i due mondi ebraici separati, quello dell’Est e quello dell’Ovest. Solo negli ultimi anni si è assistito ad una netta ripresa dell’ebraismo in Germania, dove si sono spostati molti ebrei dell’Est Europa, e che, dopo essersi ridotta a 30.000 ebrei, conta oggi la terza comunità d’Europa dopo la Francia e l’Inghilterra (oltre centomila), e nella stessa Polonia, rimasta quasi priva di ebrei dopo il 1967, quando il regime aveva dato il via ad una politica nettamente antisemita.
Che la salvezza venga, per l’Europa occidentale ancora una volta dall’Est? Che il mondo che ha prodotto la grande emigrazione americana e che ha creato il sionismo, dia nuova vita al mondo ebraico europeo, lo risusciti dal suo sopore? Se sarà così, in Occidente non se ne vedono che i primi barlumi e gli ebrei d’Europa continuano ad interrogarsi sul loro futuro.
Nel 1933, con l’avvento al potere di Hitler, ha inizio l’esodo dalla Germania dei cinquecentomila ebrei tedeschi che vi risiedevano (l’1% della popolazione).
Prima del 1938, circa duecentocinquantamila ebrei lasciarono il Paese, molti dei quali per la Palestina (nel solo 1933, circa 35.000). Nel 1939, con il suo Libro Bianco, la Gran Bretagna blocca anche l’immigrazione ebraica in Palestina
I GRUPPI
| |
Neusner: Un amico benefico e benedetto. Di G. Meotti
Per “il rabbino preferito del Papa” la visita del Santo Padre alla sinagoga di Roma conferma che «il dialogo tra la Chiesa e gli ebrei è giunto a maturazione»

A Neusner chiediamo quale sia la relazione fra Ratzinger e il giudaismo. «Papa Benedetto XVI ha portato avanti il messaggio del suo predecessore, Giovanni Paolo II il Grande, e ha formulato questo dialogo nel libro su Gesù. Si è impegnato a lavorare alle differenze fra le due grandi religioni della Scrittura. Ha assunto seriamente la critica giudaica alla cristianità e ha proposto una risposta cattolica. Il dialogo cristiano-giudaico è giunto a maturazione durante questo papato, il sì del Papa è un sì e il suo no è un no. Ha una mente chiara. La sua lezione di Ratisbona sull’islam ha mostrato devozione alla verità e integrità nel dialogo interreligioso. Il coraggio di quella lezione ha dato un modello di onestà e di chiarezza di visione che definisce oggi il dialogo religioso». Un dialogo, quello fra ebrei e cattolici, che secondo il professore-rabbino si fonda su una «causa comune», e cioè «la definizione condivisa delle Scritture, la Torah del giudaismo e l’antico Testamento della cristianità. I cattolici hanno appreso dal giudaismo l’interpretazione del mandato delle Scritture e gli ebrei hanno imparato dalla lettura cattolica. È una sfida profetica per entrambi. Ciascuno porta del suo e questo beneficia tutti, è un patrimonio che sosterrà le generazioni future».
Una questione ancora dirimente è lo Stato d’Israele. Un anno fa, durante l’offensiva militare a Gaza volta a sgominare le cellule terroristiche di Hamas che si sono impossessate della Striscia, alcuni rappresentanti della Santa Sede hanno attaccato duramente lo Stato ebraico, paragonando Gaza a un «campo di concentramento». Ma altri prestigiosi principi della Chiesa, a cominciare dall’austriaco Christoph Schönborn, hanno proclamato che Israele è un segno dell’elezione del popolo ebraico. Cinque anni fa, in visita in Israele, all’Università di Gerusalemme ha parlato sul tema “La terra eletta di Dio”. «Soltanto una volta, nella storia dell’umanità, Dio ha preso un paese in eredità e l’ha dato al popolo scelto da lui», ha detto l’arcivescovo di Vienna. «L’elezione del popolo ebraico e il suo retaggio in Terra Santa sono questioni di fede che risalgono alle stesse Scritture». Per Neusner la visione di Schönborn è anche quella del Papa. «Lo Stato d’Israele afferma la rivendicazione del popolo d’Israele sulla terra che Dio ha promesso e ha consegnato loro», spiega a Tempi. «Riconoscendo lo Stato d’Israele e sostenendo gli israeliani nella loro coraggiosa battaglia per la sopravvivenza, il Vaticano sostiene l’imperativo delle Scritture. Ogni altra posizione significherebbe il ripudio della Scrittura, un giudizio che peserebbe su tutti noi».
Tempi 21 Gennaio 2010
Hillesum & Weil giovani donne ebree nell’Europa del nazismo, morte nel ’43. Assetate di soprannaturale in un incandescente confronto con il male
In particolare, il 1943 fu per entrambe – a solo un mese di distanza – l’anno di appuntamento con la morte che nessuna delle due, nonostante la giovane età, voleva mancare, ritenendolo l’esito e il compimento di una vita e non, banalmente, la sua cessazione. Vi arrivarono preparatissme, in virtù di ciò che forse le accomuna più di tutto il resto: l’esperienza spirituale, testimoniata sia dalla vita, sia dalla «conoscenza soprannaturale » che traspare dai loro scritti. In effetti, oltre ai numerosi punti di convergenza che troviamo nelle pagine di ambedue, stupisce la saggezza profonda che le percorre, soprattutto se consideriamo l’età giovanissima delle nostre pensatrici.
Così, se Etty ci ricorda che « quel che conta in definitiva è come si porta, sopporta, e risolve il dolore, e se si riesce a mantenere intatto un pezzetto della propria anima», Simone, altrettanto, ci insegna a non eliminare o fuggire la sofferenza, ma a usarla, piuttosto, in modo soprannaturale. E non è certo secondario il fatto che queste parole provengano da chi si è impegnato a viverle in prima persona nel cuore della sventura – la Hillesum a Westerbork, la Weil in fabbrica.
L’opera di smascheramento dell’immaginazione e della fantasticheria come espedienti alienanti che l’io usa per proiettare se stesso sul mondo, stravolgendone il vero volto e fuggendolo, è un elemento educativo molto importante in questo nostro tempo in cui, invece, ad esse si attribuisce un ruolo centrale ( si pensi all’invadenza del mezzo televisivo); lo stesso si dica per il coraggio di guardare in faccia e accogliere come naturale la sofferenza, in tempi in cui la felicità sembra dover coincidere con la spensieratezza e l’assenza di ostacoli, con la fragilità psicologica che ne deriva.
È, invece, idea condivisa da entrambe le autrici che il dolore, la sofferenza, siano «radice della conoscenza » e debbano trovare il giusto spazio nell’animo, senza che siano mescolati ad altri elementi, come la paura, la rabbia, il rancore, che li rendono – quelli sì – davvero negativi: tutte e due raccomandano di non cedere alla tentazione di lasciarsi degradare dall’odio, perché solo in tal modo ci rendiamo ad esso vulnerabili, dal momento che l’umiliazione di chi è vittima è resa possibile dal suo consenso a farsi umiliare. Così, l’atteggiamento comune di accettazione di tutto il reale, lungi dall’esser manifestazione di una debolezza e passività interiore è, invece, il miglior modo di resistere al male, l’unico per debellarlo senza opporvi la forza e la violenza di cui esso stesso si alimenta – il che equivarrebbe a ri-crearlo.
Esiste, infatti, una specie di meccanismo interiore secondo il quale, quanto più siamo condannati a una totale passività dalle circostanze esterne, tanto più siamo costretti a mobilizzare le nostre forze interiori. È il concetto dell’attività passiva, di cui parlano ambedue, che viene pensato dalla Weil come il raggiungimento dello stato di innocenza-purezza al contatto del quale ciò che è male si dissolve, e dalla Hillesum come un fare che consiste nell’ essere.
Proprio questo lavoro su se stessi è ciò che sia la Hillesum, sia la Weil propongono come unica soluzione al male, giacché esso porta all’acquisizione di uno sguardo nuovo con cui leggere ciò che ci circonda e rapportarsi al mondo.
È lo sguardo di chi non vuole imporre che tutto si svolga secondo i propri desideri e la propria volontà – ormai resa passiva – e che, proprio per questo, sa cogliere nella trama pur contraddittoria della vita quell’armonia profonda che costituisce la sua bellezza misteriosa e la sua bontà sostanziale: in virtù di questo nuovo modo di vedere le cose, il « cieco meccanismo », per dirla con Simone, i «molti misteri del mondo», secondo l’espressione di Etty, non sono forzati in un sistema razionale, ma compresi – nel senso di «presi con sé» –, accettati con umiltà.
Indubbiamente, il tono della lettura weiliana è senz’altro più tragico e meno pacificato di quello della Hillesum – indice, questo, che la comune esperienza spirituale e l’altrettanto comune conoscenza sovrannaturale che ne è derivata portano, comunque, il segno personale di chi l’ha vissuta. Ci si accorge che c’è più scioltezza, più immediatezza, più accettazione nei confronti della componente istintiva dell’uomo nella Hillesum e, viceversa, più spigolosità, maggiore complessità di pensiero e una dif- ficoltà più marcata a rapportarsi con l’aspetto fisico-materiale di sé e del mondo nella Weil.
Le pagine che ci hanno lasciato testimoniano anche, del resto, una vocazione diversa a partire dall’uso del linguaggio: poetico-letterario quello di Etty, filosofico-speculativo quello di Simone.
In ogni caso, i testi delle due autrici sono lì a dimostrare la modificazione profonda che l’esperienza mistica ha operato in loro, un’esperienza che non ha assolutamente nulla a che fare con la sfera sentimentale- emotiva e che non coinvolge affatto l’immaginario (visioni, fenomeni straordinari...), ma tocca quella profondità dell’uomo che è divina, dalla quale soltanto egli può attingere il vero sapere che, proprio perché tale, si trasforma in vita.
Forse – e questo le rende così grandi e attuali – la Hillesum e la Weil hanno incarnato quel «nuovo tipo di santità» che consiste nel «mettere a nudo una larga porzione di verità e di bellezza sino ad ora nascosta sotto uno strato di polvere». Esso si manifesta nel radicamento profondo a questa vita e a questa terra, nella gioia di chi ha trovato la sua propria patria, che nessun uomo o circostanza avversa potrà togliergli, perché essa risiede nel profondo di sé, laddove abita Dio, l’armonia e il senso di tutto.
Israel Zolli: il rabbino di Roma che prese il nome di Eugenio (come Pio XII)

Il mistero svelato di Israel Zolli rabbino che volle farsi cattolico Per la prima volta dagli archivi della comunità ebraica la storia della clamorosa conversione nella Roma del ' 45 ( Corriere della Sera, 3 giugno 2006):
Se avvenisse oggi, in un' epoca di dialogo interreligioso, la conversione di un rabbino al cattolicesimo non farebbe scalpore. Ma oltre sessant' anni fa, nel febbraio 1945, la notizia che Israel Zolli, rabbino capo di una comunità particolarmente segnata dalle persecuzioni naziste come quella romana, si era appena battezzato sollevò discussioni e polemiche destinate a durare decenni, non solo in Italia.
Da parte ebraica, Zolli - che aveva esercitato le sue funzioni fino al giorno precedente la conversione - venne considerato un traditore del suo popolo; da parte cattolica, invece, la scelta dell' ex rabbino, che convertendosi aveva assunto il nome di Eugenio per gratitudine verso un pontefice che aveva aiutato gli ebrei, è stata più volte richiamata in relazione alle polemiche sui presunti silenzi di Pio XII di fronte alla Shoah.
Ma ora tutta la vicenda può essere finalmente esaminata sotto una nuova luce grazie al libro di un giovane studioso, Gabriele Rigano, basato per la prima volta su una documentazione assai ampia e di straordinario interesse. In particolare, l' aver avuto accesso all' archivio dell' Unione delle comunità ebraiche ha consentito all' autore di inserire la vicenda di Zolli nel quadro delle polemiche accesissime che attraversarono negli anni Trenta l' ebraismo italiano. Quando Zolli, rabbino capo di Trieste, venne chiamato a Roma, nel settembre 1939, la persecuzione antiebraica era già all' opera da alcuni mesi (lo stesso rabbino era stato appena privato della cittadinanza italiana che, nato in Galizia, aveva preso nel 1922).
Eppure, in una situazione così grave, la comunità ebraica romana sembrava soprattutto dilaniata dalla lotta tra due correnti, divise perfino sull' atteggiamento da assumere di fronte al regime. Per quanto possa apparire sorprendente, infatti, molti ebrei erano animati da un sentimento patriottico così forte da condurli a difendere (ancora dopo le leggi razziali!) posizioni filofasciste.
Aldo Ascoli, presidente della comunità ebraica romana, nel dicembre 1938 rivendicava la necessità di aderire «con vero cuore alla Patria Fascista» e di collaborare lealmente con uno Stato «diventato grande» grazie al Duce. Fu appunto in questo genere di polemiche che si trovò coinvolto suo malgrado il nuovo rabbino Zolli, che tuttavia riuscì a stabilire rapporti almeno formalmente buoni con i nuovi vertici della comunità, a cominciare dal presidente Ugo Foà, che nel 1940 aveva sostituito il filofascista Ascoli, assumendo una posizione più ferma nei confronti del regime.
Ma tra il settembre e l' ottobre 1943, nei circa trenta giorni che vanno dall' occupazione tedesca della capitale alla razzia del ghetto, si verifica una crisi decisiva nei rapporti tra il rabbino e la comunità. Zolli ritiene infatti che gli ebrei debbano disperdersi, quasi - diremmo oggi - passare alla clandestinità, poiché prevede (giustamente) che quanto è avvenuto altrove in Europa ai loro danni è destinato a verificarsi presto anche a Roma. La sua stessa origine di ebreo galiziano, che ha conosciuto l' antisemitismo violento dell' Europa orientale, oltre che le notizie ricevute direttamente dalla Germania lo inducono a non farsi illusioni sul comportamento dei nazisti.
I vertici della comunità, invece, pensano che sia possibile comportarsi con i tedeschi come si è fatto per cinque anni con il governo fascista, garantendosi una situazione di relativa tranquillità. «Anche le autorità tedesche sono interessate al buon ordine», è la stupefacente opinione di Foà, il quale invita dunque Zolli a non suscitare pericolosi allarmismi. A fine settembre il rabbino prende atto della situazione e decide di rendersi irreperibile. In tal modo si salva da una morte quasi certa (di lì a poco, la sua casa sarà la prima ad essere violata dai tedeschi), ma separa anche il proprio destino da quello della comunità ebraica romana. Il 16 ottobre avviene infatti la razzia del ghetto, seguita dalla deportazione ad Auschwitz di oltre mille ebrei (la gran parte dei quali verrà uccisa il giorno stesso dell' arrivo).
Era dunque inevitabile che dopo la liberazione di Roma del giugno ' 44 i rapporti tra Zolli e la comunità fossero tesissimi: il rabbino, accusato di aver abbandonato il suo posto nel momento del pericolo, imputava a sua volta ai capi dell' ebraismo romano di aver obiettivamente favorito, con la loro passività, la razzia tedesca. Senonché, la destituzione di Zolli venne allora bloccata dall' intervento del governo militare alleato, che decapitò i vertici della comunità nella convinzione (errata) che, essendo stati eletti in epoca fascista, fossero compromessi con il regime.
Da parte di Zolli, la decisione di convertirsi matura in un clima fattosi per lui sempre più pesante. Per alcuni mesi appare effettivamente indeciso: tenta in ogni modo di non perdere il posto di rabbino, ma inizia anche a valutare la prospettiva di diventare cattolico. Come scrive Rigano, «almeno fino al gennaio 1945», dunque fino alla vigilia della conversione, Zolli «non volle chiudersi nessuna via d' uscita». Sembrerebbe dunque inevitabile concludere che tale conversione fosse dovuta in buona misura a considerazioni pratiche, legate all' ostilità nei suoi confronti diffusa nell' ebraismo romano.
E tuttavia dalla ricerca di Rigano emerge che, se un tale scontro fece precipitare la decisione, questa era anche il risultato di una lunga maturazione, a partire dal modo in cui Zolli aveva sempre considerato l' ebraismo e l' esperienza religiosa in generale. Nelle sue memorie, pubblicate negli Stati Uniti nel 1954, Zolli assegnò una funzione essenziale alla visione di Cristo avuta proprio durante la celebrazione dello Yom Kippur, nel settembre 1944. Tuttavia l' episodio, pur continuamente citato dalla letteratura di parte cattolica, andrebbe considerato, secondo Rigano, come frutto di una successiva reinterpretazione personale: non a caso compare nella traduzione inglese, mentre è assente nella versione originale delle memorie, scritta in italiano e rimasta inedita fino a pochi anni fa.
Ma effettivamente la figura di Cristo aveva sempre esercitato su Zolli un fascino notevole, ben prima che si affacciasse la possibilità di una conversione, che va probabilmente spiegata (nei limiti, ovviamente, in cui è lecito tentare di spiegare decisioni del genere) in relazione a una concezione della religione fortemente caratterizzata in senso mistico, con la propensione a sottolineare le «grandi somiglianze» esistenti tra i vari sistemi religiosi. A giudizio di Rigano ci troveremmo dunque di fronte a un' esistenza liminare tra ebraismo e cristianesimo, a uno spirito religioso che tendeva a dare un' importanza relativa agli apparati dogmatici e alle divisioni di fede.
Del resto Zolli, come aveva dedicato da ebreo alcuni studi importanti alla figura di Cristo, continuò a manifestare da cattolico «una passione affettuosa» per il popolo di Israele. Tanto che nel febbraio 1945, subito dopo la conversione, ricevuto da Pio XII, gli domandò se fosse possibile eliminare, nella liturgia del Venerdì Santo, l' aggettivo «perfidi» attribuito ai giudei (che però in latino significava letteralemnte: che non hanno la vera fede,ndr).
Quasi che, essendo diventato cattolico, non avesse cessato d' essere e di sentirsi, almeno in parte, anche ebreo. il saggio Il saggio di Gabriele Rigano «Il caso Zolli. L' itinerario di un intellettuale in bilico tra fedi, culture e nazioni» (pagine 434, 29,50) è edito da Guerini e Associati Israel Zolli (1881-1956) fu rabbino capo di Roma e si convertì al cattolicesimo. Le sue memorie, intitolate «Prima dell' alba», sono edite in Italia dalla San Paolo, che su Zolli ha pubblicato anche il libro di Judith Cabaud «Il rabbino che si arrese a Cristo».
Inoltre:
Di lui si è parlato per oltre mezzo secolo. L'evocare il suo nome significa ancora oggi creare imbarazzo, sdegno, scandalo. La sua autobiografia, Before the Dawn ("Prima dell'alba") splendido racconto di una conversione, non è mai stata pubblicata in Italia, nonostante il protagonista abbia vissuto nel nostro Paese la maggior parte della sua vita. Israel Zoller, italianizzato Italo Zolli, il rabbino capo di Roma che nel 1944 decise di chiedere alla Chiesa cattolica il battesimo - prendendo il nome di Eugenio in onore di Pio XII - perché era "arrivato" all'incontro decisivo con il Messia delle Sacre Scritture, è un personaggio cancellato dalla memoria della comunità ebraica e dimenticato dai cristiani.
Eppure, proprio nella storia di un grande studioso che disse di non aver rinnegato nulla del suo passato d'israelita ma soltanto di aver portato a compimento un percorso che dall'Antico Testamento porta a Cristo, è possibile ritrovare un originale spunto per una maggiore reciproca conoscenza tra cattolici ed ebrei.
È stata un'altra ebrea convertita, Judith Cabaud, a pubblicare la prima biografia di Zolli, tradotta in italiano dalla San Paolo (Il rabbino che si arrese a Cristo). Zolli era nato a Brodi, in Galizia nel settembre 1881, da una famiglia rabbinica benestante che perse poco dopo le sue ricchezze, confiscate dalla Russia zarista.
Fin da piccolo, Israel rimane colpito dalla figura di Gesù. Lo aveva visto la prima volta appeso a un muro, nella casa di un compagno di scuola e aveva chiesto: "Chi è quell'uomo crocifisso come un criminale?". Trasferitosi in Italia ai primi del Novecento, ottiene la laurea in Filosofia e diventa vice-rabbino e quindi rabbino capo di Trieste.
Nel 1938 pubblica un libro intitolato Il Nazareno, dedicato alla figura di Gesù. Nel volume, frutto di studi approfonditi, Israel non nasconde la sua crescente ammirazione per Cristo e arriva a scrivere che il Nazareno è colui che era stato annunciato da Isaia. Il rabbino si è dunque già convinto che il cristianesimo sia la continuazione e il compimento dell'ebraismo. in Europa, in quel periodo, il libro di Zolli passa inosservato: sono ben altre le preoccupazioni della comunità ebraica alla vigilia dello scoppio della seconda guerra mondiale, quando gli israeliti sono già da tempo vittime della barbara persecuzione nazista. Israel non intende compiere il passo definitivo in un momento così grave, non vuole che si possa neanche lontanamente pensare che lascia la religione dei suoi padri per aver salva la vita.
Nel 1940 gli viene offerto l'incarico di rabbino capo di Roma, cioè della più importante ed antica comunità ebraica della diaspora. La scelta cade su di lui non soltanto perché è uno studioso di grande valore, ma anche perché, dal punto di vista politico, è assolutamente al di sopra delle parti. Da anni, lui che conosceva il tedesco e aveva letto le farneticanti opere hitleriane in lingua originale, andava gridando la sua preoccupazione per la sorte degli ebrei. Molti dei capi della comunità romana, invece, sono collaboratori leali del governo fascista, e si credono fuori pericolo.
Dopo l'occupazione di Roma da parte dei tedeschi, l'8 settembre 1943, a nulla servono gli avvertimenti di Zolli, che invita i suoi correligionari a darsi alla macchia, e vorrebbe chiudere la Sinagoga, far sparire gli elenchi con i nomi degli israeliti. Il presidente della comunità, Ugo Foà, non gli dà ascolto, ma anzi lo accusano di essere un codardo. Quando la Gestapo mette una forte taglia sulla sua testa - il rabbino era il primo ad essere catturato e ucciso quando i nazisti mettevano le mani su una città - Zolli si rifugia in casa di amici cristiani, ma lascia il recapito di un intermediario e dunque può essere rintracciato in ogni momento dai membri della comunità.
Quando il colonnello Herbert Kappler chiede agli ebrei un riscatto di cinquanta chili d'oro per risparmiare loro la deportazione, Israel Zolli va personalmente in Vaticano a chiedere aiuto. Il Papa Pio XII dispone che l'oro mancante venga messo a disposizione, ma non servirà, dato che i romani hanno risposto generosamente all'appello e la comunità ebraica è riuscita da sola a mettere insieme il prezioso metallo. Il riscatto non servirà purtroppo ad evitare il terribile rastrellamento dei Ghetto di Roma, che avviene il 16 ottobre.
I capi della comunità che deridevano Zolli sono costretti a fuggire, oltre duemila saranno deportati, quasi tutti non faranno mai ritorno dai lager nazisti. Alla fine della guerra, gli Alleati richiamano Zolli come rabbino capo: non è mai stato un collaborazionista, ma si rifiuta di accusare i suoi correligionari di fronte alle autorità americane.
Nel settembre 1944, durante la festa dello Yom Kippur nella Sinagoga di Roma, il rabbino ha una visione. Gesù gli appare e gli dice che quella sarebbe stata l'ultima volta che celebrava in quel luogo. Il 13 febbraio 1945, in gran segreto, riceve il battesimo, seguito nei mesi successivi dalla moglie e dalla figlia. Sceglie il nome di Eugenio, perché, spiega "L’ebraismo mondiale ha un debito di grande gratitudine verso Pio XII". Gli ebrei fanno di tutto per dissuaderlo: gli vengono offerte dagli Usa cifre esorbitanti di denaro. Sarà da allora dipinto come un "serpente", un "traditore". Per anni lui e la sua famiglia, che vivrà in assoluta povertà, sarà oggetto di ingiurie, al punto da vedersi costretto a rifugiarsi nell'università dei Gesuiti. Eugenio Zolli, l’"arrivato", morirà nel marzo 1956.
Ricorda: "Gesù che avrebbe potuto convertire le pietre in pane, digiuna per quaranta giorni nel deserto; egli che avrebbe potuto chiamare in sua difesa intere legioni di angeli, comanda a Pietro di rinfoderare la spada con cui ha tagliato l'orecchio di Malco; ma egli ridona la vista ai ciechi, monda i lebbrosi, risuscita i morti; egli combatte contro un nemico solo: il male; e i nemici vanno perdonati e fatti oggetto di preghiere al Padre". (Eugenio Zolli, L'Ebraismo, Editrice Studium, Roma 1953, p. 57).
Bibliografia
Judth Cabaud, Il rabbino che s'arrese a Cristo, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo 2002. Eugenio Zolli, Before the dawn, riflessioni autobiografiche, Sheed and Ward, New York 1954. Eugenio Zolli, Christus, Edizioni AVE, Roma 1946.
Eugenio Zolli, L'Ebraismo, Editrice Studium, Roma 1953.
IL PAPA VISTO DAL RABBINO. Le radici giudaico-cristiane nell’incontro tra due professori. Quattro giorni con Jacob Neusner a Roma
Sono stato in compagnia di Jacob
Neusner in questo tranquillo
weekend romano di dicembre senza
pioggia, ed è stata un’esperienza singolare
che vorrei augurare a tutti noi
italiani dagli occhi pigri e impolverati.
Ho capito infatti quello che intende
Tolkien quando scrive che “Dovremmo
guardare ancora il verde, ed essere
nuovamente stupiti […] riguadagnare,
un ritrovare una visione chiara.
Dobbiamo, in ogni caso, pulire le nostre
finestre, in modo che le cose viste
con chiarezza possano essere liberate
dalla tediosa opacità del banale o del
familiare”. Per un romano niente di
più familiare del Papa. Anche quando
è di un paese lontano, il Papa è sempre
trasteverino. E se è bello che il
Papa sia qualcuno di familiare, può
essere un rischio se diventa banale, se
le nostre finestre si opacizzano e s’incrostano
di pregiudizi. Per fortuna,
sempre secondo Tolkien, c’è “l’umiltà.
E c’è, soprattutto per gli umili, Mooreeffoc,
vale a dire la fantasia chestertoniana.
Mooreeffoc è una parola immaginaria,
ma la si può trovare bell’e
scritta in ogni villaggio del nostro paese.
E’ infatti l’insegna di un Coffeeroom,
un caffé, vista dall’interno, attraverso
una porta vetrata, come è stata
vista da Dickens in una buia giornata
londinese; e Chesterton se ne è servito
per designare la bizzarria di cose
che sono divenute ovvie, quando le si
scorga, all’improvviso, da un altro
punto di vista”. Jacob Neusner è venuto
qui in Italia per rispolverare occhi
e pulire qualche finestra.
Lo avevo conosciuto solo via mail,
nel maggio del 2007, per intervistarlo
per il Foglio sul libro del Papa che lo
aveva chiamato in causa dedicandogli
diverse pagine a commento del Discorso
della Montagna. Ora è venuto
qui a Roma proprio a esporre il suo
commento a quello che è il più famoso
di tutti i discorsi in un dialogo pubblico
con monsignor Bruno Forte che
si è svolto lunedì sera all’Auditorium
di Roma in occasione della presentazione
del libro Imago Christi realizzato
dalla Fondazione Marilena Ferrari-
FMR. Era stata proprio la Fondazione
a chiedermi di invitare Jacob
Neusner per un confronto sul testo
dei capitoli 5-7 del Vangelo secondo
Matteo e non c’era scelta più indovinata:
già nel 1993 Neusner aveva
scritto un saggio “A Rabbi talks with
Jesus” (poi pubblicato dalla San Paolo
nel 2007) in cui il rabbino immaginava
di essere lì, sulla montagna ad
ascoltare le ipsissima verba Christi
per la prima volta, sforzandosi di eliminare
quel bimillenario accumulo
di giudizi e pregiudizi, commenti,
comprensioni e precomprensioni che
si era creato su quel testo. Lo sforzo
era piaciuto tanto all’allora cardinale
prefetto della Dottrina della Fede Joseph
Ratzinger (“Questa disputa mi
ha aperto gli occhi sulla grandezza
della parola di Gesù”) al punto che
quindici anni dopo, una volta diventato
Papa, ha inteso ripercorrere sul
suo libro su Gesù di Nazareth quel
lungo dialogo a distanza con l’amico
rabbino americano. La cosa mi colpì
anche perché mi era stata sottolineata
dall’amico Elio Guerriero, curatore
dell’edizione italiana del volume
papale: “Lo spazio dedicato al rabbino
Neusner è davvero sorprendente,
segnale di una precisa volontà, un
grande passo in avanti nel dialogo
con gli Ebrei”. E così feci la cosa più
semplice da fare: navigai su Internet
e in pochi secondi trovai l’indirizzo
mail di Neusner che intervistai. Al
termine della lunga chiacchierata via
mail eravamo amici: il rabbino, che
rispondeva subito, laconicamente ma
con una prontezza commovente e sorprendente
per i miei tempi italicamente
pigri, mi disse che mi poteva
chiamare Jacobbo, che per lui è l’equivalente
italiano di Jacob (ma ora
ha capito lo spelling esatto e quando
mi ha fatto l’autografo sul suo libro ha
scritto correttamente Giacomo).
Il mio amico Giacomo mi ha infatti
regalato un libro, l’edizione italiana
della sua introduzione al Talmud di
cui è uno dei massimi esperti al mondo
(il suo sito universitario elenca più
di 800 pubblicazioni sulla tradizione
rabbinica) e mi ha anche fatto dono di
un detto del Talmud che lui ha scelto
come stile di vita: “Say little but do
much: dire poco ma fare molto”. Gli
ho citato il detto italiano “chi fa non
parla, chi parla non fa” e se n’è rallegrato,
non solo perché capisce molto
bene l’italiano, nonostante gli anni e
gli acciacchi si facciano sentire, ma
anche perché sente profondamente la
vicinanza tra l’Italia e l’America. “Roma
mi ricorda New York”, mi dice
mentre passeggiamo nei pressi di Villa
Borghese, “è un centro vitale, pulsante,
e ricco di bellezza”. Ma la vicinanza
che a lui sta a cuore è un’altra:
“Il Talmud è un testo che si riferisce
alla tradizione orale del giudaismo.
Oltre alla parte scritta, la Torah, noi
ebrei diamo molta importanza alla
parte orale, al Talmud. Proprio come
nella chiesa cattolica dove c’è non solo
la Scrittura ma anche la Tradizione.
Ecco un’altra cosa che ci accomuna”.
Gli chiedo ancora del Talmud, dire
che ne è affascinato non renderebbe
l’idea, e mi spiega che è un libro frutto
dello studio di generazioni di rabbini,
quasi uno studio sul concetto di
studio. E’ una cosa fondamentale per
Neusner lo studio e mi cita Elie Wiesel
che nel saggio Celebrazione talmudica
afferma: “Lo studio significa opporsi
alla morte; e a ciò che vi è di
peggio della morte: all’oblio”. Gli comincio
a parlare di Benedetto XVI
che già nel suo primo viaggio apostolico,
a Colonia nel 2005, andò a visitare
una sinagoga tedesca e parlò ai giovani
del mondo contemporaneo affetto
da “una strana dimenticanza di Dio” e
lui si mostra in perfetta sintonia: “Oggi
si vive nell’oblio. Ciò che manca è lo
studio della storia. Penso alla questione
delle radici cristiane. Forse è sempre
stato un po’ così… mi viene in
mente che per i giovani americani di
oggi parlare della guerra del Vietnam
è come quando a me parlavano della
Prima guerra mondiale, un passato
che non mi apparteneva”. Ma Neusner
non dispera, si dichiara felice di
essere nato americano (da una famiglia
proveniente da Odessa) perché,
dice, “ho speranza nel popolo americano
in quanto è un popolo capace di
autocritica. Siamo patriottici nel senso
profondo e buono del termine”. Gli
chiedo quali siano i rapporti negli Stati
Uniti tra ebrei e cristiani e la risposta
è lapidaria: “Ottimi. Soprattutto
nei piccoli centri c’è un bellissimo
rapporto tra cristiani ed ebrei. Io ho
tanti amici cristiani e cattolici, penso
a monsignor John Favalora, arcivescovo
di Miami, e al professore Andrew
Greley di Chicago. Ma anche qui in
Italia, come gli amici della Comunità
di Sant’Egidio. Ricordo quando mi invitarono
negli anni Novanta a Milano
dove incontrai il rabbino Giuseppe
Laras che era amico dell’allora arcivescovo
della città”. Neusner stesso è
un crocevia vivente del rapporto tra
ebrei e cristiani: a 78 anni ancora insegna
e nel semestre primaverile tiene
un corso, alla Bard University, di
studi comparativi sulla dottrina sociale
secondo il giudaismo e il cristianesimo
classico, da Paolo a Ireneo, da
Origene ad Agostino. Ancora più lapidaria
è la risposta alla mia domanda,
forse troppo candida, sul perché si sia
tanto interessato al cristianesimo:
“Perché è la religione che ha conquistato
il mondo ed è il futuro del mondo,
perché si erge a difesa della vita
contro la morte”.
Tre sono stati i momenti forti di
questi quattro giorni romani di Neusner:
la partecipazione alla visita del
Papa in sinagoga, l’udienza privata
del Papa riservata a lui e alla moglie
Suzanne e il dialogo all’Auditorium
con monsignor Forte sul Discorso della
Montagna. Sul primo Neusner è stato
chiaro: “Un incredibile evento di
partecipazione, con ogni posto a sedere
occupato, sono stato davvero felice
di parteciparvi, un buon segno per il
dialogo religioso”. Sul secondo si dilunga
invece molto di più, parliamo “a
caldo” (l’ho accompagnato io in Vaticano),
cioè a visita appena avvenuta, e
il racconto che ne fanno i coniugi
Neusner vale la pena di riportarlo per
intero: “Siamo arrivati al Cortile San
Damaso alle 11,15 e abbiamo aspettato
a lungo per essere ricevuti, il Papa
infatti era in ritardo sugli appuntamenti.
Ci hanno fatto accomodare in
una stanza, molto bella in verità, poi ci
hanno chiesto di spostarci in un’altra
ancora più bella, poi in un’altra ancora…
insomma, abbiamo visitato cinque
diverse stanze, tutte splendide, e
in ognuna entrava qualcuno che ci
chiedeva scusa a nome del Papa; persone
gentilissime che parlavano ognuna
una lingua diversa, noi ce la siamo
cavata con l’inglese. Nessuno però ci
ha mai indicato dove fosse la toilette,
mi ha colpito, quando siamo stati ricevuti
alla Casa Bianca più volte ci hanno
chiesto se avevamo bisogno del bagno,
ma si sa, noi americani siamo
gente più pratica. Finalmente entriamo
nello studio del Papa (ma quant’è
grande, lo studio!) ed eravamo veramente
elettrizzati. Lui è stato gentilissimo
e ci ha messo a nostro agio. Eravamo
solo noi tre e siamo rimasti soli
per quindici minuti, il tempo sufficiente
direi, per due professori. Conoscevo
da tanti anni lo studioso e lo stimavo,
ora ero molto interessato a incontrare
e conoscere l’uomo. E Ratzinger
è un uomo umile, gentile. Non
sente l’urgenza di riempire il silenzio
tra una parola e l’altra, si mette in
ascolto. Inoltre ha ancora la sana curiosità
dello studioso, non l’ha messa
da parte. Mi ha chiesto dei miei studenti,
gli ho detto che li adoro e lui ha
sorriso, ha capito cosa intendevo con
quell’espressione. La cosa che più mi
ha colpito sono stati i suoi occhi penetranti,
capace di attraversarti”. Mentre
Neusner parla mi viene in mente
l’espressione che usa Pier Paolo Pasolini
nel suo libro sull’India quando
parla di Madre Teresa di Calcutta:
“Quando guarda, vede” e poi la Deus
Caritas est che al punto n. 31 afferma:
“Il programma del cristiano è un cuore
che vede”. Neusner continua su
questo aspetto degli occhi e della visione.
“Ratzinger è un uomo che ha
una visione: per l’Europa, per il mondo,
per l’umanità, per la vita (e contro
la morte). Nessun altro oggi sembra
avere una visione, anche la politica un
po’ dovunque è in crisi. Quest’uomo
gentile sa dove vuole andare”. Gli
chiedo se hanno parlato di politica,
nega recisamente: “Non abbiamo parlato
di politica”. E dell’incontro di ieri
in sinagoga? Niente. E di che cosa
avete discusso? “Abbiamo parlato dei
nostri libri, come si fa tra professori.
Io gli ho regalato due libri, l’edizione
italiana del mio saggio sul Talmud e
l’edizione tedesca di “Un rabbino parla
con Gesù” e lui lo ha molto gradito
perché l’aveva letto in inglese (lingua
che conosce e pronuncia in modo eccellente)
e anche perché, ha detto,
‘non sono libri molto lunghi… così li
potrò leggere’, ha soggiunto quasi sospirando
e mi ha parlato del suo nuovo
libro, il secondo volume su Gesù di
Nazareth che ha da poco finito e che
uscirà tra sei mesi. Gli ho chiesto se
aveva in mente di scrivere altri libri
ma la risposta (che sembra rivelare il
suo desiderio reale) è stata piuttosto
negativa: “Ho 83 anni, altre cose da fare”.
Al che ho desistito dal mio intento,
quello di proporgli di scrivere un
libro insieme”. L’ho lasciato parlare,
finire di raccontare questo strano incontro
tra due vecchi professori che
ora si trovano di nuovo a migliaia di
chilometri di distanza e, pur essendosi
incontrati per soli quindici minuti,
forse sono un po’ meno soli.
Il terzo momento è stato lunedì sera
all’Auditorium, il dialogo pubblico
tra lui e S. E. monsignor Forte. Avevamo
pranzato insieme con Neusner e
mi aveva detto che aveva letto e apprezzato
il testo che l’arcivescovo di
Chieti avrebbe letto apparso sul Sole
24 Ore (il rabbino legge e parla correttamente
l’italiano). Il rischio a questo
punto era, per dirla con Bernanos, che
l’incontro tra il teologo cattolico e il
rabbino ebreo fosse una conversazione
all’insegna del miele piuttosto che
un dibattito con la giusta dose di sale,
ma il rischio è stato scongiurato grazie
soprattutto alla sincerità dei due interlocutori
che sono rimasti amabilmente
in disaccordo. “Un vero maestro
non è chi dice qualcosa di nuovo,
ma chi dice qualcosa di vero”, ha affermato
Neusner, e monsignor Forte
ha apprezzato la franchezza aggiungendo
che: “La novità del messaggio
di Cristo non sta nel messaggio ma nel
messaggero”. “Chi si dichiara Signore
del Sabato si pone fuori e al di sopra
della Torah”, ha ribadito il rabbino,
ma “il Discorso della Montagna non è
una legge che si contrappone alla legge
mosaica”, ha concluso il teologo (citando
il protestante Jeremias), “bensì
un Vangelo, la buona notizia sull’amore
di Dio che si incarna per salvare gli
uomini”. Un confronto vero contrassegnato
dalle rotondità delle arcate dei
discorsi di Forte e dalle secche e rapide
risposte di Neusner.
E laconico è stato anche in auto
mentre ritornava in albergo, quando
ho pensato di provocarlo chiedendogli
di Pio XII: “Ora è troppo presto per
giudicare. Certo mi sembra che ci siano
degli attacchi contro il dialogo tra
noi e la chiesa da persone che disonestamente
non hanno alcun interesse
nemmeno nella causa del giudaismo”,
ma non ha voluto aggiungere di più.
Gli ricordo la posizione di un ebreo
italiano come Paolo Mieli, che ha più
volte affermato di aver apprezzato
molto di più gli interventi reali e concreti
della chiesa che ha salvato tante
vite umane, rispetto all’ipotetico discorso
pubblico di denuncia da parte
del Papa. Neusner mi ha guardato e
mi ha risposto ancora una volta laconicamente:
“Say little but do much”.
Alla fine di questo intenso weekend
con un anziano rabbino in giro per
Roma, con il suo fare un po’ stravagante,
teso più a osservare che a parlare,
posso dire che proprio il suo essere e
venire “da fuori” mi ha aiutato a ripulire
le mie finestre e a vedere una cosa
così vicina, come il Papa, da un’altra
prospettiva. E se invece penso al
mio amico Jacob-Giacomo, che ora è
in viaggio per New York, mi viene subito
in mente quello che Gesù disse
del baldanzoso apostolo Natanaele,
quello che lo sfotteva sulle sue origini
di Nazareth: “Ecco un israelita senza
falsità!” (Gv 1,47).
Chi è Jacob Neusner, il rabbino amico di Benedetto XVI che parla con Gesù
Roma. L’altro ieri, all’indomani della partecipazione
alla visita del Papa alla Sinagoga di Roma e
qualche ora prima di un dialogo pubblico tenuto all’Auditorium
con l’arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno
Forte, il grande biblista ebreo americano Jacob
Neusner è stato ricevuto in Vaticano da Benedetto
XVI. Un’udienza che suggella una particolare amicizia:
i due, che già si erano incontrati personalmente
in occasione della visita del Papa alla sinagoga di
New York dell’aprile 2008, hanno infatti coltivato
per anni un intenso rapporto epistolare. La cosa è
stata rivelata anche dal Papa nel quarto capitolo del
suo “Gesù di Nazaret” dove egli descrive Neusner
così: “Un ebreo osservante e rabbino, cresciuto in
amicizia con cattolici ed evangelici, insegna all’università
insieme con teologi cristiani e nutre un
profondo rispetto nei confronti della fede dei suoi
colleghi cristiani, ma resta saldamente convinto della
validità dell’interpretazione ebraica delle Sacre
Scritture”. Secondo Ratzinger, sono stati “il profondo
rispetto verso la fede cristiana e la sua fedeltà al
giudaismo” che hanno indotto Neusner a cercare il
dialogo con Gesù”.
Nato a Hartford nel Connecticut nel ’32, sposato e
padre di quattro figli, Neusner è un rabbino culturalmente
influente quanto raffinato, tra i massimi
esperti delle Sacre Scritture ebree: a oltre novecento
ammontano le sue pubblicazioni su Torah, Mishnah,
Talmud e sui Midrash. Ha insegnato in diverse
università americane (Columbia, Wisconsin, Dartmouth)
e dal ’94 insegna Storia e teologia del giudaismo
al Bard College di New York. Ma la grande notorietà
di cui gode gli è arrivata proprio con la pagina
129 del saggio di Benedetto XVI su Gesù di Nazaret.
Qui il Papa riconosce il “grande aiuto” che ha
ricevuto dalla lettura del libro del rabbino.
Il Papa parla di Neusner quando esamina i tre
capitoli del vangelo di Matteo, dal quinto al settimo,
che raccolgono il Discorso della montagna, che per
i cristiani è “la nuova Torah, portata da Gesù” dopo
quella consegnata al popolo di Israele da Mosè. Qui
entra in scena Neusner con il suo libro “Un rabbino
parla con Gesù”. Neusner, scrive il Papa, “si è,
per così dire, inserito tra gli ascoltatori del Discorso
della montagna e ha poi cercato di avviare un colloquio
con Gesu”. E ancora: “Questa disputa, condotta
con rispetto e franchezza fra un ebreo credente
e Gesù, il figlio di Abramo, più delle altre interpretazioni
del Discorso della montagna a me note,
mi ha aperto gli occhi sulla grandezza della parola
di Gesù e sulla scelta di fronte alla quale ci pone il
Vangelo. Così desidero entrare anch’io, da cristiano,
nella conversazione del rabbino con Gesù, per comprendere
meglio, partendo da essa, ciò che è autenticamente
ebraico e ciò che costituisce il mistero di
Gesù”. Papa Ratzinger – ha ricordato il cardinale
Christoph Schönborn presentando nel 2007 il libro
in Vaticano – definì il libro del rabbino Neusner come
“il saggio di gran lunga più importante per il
dialogo ebraico-cristiano che sia stato pubblicato
nell’ultimo decennio”. Perché? “Perché egli oppone
un netto rifiuto a tutti i tentativi di scindere il Gesù
storico dal Gesù del dogma della chiesa. (pr)
Il Foglio 19 gennaio 2010