DISCERNERE
Uno sguardo profetico sugli eventi
TERRA SANTA. DA GENNAIO 2020 TORNERA' VISITABILE IL LUOGO DEL BATTESIMO DI GESU'
Le levatrici d'Egitto: puro dono è la dote della terra
IsrPer capire e rivivere, qui ed ora, il grande messaggio delle “dieci parole” donate da Elohim-YHWH, ci sarebbe bisogno di una cultura dell’alleanza, di una civiltà delle promesse fedeli, capace di patti, che riconosca il valore del “per sempre”. Una grande nota del nostro tempo è invece la trasformazione di tutti i patti in contratti, una nota che risuona sempre più forte fino a coprire tutti gli altri suoni del concerto della vita in comune. Lo vediamo con estrema nitidezza nell’ambito dei rapporti familiari, ma anche nel mondo del lavoro, dove le relazioni lavorative che nel XX secolo erano state concepite e descritte ricorrendo al registro relazionale del patto, oggi si stanno sempre più appiattendo sul solo contratto. Come se la moneta potesse compensare sogni, progetti, attese, la fioritura umana, soprattutto quella dei giovani. Stiamo smarrendo il principio alla base di ogni civiltà capace di futuro: che ai giovani va dato credito, va donata fiducia quando ancora non la meritano perché non la possono meritare. Credito e fiducia ricevuti, che domani potranno e dovranno a loro volta ridonare ai nuovi giovani. Il lavoro cresce e vive in questa amicizia e solidarietà attraverso il tempo, si nutre di questa reciprocità intertemporale. Senza questa staffetta generosa tra generazioni, il lavoro non nasce o nasce male, perché gli manca l’humus della gratuità e dei patti. Ma non lo capiamo più, e così ci stiamo perdendo. Forse avremmo bisogno di rivedere la nube e il fuoco, riudire il tuono dell’Oreb; avremmo bisogno dei profeti, dei loro occhi, della loro voce.
Mentre Mosè ascolta le dieci parole dentro la nube del Sinai, il popolo “vede” i segni della presenza di Dio, e ha paura: «Allora dissero a Mosè: “Parla tu a noi e noi ascolteremo; ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo!”». (Esodo 20,19). E Mosè: «Non abbiate paura» (20,20).
Ritornano qui, alle pendici del monte, quelle stesse parole – «non abbiate paura» – che aveva pronunciato nei pressi del Mare, quando il popolo si sentiva schiacciato tra gli egiziani e il muro delle acque (14,13). I profeti sono necessari sempre, ma sono indispensabili nei tempi delle paure collettive.
Fuori dall’Egitto, il popolo si sta abituando un po’ alla volta all’idea di un Elohim diverso, che lo ha liberato dalla schiavitù, che lo ama ed è misericordioso. Ma il processo è lungo e difficile, perché l’esperienza religiosa dell’uomo antico, inclusa quella dei popoli circostanti Israele, è primariamente quella della paura, del timore, della colpa.
Occorre sacrificare agli dei gli animali migliori e offrire loro le primizie perché plachino la loro ira e siano benigni. YHWH sta offrendo al suo popolo un’altra esperienza religiosa, un altro “timore di Dio” (20,20), che da paura delle divinità diventa sempre più “timore di uscire dall’alleanza con YHWH”. La rivelazione di un altro volto di Dio è stata un processo lento e accidentato, che si è svolta nel tempo e nello spazio concreti.
Questa dimensione storica e geografica della Torah emerge con grande forza e chiarezza nel cosiddetto “Codice dell’Alleanza”, quella lunga e mirabile raccolta di norme, raccomandazioni, leggi, una sorta di commento, di applicazione e concretizzazione del decalogo. In questi capitoli dell’Esodo si sente l’eco (a tratti nitidissima) delle leggi dei popoli semitici, del codice di Hammurabi, e della grande sapienza popolare maturata nel dolore e nell’amore della gente lungo i secoli e i millenni. Quel popolo dal Dio diverso, l’Elohim che parla e non si vede, volle porre quelle parole di sapienza-dolore-amore a corredo delle dieci parole di YWHW, donando loro una dignità altissima. Volle con quelle parole terrestri rispondere al dono delle parole celesti. È la dote della terra, il dono per le nozze dell’Alleanza, la risposta al dono della Legge. L’Alleanza è reciprocità anche perché è un dialogo tra cielo e terra, dove le parole inedite e nuove che squarciano la nube si incontrano con le parole terrestri fiorite dalle ferite amate della storia dell’Adam, creato a immagine della voce che aveva detto le dieci parole. L’Esodo ci dice allora che l’asino sfiancato dal peso, il bue che cozza e uccide, il feto della donna schiava, la festa del raccolto, possono stare vicino al «Non uccidere» e al «Non ti farai idoli». Tutta parola che salva e libera. Sta qui, in questo impasto di parole di cielo con parole di terra, il cuore dell’umanesimo biblico.
Incastonate in questo grande “Codice dell’Alleanza”, si trovano delle autentiche perle eterne di civiltà, che devono arrivare dentro i nostri giorni, per cambiarli o quantomeno scuoterli, per mandare in crisi le nostre certezze. «Quando tu avrai acquistato uno schiavo ebreo, egli ti servirà per sei anni e nel settimo potrà andarsene libero, senza riscatto» (21,2). Anche in Israele c’erano gli schiavi (sebbene, in modo significativo, solo dopo la monarchia). Anche nel popolo di un Dio che si presenta sul Sinai come liberatore dalla schiavitù, che è l’anti-idolo perché nemico delle schiavitù, esistevano schiavi. È uno dei paradossi dell’incarnazione della parola nella storia, che però ci dice molte cose. Questi schiavi erano persone “acquistate” (qnh, è un verbo usato per gli acquisti in moneta), dei debitori insolventi che perdevano la libertà perché non riuscivano a restituire i prestiti ricevuti. E con loro spesso finivano schiavi anche moglie, figli, e soprattutto figlie (21,3–5).
Questa forma di schiavitù per debiti è ancora ben presente e in crescita nel nostro capitalismo, dove imprenditori, cittadini, quasi sempre poveri, precipitano nella condizione di schiavo solo perché non riescono a ripagare i debiti. E così perdono, ancora oggi, la libertà, la casa, i beni, la dignità, e non di rado anche la vita. Tra gli schiavi per debiti ci sono senz’altro, ieri e oggi, sprovveduti, speculatori maldestri, creduloni; ma ci sono anche imprenditori, lavoratori e cittadini giusti caduti semplicemente in sventura – la Bibbia ci ricorda, basterebbe pensare a Giobbe, che anche il giusto può cadere in sventura, senza nessuna colpa: non tutti i debitori insolventi sono colpevoli. Persone ridotte in condizione di schiavitù non solo dalle mafie e dagli usurai, ma anche da società finanziarie e banche protette dalle nostre “leggi” scritte troppo spesso dai potenti contro i deboli. Ma noi, diversamente dal popolo del Sinai, non riusciamo a chiamare per nome (”schiavi”) questi sventurati, e nessuna legge li libera alla scadenza del settimo anno.
Eppure quella antica Legge continua a ripeterci da millenni che nessuna schiavitù deve essere per sempre, perché prima di essere debitori siamo abitanti della stessa terra, siamo figli dello stesso cielo, e quindi, veramente, fratelli e sorelle. Perché la ricchezza che possediamo, e che prestiamo ad un altro, prima di essere nostra proprietà privata è dono ricevuto, è provvidenza, perché «mia è tutta la terra» (19,5). Il riconoscimento che la ricchezza e la terra che possediamo non sono dominio assoluto perché prima sono dono, ispira tutta la legislazione biblica sul denaro e sui beni. Quando, invece, noi oggi pensiamo che la nostra ricchezza sia solo conquista individuale e merito, allora i debiti non vengono mai rimessi, gli schiavi non vengono liberati mai, la giustizia diventa filantropia. Il dominio assoluto dell’individuo sulle sue cose è invenzione tipica della nostra civiltà, ma non è la logica del Sinai, non è la legge vera della vita.
Dentro questa grande cornice vanno lette anche le parole del Codice dell’alleanza sui doveri verso il nemico, il divieto di chiedere gli interessi sul denaro all’indigente, la legge del mantello: «Quando vedrai l’asino di colui che ti odia accasciarsi sotto il carico, astieniti dal rimuoverlo solo per la bestia, ma lo devi rimuovere insieme a colui che ti odia» (23,5). Non è sufficiente sollevare l’asino accasciato per pietà verso la povera bestia: quell’incidente deve diventare occasione per la riconciliazione con il fratello-nemico che ti odia. Nessun nemico cessa di essere fratello, e il dolore dell’umile asino deve diventare via di ricomposizione della fraternità spezzata.
«Se tu presti al mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai da creditore, non imporrai su di lui interesse alcuno» (22,24). All’indigente non si presta a scopo di lucro, non si specula sulle povertà. E invece nel sistema economico che abbiamo costruito fuori dall’Alleanza, sono soprattutto i poveri, non i ricchi né i potenti, ad essere ridotti in schiavitù da interessi sbagliati e insostenibili. E il povero continua a gridare. «Se veramente prendi in prestito in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderei al tramonto del sole, perché è la sua sola coperta, è il mantello della sua pelle, con che cosa potrebbe dormire? Avverrà che quando griderà verso di me, io lo ascolterò, perché io sono misericordioso» (22,26).
Dovremmo provare a scrivere una nuova economia a partire dalla “legge del mantello del povero”; almeno immaginarla, sognarla, desiderarla, se vogliamo essere degni della voce del Sinai. Dovremmo stampare e affiggere queste parole dell’Esodo sugli stipiti delle nostre banche, sulle porte delle agenzie delle entrate, nelle aule dei tribunali, di fronte alle nostre chiese. Troppi poveri sono lasciati “nudi e senza mantello” nella notte, e muoiono al freddo delle nostre città opulente. Ma il loro grido non resta inascoltato: sono tanti, anche oggi, le persone animate da carismi che tutte le sere coprono con i loro mantelli molti poveri delle mille Stazioni Termini del mondo. Non sono sufficienti a coprire le troppe pelli ancora denudate di giorno e di notte. Ma la loro presenza rende vive e vere quelle antiche parole di vita, che così possono parlarci più forte, scuoterci, farci dormire meno tranquilli al caldo dei nostri molti mantelli.
l.bruni@lumsa.it
In Israele germogliano i giudeocristiani Sono battezzati nella Chiesa cattolica ma parlano e vivono come gli ebrei.
di Sandro Magister

ROMA, 8 ottobre 2010 – Alla vigilia del sinodo su "La Chiesa cattolica nel Medio Oriente: comunione e testimonianza", che si terrà in Vaticano dal 10 al 24 ottobre, è la stessa presenza dei cattolici in quelle terre che apre problemi.
Molti degli appartenenti alle comunità indigene, eredi delle antiche cristianità lì fiorenti prima che vi arrivasse l'islam, fuggono via.
Quelli che restano vivono qua e là nel terrore, ad esempio nel nord dell'Iraq, a Mosul e dintorni, dove per difendersi tendono a fare ghetto nella piana di Ninive.
Ma altrove arrivano per motivi di lavoro molti altri cattolici, in gran numero. Soprattutto dall'Asia e soprattutto nei paesi del Golfo.
Ad esempio, nel solo Kuwait i lavoratori immigrati sono oggi due milioni, il doppio dei cittadini kuwaitiani. I cattolici sono 350 mila e sono in prevalenza filippini e indiani. L'ondata di questi arrivi è così massiccia, in Arabia Saudita e nel Golfo, che a Roma stanno studiando come riscrivere i confini dei vicariati dell'area, dividendo in più parti l'immenso vicariato d'Arabia che oggi raggruppa Arabia Saudita, Oman, Yemen, Emirati Arabi, Qatar e Bahrein.
C'è infine il caso speciale dei cattolici in Israele, anche questo in piena mutazione.
*
Anzitutto, entro i confini di Israele i cristiani non sono andati diminuendo, ma in cifre assolute sono aumentati anno dopo anno: da 34 mila nel 1949 a 150 mila nel 2008, ultimo dato ufficiale.
Di una loro lieve diminuzione si può parlare solo in termini percentuali – dal 3 al 2 per cento –, perché nello stesso lasso di tempo i cittadini di religione ebraica sono cresciuti da un milione a 5 milioni e mezzo, grazie alle immigrazioni dall'estero, e i musulmani da 111 mila a 1 milione 200 mila.
In Israele, i cristiani sono presenti soprattutto in Galilea, mentre a Gerusalemme se ne contano 15 mila.
L'esodo di cristiani per il quale si lancia l'allarme riguarda quindi non Israele ma piuttosto la Terra Santa, termine geograficamente estensibile, che comprende i territori palestinesi e parti dei paesi arabi circostanti, fino alla Turchia e a Cipro.
*
La novità di maggior interesse, entro i confini di Israele, riguarda i cattolici di lingua ebraica.
Per la loro cura il patriarcato latino di Gerusalemme ha uno specifico vicariato, oggi affidato al gesuita David Neuhaus, ebreo israeliano convertito al cristianesimo.
Fino a pochi anni fa, in Israele, i cattolici di lingua ebraica erano poche centinaia. Ma sono in netta crescita e contano oggi almeno sette comunità: a Gerusalemme, Jaffa, Be'er Sheva, Haifa, Tiberiade, Latrun e Nazaret.
Alla rivista italiana "Il Regno" padre Neuhaus ha spiegato che queste comunità si sono formate grazie a quattro apporti.
Il primo apporto è venuto dagli ebrei giunti in Israele con le successive ondate migratorie, tra i quali c’erano dei cattolici, nati tali o convertiti, che sono diventati parte integrante della società israeliana di lingua ebraica. L'ultima grande ondata migratoria, dopo il 1990, è arrivata dal dissolto impero sovietico.
Il secondo apporto è dato dall'arrivo in Israele di lavoratori stranieri. Sono oggi circa 200 mila. Provengono dall'Africa, dall'America latina, dall'Europa orientale e più ancora dall'Asia. Dalle Filippine ne sono giunti 40 mila, per la maggior parte donne e cattoliche. I loro figli, nati e battezzati in Israele, vanno a scuola, imparano l'ebraico e si integrano nella società israeliana.
Il terzo apporto è costituito dai 2-3 mila maroniti libanesi trasferitisi in Israele dopo il ritiro israeliano dal sud del Libano e da profughi africani provenienti soprattutto dal Sudan meridionale, dove i cattolici sono numerosi. I loro figli crescono anch'essi parlando l'ebraico.
Infine, vi sono i palestinesi cattolici presenti in Israele fin dalla sua fondazione, con lo statuto di cittadini ma in condizioni socialmente svantaggiate. La loro lingua è l'arabo e sono stanziati soprattutto nei villaggi della Galilea, ma tendono a spostarsi in località economicamente più attraenti. Padre Neuhaus porta l'esempio di Be'er Sheva, "dove sono emigrate centinaia di famiglie arabe per lavorare nei servizi intorno ai villaggi beduini, che però non vivono con i beduini perché socialmente ed economicamente di classe inferiore. Mandano i loro figli nelle scuole di lingua ebraica e così abbiamo una nuova generazione di arabi palestinesi che parlano l'arabo solo in casa e non sanno più leggerlo né scriverlo".
Sono tutti questi – ormai alcune migliaia e di origini le più diverse – i cattolici di lingua ebraica di cui si prende cura il vicariato. La cura è rivolta in particolare ai giovanissimi, con catechismi per la prima volta redatti e insegnati nella lingua di Israele.
Commenta padre Neuhaus: "Operiamo con mezzi poveri. Nel patriarcato la maggioranza cristiana palestinese è quella a cui si dedica maggiore attenzione, e così i cristiani di lingua ebraica sono in un certo senso dimenticati. Ma siamo poveri anche in termini di persone che se ne occupino: siamo un piccolissimo gruppo con compiti troppo grandi».
*
Nel 2003 la Santa Sede pose alla testa del vicariato di Gerusalemme per i cattolici di lingua ebraica un vescovo e monaco benedettino di grande valore, Jean Baptiste Gourion, algerino di nascita, anche lui un ebreo convertito.
La nomina fu criticata aspramente dai circoli pro-palestinesi della Chiesa cattolica. Sulla rivista dei gesuiti di New York, "America", padre Drew Christiansen, che ne è l'attuale direttore, la definì "una manovra mirata a dividere la Chiesa in Terra Santa".
Purtroppo il vescovo Gourion morì poco dopo, prematuramente. E ai suoi successori non fu conferita la dignità episcopale.
Dice padre Neuhaus: "Come cattolici di lingua ebraica siamo una doppia minoranza, sia nello stato d’Israele sia nella Chiesa. A volte abbiamo l’impressione di vivere in un piccolissimo ghetto".
Un briciolo di speranza viene dal testo base del sinodo sul Medio Oriente che sta per cominciare in Vaticano, là dove definisce "un grande aiuto" al dialogo con l'ebraismo l'esistenza del vicariato per i cattolici di lingua ebraica.
Il servizio di Maria Chiara Rioli su "Il Regno" n. 16, 2010, con l'intervista a padre David Neuhaus:
> Medio Oriente. I nuovi cattolici
Negev In Israele rinasce la voglia di deserto
Quasi nessuno percorre ormai la Route 40 da Eilat a Tel Aviv. Per tagliare in due il deserto, gli israeliani imboccano la nuova Route 90, ma è dalla vecchia superstrada, più lunga e tortuosa, che si gode delle spettacolari vedute sul Negev.
Rocce, distese di arenaria, crateri naturali provocati dalle erosioni o da giganteschi meteoriti, canyon di granito. È in questi enormi spazi vuoti che, fra spiritualità ed economia, si giocano alcune scommesse del governo d’Israele. In una sorta di 'imprenditorialità' del deserto che, da David Ben Gurion in poi, ha mosso lo sforzo creativo di tutti i primi ministri. Il tentativo cominciato negli anni ’50, con la nascita dello Stato, di trasformare le distese aride in terreni agricoli ha dato esiti ammirevoli ma non imponenti e solo un decimo della popolazione vive nel deserto. Oggi non si tratta più solo di popolarlo. Per cercare di afferrare il rapporto del Paese con i suoi deserti può servire la testimonianza che fra Oscar Marzo, francescano della Custodia di Terra santa, appassionato di deserto e guida per chi affronta pellegrinaggi nei luoghi dell’Esodo, ha raccolto un giorno, trascorrendo lo Shabbat con una famiglia di Gerusalemme. Una donna gli ha spiegato che «solo nel deserto il popolo d’Israele poteva arrivare a una esperienza tanto forte di Dio». Il deserto è parte integrante dell’educazione dei giovani. Il ministero per l’Educazione ne propone la fruizione in molte forme, e a tutte le età: walking, trekking, equitazione, zoo-safari, campeggio per famiglie, pernottamenti per le scolaresche. Nel bel mezzo del maktesh Ramon, il cratere lungo quaranta chilometri e profondo trecento, può succedere d’imbattersi al mattino presto, nel silenzio, in una famigliola in mountan bike, con i bambini ben allacciati ai seggiolini che si guardano incuriositi tutt’attorno. O in gruppetti di ragazzi che discendono un costone roccioso chiacchierando tra loro come al bar. Gli israeliani vengono letteralmente 'allattati' nel deserto, per sviluppare l’attaccamento alla loro terra.
Laggiù spesso si svolge anche il lungo servizio militare, che dura tre anni per i ragazzi e quasi due per le ragazze. Alcuni soldati hanno sofferto una sorta di 'sindrome del deserto', dopo la guerra del Kippur, che li portava a ritornarvi sempre. «Quando ho voglia di deserto – racconta lo scrittore Meir Shalev, dietro la vetrata di un ristorante sul mare a Tel Aviv –, vado nel deserto, mi trovo una tamerice, e resto lì sotto per tre giorni». Sfondo o addirittura protagonista dei loro romanzi, il deserto è vissuto quotidianamente da molti artisti israeliani. Come Amos Oz: la sua Arad, una cittadina di provincia (e uno dei più antichi esperimenti di urbanizzazione), è riconoscibile, anche se un po’ trasfigurata, nella Tel Kedar di Non dire notte. «Cammino nel deserto tutte le mattine – ha detto una volta Oz –. Mi aiuta a collocare le cose nella giusta prospettiva». Non gli si può dare torto: l’alba nel Negev cambia colore con il cambiare della latitudine: rosata come la sabbia del wadi Paran, rosseggiante come i canyon di granito dei monti di Eilat, o biancastra come le rocce multiformi che, nella valle di Timna, nascondono la miniera di rame più antica del mondo. Il potenziale economico del deserto è ben utilizzato: la spiritualità e la connotazione biblica, in un Paese in cui perfino i nomi sui cartelli stradali rievocano l’Antico Testamento, riesce a convivere con la nuova vocazione turistica. Il deserto è ancora poco battuto dal viaggiatore tradizionale che si rechi in Israele: basti pensare che non sono più di cinquecento l’anno le persone che chiedono di farvi tappa.
Percorrendo il deserto di Paran, i 'pellegrini' nei luoghi della Bibbia possono fermarsi negli accampamenti beduini. Lo stile di vita dei nomadi del deserto non è cambiato molto in migliaia di anni.
Lo Stato prova a costruire loro dei villaggi. Si vedono passando lungo la Rte 40: le case sono utilizzate come stalle e i beduini preferiscono dormire lì vicino, in tende o in casette di lamiera. Be’erot, nel deserto di Mitzpe Ramon, è una sorta di campeggio gestito proprio dai beduini. Nel silenzio della sera, ci si siede ai loro tavoli bassi e si mangia l’hummus di ceci e il pane sottile cotto su piastre di ferro rovente.
Anche qui è possibile vedere come sia favorita la fruizione del deserto a livello locale: nonostante sia isolato, Be’erot ospita carovane di studenti in sacco a pelo.
L’
alternativa sono i kibbutz. Le comuni agricole, dopo aver perso il loro ruolo di traino dell’economia locale, da una decina d’anni a questa parte si reinventano in chiave turistica: diventano piccoli resort, bed&breakfast o centri benessere, arricchiti dalla possibilità di beneficiare dei fanghi del Mar Morto.
Solo una fattoria su quattro conserva ancora la vecchia veste marxista. La conversione economica dei kibbutz ha fatto lievitare il costo dei terreni ma soprattutto ha riportato nel deserto i giovani, che ormai tendevano a trasferirsi nelle più tecnologiche città, come Tel Aviv.
Naturalmente ogni kibbutz rinnovato ha un sito internet. E naturalmente (all’inizio sembra strano, ma non lo è se si pensa alle esigue dimensioni d’Israele) non c’è wadi più remoto in cui il cellulare non funzioni. Sì che la radice di deserto in ebraico contiene «parola», ma di certo il motivo era un altro.
© Copyright Avvenire 9 maggio 2010
Israele, i preparativi alla Pasqua ebraica tra gli ultraortodossi
- Belle cannonate laiche contro Darwin. Scienziati spiegano che la scienza deve diffidare del mainstream darwiniano. Giuliano Ferrara
- Le crociate? I buoni eravamo noi. Un saggio dello studioso Rodney Stark ribalta le tesi classiche sulle guerre di religione. Rino Cammilleri
- La cena dei cretini. La Francia rivoluzionaria si macchiò 200 anni fa degli stessi crimini che si è soliti associare al nazismo
- Lo smarrimento d'identità della cultura cristiana di Eugenio Corti
- Ma dove è andata a finire l'autorevolezza dei genitori? Solo a Roma oltre 40 bande di bulli
Le festività di Pesach, detta anche Pasqua ebraica, ricorda l’esodo e la liberazione del popolo israelita dall’Egitto. Prima dell’inizio della festività, si eliminano dalla casa tutte le tracce di lievito e di ogni tipo di cibo che lo contenga. Durante tutto il periodo della festività - otto giorni (sette nella sola Israele) - non viene consumato cibo lievitato: il pane, la pasta e i dolci sono sostituiti da cibi appositamente preparati.
 passerò oltre, colpirò invece con il mio castigo l'intero Egitto, e a voi non succederà niente"" class="size-large wp-image-15529" width="672" height="447">
passerò oltre, colpirò invece con il mio castigo l'intero Egitto, e a voi non succederà niente"" class="size-large wp-image-15529" width="672" height="447"> -

- Beit Horon. Una piccola folla osserva la raccolta dell’acqua che verrà usata per preparare la matzah, il pane azimo
-

- Beit Horon. La raccolta dell’acqua usata per preparare il pane azimo. Durante la settimana di Pesach, è vietato cibarsi di qualsiasi cibo contenente lievito.
-

- Beit Horon. La raccolta dell’acqua usata per preparare il pane azimo. Si ritiene che l’usanza del pane non lievitato provenga dal ricordo del pane di cui gli Israeliti si cibarono durante la loro fuga dall’Egitto e l’Esodo
-

- “In questa notte io passerò attraverso l’Egitto e colpirò a morte ogni primogenito egiziano, sia fra le genti che tra il bestiame. Io vedrò il sangue e passerò oltre, colpirò invece con il mio castigo l’intero Egitto, e a voi non succederà niente”
-

- Durante le prime due sere si usa consumare la cena seguendo un ordine particolare di cibi e preghiere che prende il nome di seder, parola che in ebraico significa per l’appunto “ordine”
-

- Prima dell’inizio della festività gli ebrei eliminano da casa ogni minima traccia di lievito e qualsiasi cibo che ne contenga (questo viene indicato con il termine chametz)
La Pesach viene solitamente trascorsa in famiglia. Nelle prime cene si mangiano i cibi seguendo un ordine particolare e alternando le pietanze a delle preghiere ed alla narrazione del conflitto con il faraone, delle 10 piaghe e della fuga finale, seguendo il racconto della Haggadah di Pesach. Questo rito prende il nome di seder, che significa ordine. Tradizionalmente, il bambino più piccolo della famiglia chiede all’uomo più anziano di raccontare cosa successe all’epoca dell’Esodo.
Nel corso del seder c’è l’obbligo di bere quattro bicchieri di vino, il che aiuta a far terminare la cena con canti tradizionali.
- Lunedì 29 Marzo 2010
© Copyright Panorama
Una sbirciatina al ghetto di Roma per capire la guerra sulle ciambelline di Pesach
in questi giorni sui muri del Portico
d’Ottavia, il cuore dell’antico ghetto
ebraico romano. Si va da “ciambellette
per tutti”, a “farina libera”, passando
per “oggi farina, e domani?”.
E’ successo che proprio in prossimità
di Pesach, la Pasqua ebraica, un
parere scritto del rabbino capo di
Israele, Rav Amar, abbia avanzato
dubbi sulla qualità “kosher” delle farine
usate nella comunità romana per
le ciambelline che fanno parte della
tradizione pasquale. A Roma, a quanto
risulta al rabbino capo di Israele,
che era stato sollecitato sul tema da
un rabbino romano, Ronnie Canarutto,
è molto alto il pericolo che nella
preparazione casalinga dei piccoli
dolci siano usate farine contaminate
da lievito, e quindi non “kosher”. Non
è una questione da poco, perché la totale
assenza di lievito nel cibo di Pesach
significa liberazione dalla schiavitù
in Egitto.
La bocciatura di buona parte delle
farine romane da parte del rabbino
capo di Israele ha provocato l’insoddisfazione
di una parte della comunità
capitolina (la più antica del mondo
tra quelle della diaspora), che ha
trovato eco addirittura in un gruppo
di protesta su Facebook, intitolato
“Per chi non accetta la decisione di
togliere la farina per Pesach” e dove
ora ci si scambiano ricette alternative.
Oltre alle scritte citate, chi andasse in
questi giorni al Portico d’Ottavia potrebbe
leggere alcuni avvisi affissi alle
porte delle pasticcerie e dei forni
della zona. Forni e pasticcerie che rivendicano
la perfetta qualità “kosher”
dei loro prodotti, ma che anche – e
non era mai successo prima – diffidano
i clienti dall’introdurre nei negozi
cibi di qualsiasi tipo dall’esterno.
La parola decisiva l’ha per ora detta
il rabbino capo di Roma, Riccardo
Di Segni, dopo aver parlato al telefono
con Rav Amar e dopo aver convocato
il consiglio dei rabbini romani: al
desco di Pesach potranno essere consumate
solo le ciambelle prodotte (a
prezzi calmierati per l’occasione) dai
forni kosher, con farine certificate,
mentre bisognerà rinunciare alle
ciambelline fatte in casa. Non c’è infatti
certezza – che deriva dall’assoluta
esclusione dell’acqua nel processo
di separazione della farina vera e propria
dalla crusca – sull’assenza di lievito
nelle farine impiegate per prepararle.
La querelle sulle ciambelline di
Pesach, con i suoi strascichi di malumori
– poche sere fa, durante la presentazione
di un libro in sinagoga, il
rabbino Di Segni ha zittito bruscamente
chi voleva invitare alla guerra
contro il rabbino di Israele – aggiunge
nervosismo ai preesistenti contrasti
nella comunità ebraica romana, che
però proprio ieri avrebbero trovato
una soluzione. Pochi giorni fa, un
gruppo di quindici consiglieri, in polemica
con l’attuale presidente, Riccardo
Pacifici, aveva rassegnato le dimissioni.
I dimissionari, l’ala di sinistra
della comunità, avevano evocato
“comportamenti non corretti, non etici,
non sani” dell’attuale presidenza.
La cui vera colpa sarebbe quella di
aver voluto la visita del Papa in sinagoga
e di aver governato, forte di una
maggioranza schiacciante, senza coinvolgere
la minoranza. (nic.til)
© Copyright Il Foglio 25 marzo 2010
Kibbutz da un secolo. Nasceva nel 1910 una delle principali basi sociali dello Stato di Israele
Il kibbutz, l'istituzione che ha rappresentato una delle principali basi sociali dello Stato d'Israele, compie un secolo. Bisogna anche dire che dimostra tutti i suoi anni, dal momento che è, a partire dagli anni Ottanta, in grande declino, e che i kibbutzim (plurale di kibbutz) sopravvissuti alla crisi hanno mutato radicalmente sia il loro carattere collettivistico sia il loro tipo di produzione.
Per risalire alle origini del kibbutz, bisogna tornare all'inizio del XX secolo, non al contesto europeo da cui è uscito il progetto sionista di Herzl, ma a quello russo: a fine Ottocento, circa cinque milioni di ebrei, privi di possibilità di emancipazione politica, ristretti nelle possibilità di movimento, sottoposti a ondate di pogroms sanguinosi. All'ondata di violenze che avevano colpito le comunità ebraiche dopo l'assassinio dello zar Alessandro ii nel 1881, gli ebrei avevano risposto con l'elaborazione di un progetto di rinascita nazionale in terra d'Israele, appunto il sionismo. Il libro di Leo Pinsker, Autoemancipazione, è del 1882, precedendo quindi di oltre dieci anni Lo Stato degli ebrei di Theodore Herzl. Pinsker fu l'ispiratore di un gruppo di giovani sionisti, "Gli amanti di Sion", molti dei quali si trasferirono in terra d'Israele, allora ancora parte dell'impero Ottomano, dedicandosi all'agricoltura e fondando il primo insediamento agricolo ebraico, Rishon le Tzion. Era la prima Aliya (immigrazione, in ebraico "salita").
Nulla di rivoluzionario, però, nella struttura sociale creata, con fattorie individuali coltivate da mano d'opera araba. Fu proprio dalla critica di questa prima forma di insediamento che nacque il progetto del kibbutz. A dar vita ai primi kibbutzim sono membri della seconda Aliya, giovani russi in fuga dai pogroms degli anni fra il 1903 e il 1906. Sono giovani socialisti, che vogliono portare nel nuovo mondo che stanno creando i principi della giustizia sociale e dell'uguaglianza, che vogliono combattere la proprietà privata come fonte di ogni male. Ne nasce il kibbutz, fattoria agricola collettiva fondata sull'adesione volontaria e governata da un'assemblea, in cui nulla era di proprietà dei membri del kibbutz, in cui si lavorava e si produceva in comune - questa volta non erano gli arabi a lavorare la terra, ma i membri del kibbutz - e in cui la vita stessa era organizzata su basi collettive: la moneta non vi aveva valore, i pasti erano consumati in comune, e nei primi anni anche i bambini vivevano collettivamente, fuori dalle famiglie.Nonostante la sua impostazione socialista, di origine europea, il kibbutz nasce in terra d'Israele, come adattamento dei principi socialisti alla pratica del lavoro e alle caratteristiche stesse della terra, che non era di proprietà di nessuno in particolare, ma del popolo ebraico tutto, dal momento che veniva acquistata con le collette compiute fra gli ebrei di tutto il mondo. Il primo kibbutz fu Degania (in ebraico "il villaggio dei cereali"), fondato appunto cent'anni fa, nel 1910, in Galilea, sulla sponda meridionale del lago di Tiberiade, a opera di dodici giovani ebrei russi, di cui due donne. Uno di loro, Yoseph Baratz, avrebbe in seguito scritto la storia di quell'impresa. A Degania, che già nel 1914 aveva 50 membri, seguirono altri kibbutzim, sempre più grandi. Ein Harod, fondato nel 1921, nasce già con 250 membri. I kibbutzim sono una cinquantina nel 1940, 200 nel 1948, 250 nel 1980. Fino alla fine degli anni Cinquanta esclusivamente agricoli, essi rappresentano una fetta consistente dell'economia nazionale, anche se sono accompagnati in altri settori da un'economia di tipo tradizionale, e fin da cooperative agricole in cui è collettivizzato solo il commercio ma non la produzione, i moshavim (plurale di moshav). Molto legati nei primi anni ai partiti operai e fortemente laici, essi sono affiancati negli anni Trenta dai kibbutzim religiosi, espressione di un'ala radicale del sionismo religioso.
Il kibbutz entra in crisi con le trasformazioni sociali ed economiche che coinvolgono il Paese a partire dalla fine degli anni Ottanta, ma anche con il declino in Occidente dell'ideologia socialista e collettivistica. Molti dei kibbutzim tuttora in vita si sono privatizzati in tutto o in parte, oltre a mutare genere di produzione, dedicandosi alla produzione di prodotti selezionati, come la frutta, e al commercio. La stessa Degania, patria di molti personaggi famosi tra cui Moshe Dayan, si è privatizzata nel 2007. La celebrazione del centenario della nascita del kibbutz punta, nell'intenzione del movimento dei kibbutzim che lo ha organizzato, a dar nuova vita all'istituzione, a favorire l'accesso di nuovi membri, a rivitalizzare insomma questa esperienza unica nella storia del mondo: istituzioni collettivistiche fondate su basi totalmente volontarie e organizzate democraticamente, senza costrizioni o limiti alla libertà delle persone. L'unico esperimento mai riuscito di collettivizzazione del lavoro e della vita degli esseri umani.
(©L'Osservatore Romano - 8-9 febbraio 2010)
Il Giorno della Memoria: Vasilij Grossman, la Shoah e Stalin -
 In occasione dell'annuale "Giornata della Memoria" si è svolto a Milano a cura de "Il Giardino dei Giusti" voluto dall'intellettuale e scrittore Gabriele Nissim, un incontro che ha ricordato tre figure, tre testimoni che in ambiti diversi hanno vissuto la tragedia della violenza del totalitarismo, sia esso nazista che comunista. I nomi: Marek Edelman, ebreo polacco, Guelfo Zamboni, console italianoche salvò centinaia di ebrei dai nazisti, e Vasilij Grossman, scrittore russo che combattè la censura antisemita di Stalin. Proprio di Grossman abbiamo chiesto al prof.Adriano Dell'Asta, docente di letteratura russa all'Università Cattolica di Milano, di tratteggiarne la figura:
In occasione dell'annuale "Giornata della Memoria" si è svolto a Milano a cura de "Il Giardino dei Giusti" voluto dall'intellettuale e scrittore Gabriele Nissim, un incontro che ha ricordato tre figure, tre testimoni che in ambiti diversi hanno vissuto la tragedia della violenza del totalitarismo, sia esso nazista che comunista. I nomi: Marek Edelman, ebreo polacco, Guelfo Zamboni, console italianoche salvò centinaia di ebrei dai nazisti, e Vasilij Grossman, scrittore russo che combattè la censura antisemita di Stalin. Proprio di Grossman abbiamo chiesto al prof.Adriano Dell'Asta, docente di letteratura russa all'Università Cattolica di Milano, di tratteggiarne la figura: 
ELDORADO: I libri son tesori. "Non smetteremo di danzare"
 Il 27 Gennaio l'Europa celebra il Giorno della Memoria. Si ricorda, cioè, la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico per mano nazista. Ma lo sguardo storico si allarga anche a luoghi e tempi diversi.
Il 27 Gennaio l'Europa celebra il Giorno della Memoria. Si ricorda, cioè, la Shoah, lo sterminio del popolo ebraico per mano nazista. Ma lo sguardo storico si allarga anche a luoghi e tempi diversi.Giulio Meotti, giornalista, collaboratore de "Il Foglio", ha pubblicato per le edizioni Lindau, una raccolta di storie, in un volume dal titolo "Non smetteremo di danzare". Le storie mai raccontate dei martiri d'Israele. Lo abbiamo intervistato:

Il Giorno della Memoria, pensando ai nostri figli - intervista a Guido Guastalla
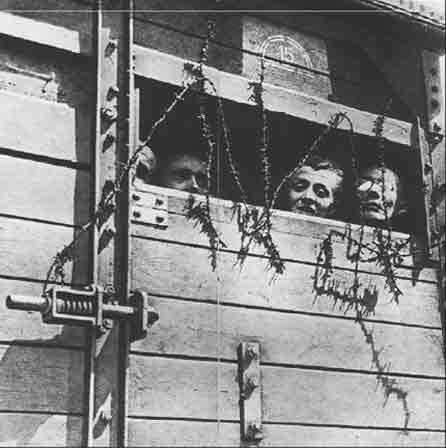 Tra gli incontri organizzati per celebrare "Il giorno della Memoria", di grande importanza quello alla Camera dei Deputati a Montecitorio.
Tra gli incontri organizzati per celebrare "Il giorno della Memoria", di grande importanza quello alla Camera dei Deputati a Montecitorio.Hanno presieduto il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quello della Camera Gianfranco Fini ed il Premier Silvio Berlusconi, che hanno accolto con emozione Eli Weisel, ex internato ad Auschwitz e Premio Nobel per la Pace nel 1986.
Abbiamo intervistato Guido Guastalla, assessore alla Cultura della Comunità Ebraica di Livorno, che è stato spettatore dell'incontro, che ci ha ricordato come solo la poesia aiuta l'uomo a non dimenticare.:

Le linee guida di Benedetto XVI per frenare l’esodo dei cristiani sotto attacco in Medio Oriente e in altri 60 Paesi nel mondo
 Un piano Marshall cattolico per salvare i cristiani dall’estinzione in Medio Oriente e nei paesi a maggioranza musulmana: è quello che si appresta a lanciare Papa Benedetto XVI per far fronte alla nuova, terribile escalation di violenza. Due commercianti cristiani uccisi a Mosul, in Iraq, dove si è appena insediato il nuovo vescovo Emil Shimoun Nona. Un agguato ai cristiani copti in Egitto, il 6 dicembre all’uscita della Messa, con sette morti e nove feriti. Undici chiese cristiane danneggiate in Malaysia. Una chiesa evangelica data alle fiamme nella Cabilia, in Algeria. E ancora Somalia, India, Pakistan, Cina, Myanmar, Corea del Nord, Maldive e Zanzibar: in 60 paesi del mondo, concentrati in Asia e Africa, i cristiani rischiano il martirio. Certo, in alcuni paesi anche i cristiani si macchiano di fanatismo: a Jos, in Nigeria, gli scontri con i musulmani hanno lasciato sul campo centinaia di morti da entrambe le parti. Ma nella gran parte dei casi le vittime sono i cristiani. Sette le linee guida del piano tracciato dal Papa con i suoi collaboratori: tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sulle violazioni alla libertà religiosa e sulle persecuzioni dei cristiani; rafforzare la collaborazione delle Chiese cristiane mettendo da parte antichi conflitti e rivalità; costruire case per i cristiani in Terra Santa; favorire i pellegrinaggi; promuovere l’occupazione dei cristiani nei territori palestinesi e l’edificazione di scuole; intensificare l’impegno caritativo delle associazioni cattoliche per far fronte al proselitismo delle organizzazioni umanitarie islamiche; arginare la diffusione delle sette di ispirazione evangelica e pentecostale che, complici la povertà e le persecuzioni, sottraggono fedeli alla Chiesa Cattolica offrendo anche aiuti materiali. Non c’è tempo da perdere. Anche i missionari pagano un prezzo altissimo: nel corso dell’ultimo anno ne sono stati uccisi 37 (sono stati 20 nel 2008). Due erano italiani: Giuseppe Bertaina a Nairobi, in Kenya, e Ruggero Ruvoletto a Manaus in Brasile. "I missionari uccisi sono martiri della fede ma anche della giustizia" spiega a Panorama Giulio Albanese, missionario comboniano e direttore delle riviste missionarie delle Pontificie opere missionarie. "Vengono uccisi perché difendono la vita e i diritti dei più deboli e spesso, come accade oggi in alcune aree della Repubblica del Congo e del Sudan meridionale, sono le uniche forze di interposizione fra gli eserciti e la gente comune". Lo stesso accade in alcuni paesi dell’America Latina (Colombia, Guatemala, Brasile, Bolivia), dove sacerdoti e religiosi vengono uccisi o intimiditi perché si oppongono alle violenze dei clan della droga o degli squadroni della morte. In ogni caso la Chiesa non si lascia intimidire, ha detto il Papa il giorno di Natale, e continua ad annunciare "ovunque il Vangelo di Cristo nonostante le persecuzioni, le discriminazioni, gli attacchi e l’indifferenza, talvolta ostile". Però chiede aiuto alla comunità internazionale affinché si metta fine a questo martirio. "Gli stati fondamentalisti, come il Pakistan e l’Arabia Saudita, e i regimi atei, come quelli della Cina e della Corea del Nord, sono i principali nemici dei cristiani" spiega Bernardo Cervellera, missionario del Pime e direttore dell’agenzia AsiaNews. Ma, prosegue Cervellera, "è l’indifferenza della comunità internazionale, e dell’Europa in particolare, il più grande alleato dei paesi che ostacolano la libertà religiosa". La fuga diventa così l’unica via d’uscita per i cristiani perseguitati, in particolare in Medio Oriente. I cristiani arabi sono ridotti a 11 milioni in sette paesi: Egitto, Iraq, Giordania, Siria, Libano, Israele e Territori palestinesi, ma il loro numero continua a diminuire. Dalla Guerra dei sei giorni (1967) a oggi è emigrato il 35 per cento dei cristiani palestinesi con destinazione America Latina e Canada. In Libano i cristiani sono scesi dal 51 al 40 per cento della popolazione. Più clamoroso di tutti è il caso dell’Iraq dove, prima della guerra, vivevano 1,5 milioni di cattolici e oggi sono meno di 400 mila. "I cristiani si trovano in particolare difficoltà soprattutto in Medio Oriente perché ai ben noti problemi dell’area si aggiungono le pressioni socioreligiose dovute al fatto di essere ormai piccola minoranza (le stime parlano del 4 per cento) in un contesto sempre più islamico. È perciò inevitabile la spinta all’emigrazione", osserva Massimo Ilardo, direttore per l’Italia di Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), che cura un rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo. Per mobilitare la Chiesa e l’opinione pubblica mondiale il Papa ha convocato un Sinodo speciale dei vescovi per il Medio Oriente, che si terrà a Roma dal 10 al 24 ottobre prossimo. La speranza è favorire il dialogo con l’Islam e gli ebrei, ma anzitutto superare le divisioni interne agli stessi cristiani che in Medio Oriente fanno capo a 22 diverse denominazioni tra ortodossi, cattolici ed evangelici, spesso in attrito fra loro, come in occasione dei clamorosi scontri alla Basilica del Santo sepolcro di Gerusalemme. Intanto il piano Marshall del Papa è già in atto. "Sono tre le direttrici principali di intervento per fermare l’esodo dei cristiani" spiega Giuseppe Caffulli, direttore della rivista Terrasanta e del portale www.terrasanta.net della custodia francescana. "Costruire scuole, dove cristiani e musulmani crescano insieme, imparando a conoscersi e a rispettarsi. Costruire case per fare fronte alla drammatica mancanza di alloggi nei Territori. A questo scopo la custodia francescana di Terra Santa e il patriarcato di Gerusalemme hanno già edificato cinque o sei palazzi a Betlemme, in Galilea e a Haifa, con l’aiuto anche della CEI e di altre Conferenze Episcopali. Infine impegnarsi nella pastorale: far comprendere ai cristiani che vivono in Terra Santa che hanno una vocazione speciale". Anche il turismo religioso è importante per fermare la fuga dei cristiani, spiega padre Cesare Atuire, amministratore delegato dell’Opera romana pellegrinaggi che ogni anno porta oltre 15 mila pellegrini in Israele. "Il pellegrinaggio è un modo per far sentire la vicinanza della Chiesa ai cristiani che soffrono ma anche per sostenere l’artigianato locale e favorire l’occupazione". Non c’è solo il Medio Oriente tra le priorità del Papa. C’è anche l’Africa, cui è stato dedicato invece il sinodo dell’ottobre scorso. In particolare l’emergenza Somalia, dove nel 2006 venne uccisa suor Leonella Sgorbati. Ci sono poi il proselitismo e l’islamizzazione forzata portati avanti da alcune organizzazioni umanitarie islamiche in Sudan. E c’è la "concorrenza" sempre più aggressiva delle sette di ispirazione cristiana. "Solo in Africa si contano ormai circa 15 mila chiese indipendenti" afferma padre Albanese. Per contrastarle "è necessario puntare sulla formazione soprattutto delle giovani generazioni". Insomma i cristiani sono attaccati su più fronti. Ma la Chiesa cattolica si prepara a reagire.
Un piano Marshall cattolico per salvare i cristiani dall’estinzione in Medio Oriente e nei paesi a maggioranza musulmana: è quello che si appresta a lanciare Papa Benedetto XVI per far fronte alla nuova, terribile escalation di violenza. Due commercianti cristiani uccisi a Mosul, in Iraq, dove si è appena insediato il nuovo vescovo Emil Shimoun Nona. Un agguato ai cristiani copti in Egitto, il 6 dicembre all’uscita della Messa, con sette morti e nove feriti. Undici chiese cristiane danneggiate in Malaysia. Una chiesa evangelica data alle fiamme nella Cabilia, in Algeria. E ancora Somalia, India, Pakistan, Cina, Myanmar, Corea del Nord, Maldive e Zanzibar: in 60 paesi del mondo, concentrati in Asia e Africa, i cristiani rischiano il martirio. Certo, in alcuni paesi anche i cristiani si macchiano di fanatismo: a Jos, in Nigeria, gli scontri con i musulmani hanno lasciato sul campo centinaia di morti da entrambe le parti. Ma nella gran parte dei casi le vittime sono i cristiani. Sette le linee guida del piano tracciato dal Papa con i suoi collaboratori: tenere alta l’attenzione della comunità internazionale sulle violazioni alla libertà religiosa e sulle persecuzioni dei cristiani; rafforzare la collaborazione delle Chiese cristiane mettendo da parte antichi conflitti e rivalità; costruire case per i cristiani in Terra Santa; favorire i pellegrinaggi; promuovere l’occupazione dei cristiani nei territori palestinesi e l’edificazione di scuole; intensificare l’impegno caritativo delle associazioni cattoliche per far fronte al proselitismo delle organizzazioni umanitarie islamiche; arginare la diffusione delle sette di ispirazione evangelica e pentecostale che, complici la povertà e le persecuzioni, sottraggono fedeli alla Chiesa Cattolica offrendo anche aiuti materiali. Non c’è tempo da perdere. Anche i missionari pagano un prezzo altissimo: nel corso dell’ultimo anno ne sono stati uccisi 37 (sono stati 20 nel 2008). Due erano italiani: Giuseppe Bertaina a Nairobi, in Kenya, e Ruggero Ruvoletto a Manaus in Brasile. "I missionari uccisi sono martiri della fede ma anche della giustizia" spiega a Panorama Giulio Albanese, missionario comboniano e direttore delle riviste missionarie delle Pontificie opere missionarie. "Vengono uccisi perché difendono la vita e i diritti dei più deboli e spesso, come accade oggi in alcune aree della Repubblica del Congo e del Sudan meridionale, sono le uniche forze di interposizione fra gli eserciti e la gente comune". Lo stesso accade in alcuni paesi dell’America Latina (Colombia, Guatemala, Brasile, Bolivia), dove sacerdoti e religiosi vengono uccisi o intimiditi perché si oppongono alle violenze dei clan della droga o degli squadroni della morte. In ogni caso la Chiesa non si lascia intimidire, ha detto il Papa il giorno di Natale, e continua ad annunciare "ovunque il Vangelo di Cristo nonostante le persecuzioni, le discriminazioni, gli attacchi e l’indifferenza, talvolta ostile". Però chiede aiuto alla comunità internazionale affinché si metta fine a questo martirio. "Gli stati fondamentalisti, come il Pakistan e l’Arabia Saudita, e i regimi atei, come quelli della Cina e della Corea del Nord, sono i principali nemici dei cristiani" spiega Bernardo Cervellera, missionario del Pime e direttore dell’agenzia AsiaNews. Ma, prosegue Cervellera, "è l’indifferenza della comunità internazionale, e dell’Europa in particolare, il più grande alleato dei paesi che ostacolano la libertà religiosa". La fuga diventa così l’unica via d’uscita per i cristiani perseguitati, in particolare in Medio Oriente. I cristiani arabi sono ridotti a 11 milioni in sette paesi: Egitto, Iraq, Giordania, Siria, Libano, Israele e Territori palestinesi, ma il loro numero continua a diminuire. Dalla Guerra dei sei giorni (1967) a oggi è emigrato il 35 per cento dei cristiani palestinesi con destinazione America Latina e Canada. In Libano i cristiani sono scesi dal 51 al 40 per cento della popolazione. Più clamoroso di tutti è il caso dell’Iraq dove, prima della guerra, vivevano 1,5 milioni di cattolici e oggi sono meno di 400 mila. "I cristiani si trovano in particolare difficoltà soprattutto in Medio Oriente perché ai ben noti problemi dell’area si aggiungono le pressioni socioreligiose dovute al fatto di essere ormai piccola minoranza (le stime parlano del 4 per cento) in un contesto sempre più islamico. È perciò inevitabile la spinta all’emigrazione", osserva Massimo Ilardo, direttore per l’Italia di Aiuto alla Chiesa che soffre (Acs), che cura un rapporto annuale sulla libertà religiosa nel mondo. Per mobilitare la Chiesa e l’opinione pubblica mondiale il Papa ha convocato un Sinodo speciale dei vescovi per il Medio Oriente, che si terrà a Roma dal 10 al 24 ottobre prossimo. La speranza è favorire il dialogo con l’Islam e gli ebrei, ma anzitutto superare le divisioni interne agli stessi cristiani che in Medio Oriente fanno capo a 22 diverse denominazioni tra ortodossi, cattolici ed evangelici, spesso in attrito fra loro, come in occasione dei clamorosi scontri alla Basilica del Santo sepolcro di Gerusalemme. Intanto il piano Marshall del Papa è già in atto. "Sono tre le direttrici principali di intervento per fermare l’esodo dei cristiani" spiega Giuseppe Caffulli, direttore della rivista Terrasanta e del portale www.terrasanta.net della custodia francescana. "Costruire scuole, dove cristiani e musulmani crescano insieme, imparando a conoscersi e a rispettarsi. Costruire case per fare fronte alla drammatica mancanza di alloggi nei Territori. A questo scopo la custodia francescana di Terra Santa e il patriarcato di Gerusalemme hanno già edificato cinque o sei palazzi a Betlemme, in Galilea e a Haifa, con l’aiuto anche della CEI e di altre Conferenze Episcopali. Infine impegnarsi nella pastorale: far comprendere ai cristiani che vivono in Terra Santa che hanno una vocazione speciale". Anche il turismo religioso è importante per fermare la fuga dei cristiani, spiega padre Cesare Atuire, amministratore delegato dell’Opera romana pellegrinaggi che ogni anno porta oltre 15 mila pellegrini in Israele. "Il pellegrinaggio è un modo per far sentire la vicinanza della Chiesa ai cristiani che soffrono ma anche per sostenere l’artigianato locale e favorire l’occupazione". Non c’è solo il Medio Oriente tra le priorità del Papa. C’è anche l’Africa, cui è stato dedicato invece il sinodo dell’ottobre scorso. In particolare l’emergenza Somalia, dove nel 2006 venne uccisa suor Leonella Sgorbati. Ci sono poi il proselitismo e l’islamizzazione forzata portati avanti da alcune organizzazioni umanitarie islamiche in Sudan. E c’è la "concorrenza" sempre più aggressiva delle sette di ispirazione cristiana. "Solo in Africa si contano ormai circa 15 mila chiese indipendenti" afferma padre Albanese. Per contrastarle "è necessario puntare sulla formazione soprattutto delle giovani generazioni". Insomma i cristiani sono attaccati su più fronti. Ma la Chiesa cattolica si prepara a reagire.Neusner: Un amico benefico e benedetto. Di G. Meotti
Per “il rabbino preferito del Papa” la visita del Santo Padre alla sinagoga di Roma conferma che «il dialogo tra la Chiesa e gli ebrei è giunto a maturazione»

A Neusner chiediamo quale sia la relazione fra Ratzinger e il giudaismo. «Papa Benedetto XVI ha portato avanti il messaggio del suo predecessore, Giovanni Paolo II il Grande, e ha formulato questo dialogo nel libro su Gesù. Si è impegnato a lavorare alle differenze fra le due grandi religioni della Scrittura. Ha assunto seriamente la critica giudaica alla cristianità e ha proposto una risposta cattolica. Il dialogo cristiano-giudaico è giunto a maturazione durante questo papato, il sì del Papa è un sì e il suo no è un no. Ha una mente chiara. La sua lezione di Ratisbona sull’islam ha mostrato devozione alla verità e integrità nel dialogo interreligioso. Il coraggio di quella lezione ha dato un modello di onestà e di chiarezza di visione che definisce oggi il dialogo religioso». Un dialogo, quello fra ebrei e cattolici, che secondo il professore-rabbino si fonda su una «causa comune», e cioè «la definizione condivisa delle Scritture, la Torah del giudaismo e l’antico Testamento della cristianità. I cattolici hanno appreso dal giudaismo l’interpretazione del mandato delle Scritture e gli ebrei hanno imparato dalla lettura cattolica. È una sfida profetica per entrambi. Ciascuno porta del suo e questo beneficia tutti, è un patrimonio che sosterrà le generazioni future».
Una questione ancora dirimente è lo Stato d’Israele. Un anno fa, durante l’offensiva militare a Gaza volta a sgominare le cellule terroristiche di Hamas che si sono impossessate della Striscia, alcuni rappresentanti della Santa Sede hanno attaccato duramente lo Stato ebraico, paragonando Gaza a un «campo di concentramento». Ma altri prestigiosi principi della Chiesa, a cominciare dall’austriaco Christoph Schönborn, hanno proclamato che Israele è un segno dell’elezione del popolo ebraico. Cinque anni fa, in visita in Israele, all’Università di Gerusalemme ha parlato sul tema “La terra eletta di Dio”. «Soltanto una volta, nella storia dell’umanità, Dio ha preso un paese in eredità e l’ha dato al popolo scelto da lui», ha detto l’arcivescovo di Vienna. «L’elezione del popolo ebraico e il suo retaggio in Terra Santa sono questioni di fede che risalgono alle stesse Scritture». Per Neusner la visione di Schönborn è anche quella del Papa. «Lo Stato d’Israele afferma la rivendicazione del popolo d’Israele sulla terra che Dio ha promesso e ha consegnato loro», spiega a Tempi. «Riconoscendo lo Stato d’Israele e sostenendo gli israeliani nella loro coraggiosa battaglia per la sopravvivenza, il Vaticano sostiene l’imperativo delle Scritture. Ogni altra posizione significherebbe il ripudio della Scrittura, un giudizio che peserebbe su tutti noi».
Tempi 21 Gennaio 2010
L'ambasciatore israeliano agli ebrei: dialogate con la Chiesa senza paura “I cattolici ci porgono la mano. Sarebbe insensato non afferrarla”
ROMA, giovedì, 21 gennaio 2010 (ZENIT.org).- L'ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Mordechay Lewy, ha pubblicato alcune dichiarazioni sui numeri di gennaio e febbraio della rivista mensile ebraica italiana “Pagine Ebraiche”, delle quali si è fatto eco “L'Osservatore Romano” e in cui chiede ai suoi connazionali una maggiore apertura al dialogo con la Chiesa cattolica.
In entrambi gli interventi, il diplomatico israeliano lamenta che “solo pochi rappresentanti dell'ebraismo sono realmente impegnati nell'attuale dialogo con i cattolici”, e riconosce che esiste un'“asimmetria” in questo colloquio.
Anche se il suo Governo è favorevole “al continuo dialogo ai massimi livelli ufficiali, tra il Rabbinato Centrale d'Israele e la Santa Sede, rimane scetticismo da parte della corrente principale degli ortodossi”, osserva.
Questa chiusura, ammette, è superiore dopo la Shoah, che ha visto l'ortodossia ebraica, prima plurale nella sua relazione con i cristiani, diventare a dir poco meno flessibile, soprattutto la corrente degli Haredim ultraortodossi, che proibisce anche l'incontro con i sacerdoti.
Attualmente, ha spiegato, l'ebraismo riformato e quello conservatore sono “più aperti al dialogo con i cristiani”. “Lo fanno dal punto di vista della loro esperienza americana, dove la convivenza tra gruppi etnici e religiosi è intrinseca alla società”.
Anche questo dialogo, guidato dal rabbino Soloweitchik, non voleva discutere i principi di fede, anche se almeno “non rifuggiva da un dialogo che si basasse su questioni che potessero migliorare il bene comune della convivenza sociale” in temi come la bioetica, l'ecologia, la violenza, ecc.
Questa difficoltà che sperimentano molti ebrei al momento di proporre un dialogo si spiega, secondo Lewy, con il fatto che la maggior parte degli ebrei “considera come autosufficienza nel definire la propria identità religiosa. Non abbiamo bisogno di nessun altro riferimento teologico, se non la Bibbia, per spiegare la nostra vicinanza a Dio come suoi figli prescelti”.
Ciò accade, spiega, per un meccanismo di autodifesa degli ebrei nel corso della loro storia, dovendo vivere in ambienti ostili, anche se la loro relazione con i cristiani non è sempre stata così.
“La maggior parte degli ebrei percepisce la loro storia durante la Diaspora come una battaglia traumatica per la sopravvivenza contro i costanti sforzi da parte dei cattolici di convertirli gentilmente, o, nella maggioranza dei casi, coercitivamente”.
Questa ferita “grave e dolorosa” è quelle che il diplomatico israeliano invita gli ebrei a superare, esortando anche a “conoscere meglio l'altro” per “comprenderlo meglio”.
“Potrebbe essere che molti di noi, ancora traumatizzati, desiderino evitare ogni situazione in cui si debba perdonare qualcuno, specialmente se viene identificato giustamente o erroneamente come rappresentante del carnefice”, ha aggiunto.
Accettare il dialogo
In questo senso, Mordechay Lewy, citando vari saggi ebrei di tutti i tempi, ricorda che l'ebraismo “si fonda sul riconoscimento dell'unità del genere umano, dell'aderenza ai principi morali e della verità, che regnano supreme sopra ogni uomo, a prescindere dalla razza o dalla religione”.
In questo senso, ricorda gli insegnamenti delle fonti rabbiniche medievali, soprattutto Maimonide, affermando che “mostrano rispetto verso le altre religioni”.
Il diplomatico insiste sulla necessità di accettare un dialogo con i cattolici, sulla linea dell'ortodossia moderna attuale, uno dei rappresentanti della quale è il rabbino statunitense David Rosen.
“Quaranta anni di dialogo ebraico-cattolico dopo la 'Nostra aetate' sono stati un periodo di prove ed errori reciproci in cui si è sviluppato un proprio dinamismo”, aggiunge.
“Dopo la Shoah la Chiesa cattolica ha avviato negli anni Sessanta un cambiamento radicale nei riguardi degli ebrei. La conversione è bandita a un orizzonte escatologico distante e sconosciuto”.
“La capacità di sopravvivenza dell'ebraismo è garantita dalla fondazione dello Stato Ebraico”, sottolinea Lewy, sostenendo la necessità di superare questo atteggiamento di autodifesa.
“I cattolici ci porgono la mano. Sarebbe insensato non afferrarla, a meno di non voler ipotecare il nostro futuro con una costante animosità con il mondo cattolico”.
Mordechay Lewy conclude poi rinnovando ai suoi connazionali l'invito al dialogo: “I primi duemila anni non legittimano una ripetizione. Entrambi meritiamo di meglio”.
IL PAPA VISTO DAL RABBINO. Le radici giudaico-cristiane nell’incontro tra due professori. Quattro giorni con Jacob Neusner a Roma
Sono stato in compagnia di Jacob
Neusner in questo tranquillo
weekend romano di dicembre senza
pioggia, ed è stata un’esperienza singolare
che vorrei augurare a tutti noi
italiani dagli occhi pigri e impolverati.
Ho capito infatti quello che intende
Tolkien quando scrive che “Dovremmo
guardare ancora il verde, ed essere
nuovamente stupiti […] riguadagnare,
un ritrovare una visione chiara.
Dobbiamo, in ogni caso, pulire le nostre
finestre, in modo che le cose viste
con chiarezza possano essere liberate
dalla tediosa opacità del banale o del
familiare”. Per un romano niente di
più familiare del Papa. Anche quando
è di un paese lontano, il Papa è sempre
trasteverino. E se è bello che il
Papa sia qualcuno di familiare, può
essere un rischio se diventa banale, se
le nostre finestre si opacizzano e s’incrostano
di pregiudizi. Per fortuna,
sempre secondo Tolkien, c’è “l’umiltà.
E c’è, soprattutto per gli umili, Mooreeffoc,
vale a dire la fantasia chestertoniana.
Mooreeffoc è una parola immaginaria,
ma la si può trovare bell’e
scritta in ogni villaggio del nostro paese.
E’ infatti l’insegna di un Coffeeroom,
un caffé, vista dall’interno, attraverso
una porta vetrata, come è stata
vista da Dickens in una buia giornata
londinese; e Chesterton se ne è servito
per designare la bizzarria di cose
che sono divenute ovvie, quando le si
scorga, all’improvviso, da un altro
punto di vista”. Jacob Neusner è venuto
qui in Italia per rispolverare occhi
e pulire qualche finestra.
Lo avevo conosciuto solo via mail,
nel maggio del 2007, per intervistarlo
per il Foglio sul libro del Papa che lo
aveva chiamato in causa dedicandogli
diverse pagine a commento del Discorso
della Montagna. Ora è venuto
qui a Roma proprio a esporre il suo
commento a quello che è il più famoso
di tutti i discorsi in un dialogo pubblico
con monsignor Bruno Forte che
si è svolto lunedì sera all’Auditorium
di Roma in occasione della presentazione
del libro Imago Christi realizzato
dalla Fondazione Marilena Ferrari-
FMR. Era stata proprio la Fondazione
a chiedermi di invitare Jacob
Neusner per un confronto sul testo
dei capitoli 5-7 del Vangelo secondo
Matteo e non c’era scelta più indovinata:
già nel 1993 Neusner aveva
scritto un saggio “A Rabbi talks with
Jesus” (poi pubblicato dalla San Paolo
nel 2007) in cui il rabbino immaginava
di essere lì, sulla montagna ad
ascoltare le ipsissima verba Christi
per la prima volta, sforzandosi di eliminare
quel bimillenario accumulo
di giudizi e pregiudizi, commenti,
comprensioni e precomprensioni che
si era creato su quel testo. Lo sforzo
era piaciuto tanto all’allora cardinale
prefetto della Dottrina della Fede Joseph
Ratzinger (“Questa disputa mi
ha aperto gli occhi sulla grandezza
della parola di Gesù”) al punto che
quindici anni dopo, una volta diventato
Papa, ha inteso ripercorrere sul
suo libro su Gesù di Nazareth quel
lungo dialogo a distanza con l’amico
rabbino americano. La cosa mi colpì
anche perché mi era stata sottolineata
dall’amico Elio Guerriero, curatore
dell’edizione italiana del volume
papale: “Lo spazio dedicato al rabbino
Neusner è davvero sorprendente,
segnale di una precisa volontà, un
grande passo in avanti nel dialogo
con gli Ebrei”. E così feci la cosa più
semplice da fare: navigai su Internet
e in pochi secondi trovai l’indirizzo
mail di Neusner che intervistai. Al
termine della lunga chiacchierata via
mail eravamo amici: il rabbino, che
rispondeva subito, laconicamente ma
con una prontezza commovente e sorprendente
per i miei tempi italicamente
pigri, mi disse che mi poteva
chiamare Jacobbo, che per lui è l’equivalente
italiano di Jacob (ma ora
ha capito lo spelling esatto e quando
mi ha fatto l’autografo sul suo libro ha
scritto correttamente Giacomo).
Il mio amico Giacomo mi ha infatti
regalato un libro, l’edizione italiana
della sua introduzione al Talmud di
cui è uno dei massimi esperti al mondo
(il suo sito universitario elenca più
di 800 pubblicazioni sulla tradizione
rabbinica) e mi ha anche fatto dono di
un detto del Talmud che lui ha scelto
come stile di vita: “Say little but do
much: dire poco ma fare molto”. Gli
ho citato il detto italiano “chi fa non
parla, chi parla non fa” e se n’è rallegrato,
non solo perché capisce molto
bene l’italiano, nonostante gli anni e
gli acciacchi si facciano sentire, ma
anche perché sente profondamente la
vicinanza tra l’Italia e l’America. “Roma
mi ricorda New York”, mi dice
mentre passeggiamo nei pressi di Villa
Borghese, “è un centro vitale, pulsante,
e ricco di bellezza”. Ma la vicinanza
che a lui sta a cuore è un’altra:
“Il Talmud è un testo che si riferisce
alla tradizione orale del giudaismo.
Oltre alla parte scritta, la Torah, noi
ebrei diamo molta importanza alla
parte orale, al Talmud. Proprio come
nella chiesa cattolica dove c’è non solo
la Scrittura ma anche la Tradizione.
Ecco un’altra cosa che ci accomuna”.
Gli chiedo ancora del Talmud, dire
che ne è affascinato non renderebbe
l’idea, e mi spiega che è un libro frutto
dello studio di generazioni di rabbini,
quasi uno studio sul concetto di
studio. E’ una cosa fondamentale per
Neusner lo studio e mi cita Elie Wiesel
che nel saggio Celebrazione talmudica
afferma: “Lo studio significa opporsi
alla morte; e a ciò che vi è di
peggio della morte: all’oblio”. Gli comincio
a parlare di Benedetto XVI
che già nel suo primo viaggio apostolico,
a Colonia nel 2005, andò a visitare
una sinagoga tedesca e parlò ai giovani
del mondo contemporaneo affetto
da “una strana dimenticanza di Dio” e
lui si mostra in perfetta sintonia: “Oggi
si vive nell’oblio. Ciò che manca è lo
studio della storia. Penso alla questione
delle radici cristiane. Forse è sempre
stato un po’ così… mi viene in
mente che per i giovani americani di
oggi parlare della guerra del Vietnam
è come quando a me parlavano della
Prima guerra mondiale, un passato
che non mi apparteneva”. Ma Neusner
non dispera, si dichiara felice di
essere nato americano (da una famiglia
proveniente da Odessa) perché,
dice, “ho speranza nel popolo americano
in quanto è un popolo capace di
autocritica. Siamo patriottici nel senso
profondo e buono del termine”. Gli
chiedo quali siano i rapporti negli Stati
Uniti tra ebrei e cristiani e la risposta
è lapidaria: “Ottimi. Soprattutto
nei piccoli centri c’è un bellissimo
rapporto tra cristiani ed ebrei. Io ho
tanti amici cristiani e cattolici, penso
a monsignor John Favalora, arcivescovo
di Miami, e al professore Andrew
Greley di Chicago. Ma anche qui in
Italia, come gli amici della Comunità
di Sant’Egidio. Ricordo quando mi invitarono
negli anni Novanta a Milano
dove incontrai il rabbino Giuseppe
Laras che era amico dell’allora arcivescovo
della città”. Neusner stesso è
un crocevia vivente del rapporto tra
ebrei e cristiani: a 78 anni ancora insegna
e nel semestre primaverile tiene
un corso, alla Bard University, di
studi comparativi sulla dottrina sociale
secondo il giudaismo e il cristianesimo
classico, da Paolo a Ireneo, da
Origene ad Agostino. Ancora più lapidaria
è la risposta alla mia domanda,
forse troppo candida, sul perché si sia
tanto interessato al cristianesimo:
“Perché è la religione che ha conquistato
il mondo ed è il futuro del mondo,
perché si erge a difesa della vita
contro la morte”.
Tre sono stati i momenti forti di
questi quattro giorni romani di Neusner:
la partecipazione alla visita del
Papa in sinagoga, l’udienza privata
del Papa riservata a lui e alla moglie
Suzanne e il dialogo all’Auditorium
con monsignor Forte sul Discorso della
Montagna. Sul primo Neusner è stato
chiaro: “Un incredibile evento di
partecipazione, con ogni posto a sedere
occupato, sono stato davvero felice
di parteciparvi, un buon segno per il
dialogo religioso”. Sul secondo si dilunga
invece molto di più, parliamo “a
caldo” (l’ho accompagnato io in Vaticano),
cioè a visita appena avvenuta, e
il racconto che ne fanno i coniugi
Neusner vale la pena di riportarlo per
intero: “Siamo arrivati al Cortile San
Damaso alle 11,15 e abbiamo aspettato
a lungo per essere ricevuti, il Papa
infatti era in ritardo sugli appuntamenti.
Ci hanno fatto accomodare in
una stanza, molto bella in verità, poi ci
hanno chiesto di spostarci in un’altra
ancora più bella, poi in un’altra ancora…
insomma, abbiamo visitato cinque
diverse stanze, tutte splendide, e
in ognuna entrava qualcuno che ci
chiedeva scusa a nome del Papa; persone
gentilissime che parlavano ognuna
una lingua diversa, noi ce la siamo
cavata con l’inglese. Nessuno però ci
ha mai indicato dove fosse la toilette,
mi ha colpito, quando siamo stati ricevuti
alla Casa Bianca più volte ci hanno
chiesto se avevamo bisogno del bagno,
ma si sa, noi americani siamo
gente più pratica. Finalmente entriamo
nello studio del Papa (ma quant’è
grande, lo studio!) ed eravamo veramente
elettrizzati. Lui è stato gentilissimo
e ci ha messo a nostro agio. Eravamo
solo noi tre e siamo rimasti soli
per quindici minuti, il tempo sufficiente
direi, per due professori. Conoscevo
da tanti anni lo studioso e lo stimavo,
ora ero molto interessato a incontrare
e conoscere l’uomo. E Ratzinger
è un uomo umile, gentile. Non
sente l’urgenza di riempire il silenzio
tra una parola e l’altra, si mette in
ascolto. Inoltre ha ancora la sana curiosità
dello studioso, non l’ha messa
da parte. Mi ha chiesto dei miei studenti,
gli ho detto che li adoro e lui ha
sorriso, ha capito cosa intendevo con
quell’espressione. La cosa che più mi
ha colpito sono stati i suoi occhi penetranti,
capace di attraversarti”. Mentre
Neusner parla mi viene in mente
l’espressione che usa Pier Paolo Pasolini
nel suo libro sull’India quando
parla di Madre Teresa di Calcutta:
“Quando guarda, vede” e poi la Deus
Caritas est che al punto n. 31 afferma:
“Il programma del cristiano è un cuore
che vede”. Neusner continua su
questo aspetto degli occhi e della visione.
“Ratzinger è un uomo che ha
una visione: per l’Europa, per il mondo,
per l’umanità, per la vita (e contro
la morte). Nessun altro oggi sembra
avere una visione, anche la politica un
po’ dovunque è in crisi. Quest’uomo
gentile sa dove vuole andare”. Gli
chiedo se hanno parlato di politica,
nega recisamente: “Non abbiamo parlato
di politica”. E dell’incontro di ieri
in sinagoga? Niente. E di che cosa
avete discusso? “Abbiamo parlato dei
nostri libri, come si fa tra professori.
Io gli ho regalato due libri, l’edizione
italiana del mio saggio sul Talmud e
l’edizione tedesca di “Un rabbino parla
con Gesù” e lui lo ha molto gradito
perché l’aveva letto in inglese (lingua
che conosce e pronuncia in modo eccellente)
e anche perché, ha detto,
‘non sono libri molto lunghi… così li
potrò leggere’, ha soggiunto quasi sospirando
e mi ha parlato del suo nuovo
libro, il secondo volume su Gesù di
Nazareth che ha da poco finito e che
uscirà tra sei mesi. Gli ho chiesto se
aveva in mente di scrivere altri libri
ma la risposta (che sembra rivelare il
suo desiderio reale) è stata piuttosto
negativa: “Ho 83 anni, altre cose da fare”.
Al che ho desistito dal mio intento,
quello di proporgli di scrivere un
libro insieme”. L’ho lasciato parlare,
finire di raccontare questo strano incontro
tra due vecchi professori che
ora si trovano di nuovo a migliaia di
chilometri di distanza e, pur essendosi
incontrati per soli quindici minuti,
forse sono un po’ meno soli.
Il terzo momento è stato lunedì sera
all’Auditorium, il dialogo pubblico
tra lui e S. E. monsignor Forte. Avevamo
pranzato insieme con Neusner e
mi aveva detto che aveva letto e apprezzato
il testo che l’arcivescovo di
Chieti avrebbe letto apparso sul Sole
24 Ore (il rabbino legge e parla correttamente
l’italiano). Il rischio a questo
punto era, per dirla con Bernanos, che
l’incontro tra il teologo cattolico e il
rabbino ebreo fosse una conversazione
all’insegna del miele piuttosto che
un dibattito con la giusta dose di sale,
ma il rischio è stato scongiurato grazie
soprattutto alla sincerità dei due interlocutori
che sono rimasti amabilmente
in disaccordo. “Un vero maestro
non è chi dice qualcosa di nuovo,
ma chi dice qualcosa di vero”, ha affermato
Neusner, e monsignor Forte
ha apprezzato la franchezza aggiungendo
che: “La novità del messaggio
di Cristo non sta nel messaggio ma nel
messaggero”. “Chi si dichiara Signore
del Sabato si pone fuori e al di sopra
della Torah”, ha ribadito il rabbino,
ma “il Discorso della Montagna non è
una legge che si contrappone alla legge
mosaica”, ha concluso il teologo (citando
il protestante Jeremias), “bensì
un Vangelo, la buona notizia sull’amore
di Dio che si incarna per salvare gli
uomini”. Un confronto vero contrassegnato
dalle rotondità delle arcate dei
discorsi di Forte e dalle secche e rapide
risposte di Neusner.
E laconico è stato anche in auto
mentre ritornava in albergo, quando
ho pensato di provocarlo chiedendogli
di Pio XII: “Ora è troppo presto per
giudicare. Certo mi sembra che ci siano
degli attacchi contro il dialogo tra
noi e la chiesa da persone che disonestamente
non hanno alcun interesse
nemmeno nella causa del giudaismo”,
ma non ha voluto aggiungere di più.
Gli ricordo la posizione di un ebreo
italiano come Paolo Mieli, che ha più
volte affermato di aver apprezzato
molto di più gli interventi reali e concreti
della chiesa che ha salvato tante
vite umane, rispetto all’ipotetico discorso
pubblico di denuncia da parte
del Papa. Neusner mi ha guardato e
mi ha risposto ancora una volta laconicamente:
“Say little but do much”.
Alla fine di questo intenso weekend
con un anziano rabbino in giro per
Roma, con il suo fare un po’ stravagante,
teso più a osservare che a parlare,
posso dire che proprio il suo essere e
venire “da fuori” mi ha aiutato a ripulire
le mie finestre e a vedere una cosa
così vicina, come il Papa, da un’altra
prospettiva. E se invece penso al
mio amico Jacob-Giacomo, che ora è
in viaggio per New York, mi viene subito
in mente quello che Gesù disse
del baldanzoso apostolo Natanaele,
quello che lo sfotteva sulle sue origini
di Nazareth: “Ecco un israelita senza
falsità!” (Gv 1,47).
Chi è Jacob Neusner, il rabbino amico di Benedetto XVI che parla con Gesù
Roma. L’altro ieri, all’indomani della partecipazione
alla visita del Papa alla Sinagoga di Roma e
qualche ora prima di un dialogo pubblico tenuto all’Auditorium
con l’arcivescovo di Chieti-Vasto Bruno
Forte, il grande biblista ebreo americano Jacob
Neusner è stato ricevuto in Vaticano da Benedetto
XVI. Un’udienza che suggella una particolare amicizia:
i due, che già si erano incontrati personalmente
in occasione della visita del Papa alla sinagoga di
New York dell’aprile 2008, hanno infatti coltivato
per anni un intenso rapporto epistolare. La cosa è
stata rivelata anche dal Papa nel quarto capitolo del
suo “Gesù di Nazaret” dove egli descrive Neusner
così: “Un ebreo osservante e rabbino, cresciuto in
amicizia con cattolici ed evangelici, insegna all’università
insieme con teologi cristiani e nutre un
profondo rispetto nei confronti della fede dei suoi
colleghi cristiani, ma resta saldamente convinto della
validità dell’interpretazione ebraica delle Sacre
Scritture”. Secondo Ratzinger, sono stati “il profondo
rispetto verso la fede cristiana e la sua fedeltà al
giudaismo” che hanno indotto Neusner a cercare il
dialogo con Gesù”.
Nato a Hartford nel Connecticut nel ’32, sposato e
padre di quattro figli, Neusner è un rabbino culturalmente
influente quanto raffinato, tra i massimi
esperti delle Sacre Scritture ebree: a oltre novecento
ammontano le sue pubblicazioni su Torah, Mishnah,
Talmud e sui Midrash. Ha insegnato in diverse
università americane (Columbia, Wisconsin, Dartmouth)
e dal ’94 insegna Storia e teologia del giudaismo
al Bard College di New York. Ma la grande notorietà
di cui gode gli è arrivata proprio con la pagina
129 del saggio di Benedetto XVI su Gesù di Nazaret.
Qui il Papa riconosce il “grande aiuto” che ha
ricevuto dalla lettura del libro del rabbino.
Il Papa parla di Neusner quando esamina i tre
capitoli del vangelo di Matteo, dal quinto al settimo,
che raccolgono il Discorso della montagna, che per
i cristiani è “la nuova Torah, portata da Gesù” dopo
quella consegnata al popolo di Israele da Mosè. Qui
entra in scena Neusner con il suo libro “Un rabbino
parla con Gesù”. Neusner, scrive il Papa, “si è,
per così dire, inserito tra gli ascoltatori del Discorso
della montagna e ha poi cercato di avviare un colloquio
con Gesu”. E ancora: “Questa disputa, condotta
con rispetto e franchezza fra un ebreo credente
e Gesù, il figlio di Abramo, più delle altre interpretazioni
del Discorso della montagna a me note,
mi ha aperto gli occhi sulla grandezza della parola
di Gesù e sulla scelta di fronte alla quale ci pone il
Vangelo. Così desidero entrare anch’io, da cristiano,
nella conversazione del rabbino con Gesù, per comprendere
meglio, partendo da essa, ciò che è autenticamente
ebraico e ciò che costituisce il mistero di
Gesù”. Papa Ratzinger – ha ricordato il cardinale
Christoph Schönborn presentando nel 2007 il libro
in Vaticano – definì il libro del rabbino Neusner come
“il saggio di gran lunga più importante per il
dialogo ebraico-cristiano che sia stato pubblicato
nell’ultimo decennio”. Perché? “Perché egli oppone
un netto rifiuto a tutti i tentativi di scindere il Gesù
storico dal Gesù del dogma della chiesa. (pr)
Il Foglio 19 gennaio 2010











