Ma conoscendo Cristo – questo è il punto essenziale - conosciamo il volto di Dio. Cristo è soprattutto la rivelazione di Dio. In tutti i tempi, gli uomini percepiscono l’esistenza di Dio, un Dio unico, ma che è lontano e non si mostra. In Cristo questo Dio si mostra, il Dio lontano diventa vicino. "Tutto ciò" è quindi, soprattutto col mistero di Cristo, Dio che si è fatto vicino a noi. Ciò implica un’altra dimensione: Cristo non è mai solo; Egli è venuto in mezzo a noi, è morto solo, ma è risorto per attirare tutti sé. Cristo, come dice la Scrittura, si crea un corpo, riunisce tutta l’umanità nella sua realtà della vita immortale. E così, in Cristo che riunisce l’umanità, conosciamo il futuro dell’umanità: la vita eterna. Tutto ciò, quindi, è molto semplice, in ultima istanza: conosciamo Dio conoscendo Cristo, il suo corpo, il mistero della Chiesa e la promessa della vita eterna.
CITTA' DEL VATICANO, mercoledì, 20 gennaio 2010 (ZENIT.org).- Pubblichiamo di seguito il discorso pronunciato mercoledì da Benedetto XVI in occasione dell'Udienza generale nell'aula Paolo VI, dove ha incontrato gruppi di pellegrini e fedeli giunti dall’Italia e da ogni parte del mondo.
Nel discorso in lingua italiana, il Papa ha parlato della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
* * *
Cari fratelli e sorelle!
Siamo al centro della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, un’iniziativa ecumenica, che si è andata strutturando ormai da oltre un secolo, e che attira ogni anno l’attenzione su un tema, quello dell’unità visibile tra i cristiani, che coinvolge la coscienza e stimola l’impegno di quanti credono in Cristo. E lo fa innanzitutto con l’invito alla preghiera, ad imitazione di Gesù stesso, che chiede al Padre per i suoi discepoli "Siano uno, affinché il mondo creda" (Gv 17,21). Il richiamo perseverante alla preghiera per la piena comunione tra i seguaci del Signore manifesta l’orientamento più autentico e più profondo dell’intera ricerca ecumenica, perché l’unità, prima di tutto, è dono di Dio. Infatti, come afferma il Concilio Vaticano Secondo: "il santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell’unica Chiesa di Cristo, una e unica, supera tutte le forze umane" (Unitatis Redintegratio, 24). Pertanto, oltre al nostro sforzo di sviluppare relazioni fraterne e promuovere il dialogo per chiarire e risolvere le divergenze che separano le Chiese e le Comunità ecclesiali, è necessaria la fiduciosa e concorde invocazione al Signore.
Il tema di quest’anno è preso dal Vangelo di san Luca, dalle ultime parole del Risorto ai suoi discepoli "Di questo voi siete testimoni" (Lc 24,48). La proposta del tema è stata chiesta dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, in accordo con la Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese, ad un gruppo ecumenico della Scozia. Un secolo fa la Conferenza Mondiale per la considerazione dei problemi in riferimento al mondo non cristiano ebbe luogo proprio ad Edimburgo, in Scozia, dal 13 al 24 giugno 1910. Tra i problemi allora discussi vi fu quello della difficoltà oggettiva di proporre con credibilità l’annuncio evangelico al mondo non cristiano da parte dei cristiani divisi tra loro. Se ad un mondo che non conosce Cristo, che si è allontanato da Lui o che si mostra indifferente al Vangelo, i cristiani si presentano non uniti, anzi spesso contrapposti, sarà credibile l’annuncio di Cristo come unico Salvatore del mondo e nostra pace? Il rapporto fra unità e missione da quel momento ha rappresentato una dimensione essenziale dell’intera azione ecumenica e il suo punto di partenza. Ed è per questo specifico apporto che quella Conferenza di Edimburgo rimane come uno dei punti fermi dell’ecumenismo moderno. La Chiesa Cattolica, nel Concilio Vaticano II, riprese e ribadì con vigore questa prospettiva, affermando che la divisione tra i discepoli di Gesù "non solo contraddice apertamente alla volontà di Cristo, ma anche è di scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della predicazione del Vangelo ad ogni creatura" (Unitatis Redintegratio, 1).
In tale contesto teologico e spirituale si situa il tema proposto in questa Settimana per la meditazione e la preghiera: l’esigenza di una testimonianza comune a Cristo. Il breve testo proposto come tema "Di questo voi siete testimoni" è da leggere nel contesto dell’intero capitolo 24 del Vangelo secondo Luca. Ricordiamo brevemente il contenuto di questo capitolo. Prima le donne si recano al sepolcro, vedono i segni della Risurrezione di Gesù e annunciano quanto hanno visto agli Apostoli e agli altri discepoli (v. 8); poi lo stesso Risorto appare ai discepoli di Emmaus lungo il cammino, appare a Simon Pietro e successivamente, agli "Undici e agli altri che erano con loro" (v. 33). Egli apre la mente alla comprensione delle Scritture circa la sua Morte redentrice e la sua Risurrezione, affermando che "nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati" (v. 47). Ai discepoli che si trovano "riuniti" insieme e che sono stati testimoni della sua missione, il Signore Risorto promette il dono dello Spirito Santo (cfr v. 49), affinché insieme lo testimonino a tutti i popoli. Da tale imperativo – "Di tutto ciò", di questo voi siete testimoni (cfr Lc 24,48) -, che è il tema di questa Settimana per l’unità dei cristiani, nascono per noi due domande. La prima: cosa è "tutto ciò"? La seconda: come possiamo noi essere testimoni di "tutto ciò"?
Se vediamo il contesto del capitolo, "tutto ciò" vuole dire innanzitutto la Croce e la Risurrezione: i discepoli hanno visto la crocifissione del Signore, vedono il Risorto e così cominciano a capire tutte le Scritture che parlano del mistero della Passione e del dono della Risurrezione. "Tutto ciò" quindi è il mistero di Cristo, del Figlio di Dio fattosi uomo, morto per noi e risorto, vivo per sempre e così garanzia della nostra vita eterna.
Ma conoscendo Cristo – questo è il punto essenziale - conosciamo il volto di Dio. Cristo è soprattutto la rivelazione di Dio. In tutti i tempi, gli uomini percepiscono l’esistenza di Dio, un Dio unico, ma che è lontano e non si mostra. In Cristo questo Dio si mostra, il Dio lontano diventa vicino. "Tutto ciò" è quindi, soprattutto col mistero di Cristo, Dio che si è fatto vicino a noi. Ciò implica un’altra dimensione: Cristo non è mai solo; Egli è venuto in mezzo a noi, è morto solo, ma è risorto per attirare tutti sé. Cristo, come dice la Scrittura, si crea un corpo, riunisce tutta l’umanità nella sua realtà della vita immortale. E così, in Cristo che riunisce l’umanità, conosciamo il futuro dell’umanità: la vita eterna. Tutto ciò, quindi, è molto semplice, in ultima istanza: conosciamo Dio conoscendo Cristo, il suo corpo, il mistero della Chiesa e la promessa della vita eterna.
Veniamo ora alla seconda domanda. Come possiamo noi essere testimoni di "tutto ciò"? Possiamo essere testimoni solo conoscendo Cristo e, conoscendo Cristo, anche conoscendo Dio. Ma conoscere Cristo implica certamente una dimensione intellettuale - imparare quanto conosciamo da Cristo - ma è sempre molto più che un processo intellettuale: è un processo esistenziale, è un processo dell'apertura del mio io, della mia trasformazione dalla presenza e dalla forza di Cristo, e così è anche un processo di apertura a tutti gli altri che devono essere corpo di Cristo. In questo modo, è evidente che conoscere Cristo, come processo intellettuale e soprattutto esistenziale, è un processo che ci fa testimoni. In altre parole, possiamo essere testimoni solo se Cristo lo conosciamo di prima mano e non solo da altri, dalla nostra propria vita, dal nostro incontro personale con Cristo. Incontrandolo realmente nella nostra vita di fede diventiamo testimoni e possiamo così contribuire alla novità del mondo, alla vita eterna. Il Catechismo della Chiesa Cattolica ci dà un'indicazione anche per il contenuto di questo "tutto ciò". La Chiesa ha riunito e riassunto l'essenziale di quanto il Signore ci ha donato nella Rivelazione, nel "Simbolo detto niceno-costantinopolitano, il quale trae la sua grande autorità dal fatto di essere frutto dei primi due Concili Ecumenici (325 e 381)" (CCC, n. 195). Il Catechismo precisa che questo Simbolo "è tuttora comune a tutte le grandi Chiese dell’Oriente e dell’Occidente" (Ibid.). In questo Simbolo quindi si trovano le verità di fede che i cristiani possono professare e testimoniare insieme, affinché il mondo creda, manifestando, con il desiderio e l’impegno di superare le divergenze esistenti, la volontà di camminare verso la piena comunione, l’unità del Corpo di Cristo.
La celebrazione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani ci porta a considerare altri aspetti importanti per l’ecumenismo. Innanzitutto, il grande progresso realizzato nelle relazioni tra Chiese e Comunità ecclesiali dopo la Conferenza di Edimburgo di un secolo fa. Il movimento ecumenico moderno si è sviluppato in modo così significativo da diventare, nell’ultimo secolo, un elemento importante nella vita della Chiesa, ricordando il problema dell’unità tra tutti i cristiani e sostenendo anche la crescita della comunione tra loro. Esso non solo favorisce i rapporti fraterni tra le Chiese e le Comunità ecclesiali in risposta al comandamento dell’amore, ma stimola anche la ricerca teologica. Inoltre, esso coinvolge la vita concreta delle Chiese e delle Comunità ecclesiali con tematiche che toccano la pastorale e la vita sacramentale, come, ad esempio, il mutuo riconoscimento del Battesimo, le questioni relative ai matrimoni misti, i casi parziali di comunicatio in sacris in situazioni particolari ben definite. Nel solco di tale spirito ecumenico, i contatti sono andati allargandosi anche a movimenti pentecostali, evangelici e carismatici, per una maggiore conoscenza reciproca, benchè non manchino problemi gravi in questo settore.
La Chiesa cattolica, dal Concilio Vaticano II in poi, è entrata in relazioni fraterne con tutte le Chiese d’Oriente e le Comunità ecclesiali d’Occidente, organizzando, in particolare, con la maggior parte di esse, dialoghi teologici bilaterali, che hanno portato a trovare convergenze o anche consensi in vari punti, approfondendo così i vincoli di comunione. Nell’anno appena trascorso i vari dialoghi hanno registrato positivi passi. Con le Chiese Ortodosse la Commissione Mista Internazionale per il Dialogo Teologico ha iniziato, nell’XI Sessione plenaria svoltasi a Paphos di Cipro nell’ottobre 2009, lo studio di un tema cruciale nel dialogo fra cattolici e ortodossi: Il ruolo del vescovo di Roma nella comunione della Chiesa nel primo millennio, cioè nel tempo in cui i cristiani di Oriente e di Occidente vivevano nella piena comunione. Questo studio si estenderà in seguito al secondo millennio. Ho già più volte chiesto la preghiera dei cattolici per questo dialogo delicato ed essenziale per l’intero movimento ecumenico. Anche con le Antiche Chiese ortodosse d’Oriente (copta, etiopica, sira, armena) l’analoga Commissione Mista si è incontrata dal 26 al 30 gennaio dello scorso anno. Tali importanti iniziative attestano come sia in atto un dialogo profondo e ricco di speranze con tutte le Chiese d’Oriente non in piena comunione con Roma, nella loro propria specificità.
Nel corso dell’anno passato, con le Comunità ecclesiali di Occidente si sono esaminati i risultati raggiunti nei vari dialoghi in questi quarant’anni, soffermandosi, in particolare, su quelli con la Comunione Anglicana, con la Federazione Luterana Mondiale, con l’Alleanza Riformata Mondiale e con il Consiglio Mondiale Metodista. Al riguardo, il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani ha realizzato uno studio per enucleare i punti di convergenza a cui si è giunti nei relativi dialoghi bilaterali, e segnalare, allo stesso tempo, i problemi aperti su cui occorrerà iniziare una nuova fase di confronto.
Tra gli eventi recenti, vorrei menzionare la commemorazione del decimo anniversario della Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione, celebrato insieme da cattolici e luterani il 31 ottobre 2009, per stimolare il proseguimento del dialogo, come pure la visita a Roma dell’Arcivescovo di Canterbury, il Dottor Rowan Williams, il quale ha avuto anche colloqui sulla particolare situazione in cui si trova la Comunione Anglicana. Il comune impegno di continuare le relazioni e il dialogo sono un segno positivo, che manifesta quanto sia intenso il desiderio dell’unità, nonostante tutti i problemi che si oppongono. Così vediamo che c’è una dimensione della nostra responsabilità nel fare tutto ciò che è possibile per arrivare realmente all’unità, ma c’è l’altra dimensione, quella dell’azione divina, perché solo Dio può dare l’unità alla Chiesa. Una unità "autofatta" sarebbe umana, ma noi desideriamo la Chiesa di Dio, fatta da Dio, il quale quando vorrà e quando noi saremo pronti, creerà l’unità. Dobbiamo tenere presente anche quanti progressi reali si sono raggiunti nella collaborazione e nella fraternità in tutti questi anni, in questi ultimi cinquant’anni. Allo stesso tempo, dobbiamo sapere che il lavoro ecumenico non è un processo lineare. Infatti, problemi vecchi, nati nel contesto di un’altra epoca, perdono il loro peso, mentre nel contesto odierno nascono nuovi problemi e nuove difficoltà. Pertanto dobbiamo essere sempre disponibili per un processo di purificazione, nel quale il Signore ci renda capaci di essere uniti.
Cari fratelli e sorelle, per la complessa realtà ecumenica, per la promozione del dialogo, come pure affinché i cristiani nel nostro tempo possano dare una nuova testimonianza comune di fedeltà a Cristo davanti a questo nostro mondo, chiedo la preghiera di tutti. Il Signore ascolti l’invocazione nostra e di tutti i cristiani, che in questa settimana si eleva a Lui con particolare intensità.
[Il Papa ha poi salutato i pellegrini in diverse lingue. In Italiano ha detto:]
Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto i partecipanti al pellegrinaggio promosso dalle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù, in occasione dell’inaugurazione e benedizione della statua della loro Fondatrice, collocata presso le fondamenta della Basilica Vaticana. Cari amici, sull’esempio di santa Raffaella Maria, siate anche voi testimoni dell’amore misericordioso di Dio. Saluto con affetto i fedeli della parrocchia Santo Nome di Maria in Caserta, convenuti così numerosi in occasione del 25° anniversario di fondazione della loro comunità cristiana. Mentre vi ringrazio per la vostra visita, auspico che questa fausta ricorrenza susciti nuovo impulso per progredire nella fedele e generosa adesione a Cristo e alla Chiesa. Saluto la Pia Associazione del Sacro Cuore di Gesù in Trastevere, che in questi giorni ricorda con opportune iniziative l’80° anniversario della morte del Cardinale Rafael Merry del Val.
Il mio pensiero va infine, come di consueto, ai giovani, ai malati e agli sposi novelli, che oggi vorrei esortare a tradurre in atteggiamenti concreti la preghiera per l’unità dei cristiani. Questi giorni di riflessione costituiscano per voi, cari giovani, un invito ad essere ovunque operatori di pace e di riconciliazione; per voi, cari ammalati, un momento propizio ad offrire le vostre sofferenze per una comunione dei cristiani sempre più piena; e per voi, cari sposi novelli, l’occasione per vivere ancor più la vostra vocazione speciale con un cuore solo ed un’anima sola.
[© Copyright 2010 - Libreria Editrice Vaticana]


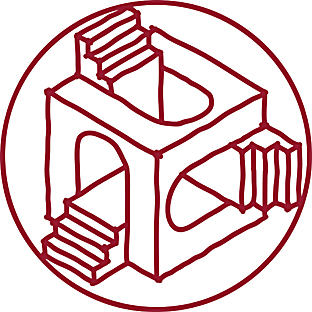 Partendo da Edimburgo per volgere lo sguardo al futuro del dialogo ecumenico, si devono presentare le vicende storiche della Conferenza di Edimburgo con una particolare attenzione all'attività missionaria della quale la Conferenza faceva formalmente parte, e successivamente delineare alcuni elementi per comprendere le radici della dimensione ecumenica assunta dalla Conferenza, anche nell'immaginario collettivo dei cristiani del xx secolo per i quali la Conferenza di Edimburgo coincide con l'inizio del dialogo ecumenico.
Partendo da Edimburgo per volgere lo sguardo al futuro del dialogo ecumenico, si devono presentare le vicende storiche della Conferenza di Edimburgo con una particolare attenzione all'attività missionaria della quale la Conferenza faceva formalmente parte, e successivamente delineare alcuni elementi per comprendere le radici della dimensione ecumenica assunta dalla Conferenza, anche nell'immaginario collettivo dei cristiani del xx secolo per i quali la Conferenza di Edimburgo coincide con l'inizio del dialogo ecumenico. 
