di Paolo Rodari
Non è colpa soltanto del fatto che
essendo l’Osservatore Romano
un giornale di idee e che predilige il
dibattito delle idee – così lo vuole il
direttore Gian Maria Vian in scia ad
auspici espressi tempo addietro da
uno che di giornalismo ci capiva parecchio,
ovvero Papa Paolo VI, figlio
di Giorgio Montini, direttore del Cittadino
di Brescia – la musica pop ha sul
giornale vaticano un posto di rilievo.
E’ anche colpa, se di colpa si può parlare,
dei cronisti che Vian ha in redazione
se ogni tanto il quotidiano del
Pontefice che ama Mozart, Bach,
Beethoven, Palestrina, Berlioz, Händel
e Liszt, sdogana, critica, boccia e
riabilita ora questo ora quel cantante
della musica contemporanea.
C’è Marcello Filotei, giornalista e
insieme compositore, che vanta una
conoscenza musicale variegata tanto
che in via del Pellegrino dov’è la sede
del giornale lo chiamano “il maestro”.
Filotei, tra l’altro, è un raffinato
conoscitore di musica elettronica,
il sogno futurista di anticipare i rumori.
Ci sono il segretario di redazione
Gaetano Vallini e il capo del servizio
internazionale Giuseppe Fiorentino
che sono appassionati di musica poprock.
C’è il vicedirettore Carlo Di Cicco
che pur prediligendo la classica
ama il rock ma anche Fabrizio De André.
Poi, certo, ci sono gusti più sobri
come quelli dell’assistente alla direzione
Marilia D’Addio che predilige
la lirica. E, infine, quelli decisamente
più eclettici come sono le passioni
musicali di Vian il quale, come disse
lui stesso in un’intervista rilasciata
più di un anno fa, spazia “dal gregoriano
a Peppino Di Capri, da Frank
Sinatra ai Blues Brothers, polifonia e
oratori barocchi compresi”.
Cos’è la musica? Quell’arte normale
che coglie verità attraverso la bellezza,
disse Benedetto XVI il 10 agosto
del 2008 incontrando il clero a
Bressanone. E l’Osservatore, quest’arte,
la scandaglia in lungo e in largo incurante
di quei mugugni che inevitabilmente
riecheggiano tra le mura
della curia romana quando sotto un
pezzo che rende noto un discorso del
Papa ce n’è un altro che informa del
valore musicale di una stella del rock.
L’infatuazione principale dell’Osservatore
è per i Beatles. Lo si è capito da
più indizi. Nel novembre 2008 il quotidiano
vaticano dedica un pezzo a John
Lennon, di fatto assolvendolo per
quella frase pronunciata quarant’anni
prima: “I Beatles sono più famosi di
Gesù Cristo”. E successivamente, lo
scorso 10 aprile, in occasione del quarantennale
dello scioglimento della
band, sono Vallini e Fiorentino a tornare
sul tema rilevando il “fiuto” epocale
della band inglese. L’Osservatore
ripercorre “i sette anni che sconvolsero
la musica” mettendo in pagina un
notevole repechage. Perché i Fab four
non hanno pari. “Le loro bellissime
melodie hanno cambiato per sempre
la musica leggera e continuano a regalare
emozioni”. Dopo di loro, “musicalmente,
nulla è più stato come prima”.
E ancora: “E’ vero, hanno assunto sostanze
stupefacenti; travolti dal successo
hanno vissuto anni scapestrati e
disinibiti; in un eccesso di spacconeria
hanno detto persino di essere più famosi
di Gesù; non sono stati il migliore
esempio per i giovani del tempo, ma
neppure il peggiore”. E poi “ascoltando
le loro canzoni tutto questo appare
lontano e insignificante. A quarant’anni
dal turbolento scioglimento restano
come gioielli preziosi le loro bellissime
melodie che hanno cambiato per
sempre la musica leggera e continuano
a regalare emozioni”. E poi il finale
agiografico: “Attraverso la loro musica
quei quattro ragazzi di Liverpool,
splendidi e imperfetti, sono stati capaci
di leggere e di esprimere i segni di
un’epoca che a tratti hanno persino indirizzato,
imprimendovi un marchio
indelebile. Un marchio che segna lo
spartiacque tra un prima e un dopo. E
dopo, musicalmente, nulla è più stato
come prima”.
Parole importanti. Una dichiarazione
d’amore in piena regola. Che
però non viene corrisposta. “Ha saputo
che l’Osservatore Romano vi ha riabilitati?”
chiede un giornalista della
Cnn al batterista dei Beatles, Richard
Starkey, in arte Ringo Starr. “I
couldn’t care less”, e cioè “non me ne
potrebbe fregare di meno” risponde
Ringo. “Ma come?” dice il batterista.
“Eravamo satanici e adesso ci perdonano?
Credo che la Santa Sede abbia
altre cose di cui parlare”. Ma l’Osservatore
non si dà per vinto e spiega
che in realtà il suo giornale non ha
riabilitato nessuno. Già nel 1966 l’Osservatore
dedicò un pezzo ai Beatles
i quali, per primi, spiegarono che dicendo
d’essere più famosi di Cristo
intendevano soltanto deplorare l’atteggiamento
della gente nei confronti
del cristianesimo. “Non ho mai detto
che i Beatles siano migliori di Dio o
di Gesù”, disse Lennon.
Quanto a satana, Ringo Starr non
ha tutti i torti. Già nel 2000 Joseph
Ratzinger parlava della musica rock
e pop, i cui raduni sono sostanzialmente
“pratiche di redenzione la cui
forma è apparentata a quella della
droga e che sono fondamentalmente
opposte alla fede cristiana nella redenzione”.
“Perciò è coerente con
tutto ciò – diceva Ratzinger – che ora
in quest’ambito dilaghino sempre più
anche culti satanici e musiche sataniche,
la cui potenza pericolosa, in
quanto scientemente finalizzata alla
rovina e alla distruzione della persona,
non è ancora presa sufficientemente
sul serio”.
Oltre ai Beatles, anche Bruce
Springsteen e la sua E Street Band. E’
il luglio del 2009. The Boss è a Roma
per un concerto. L’Osservatore lo segue.
Manda i suoi cronisti ad assistere
alla performance: “Tra badlands e
terra promessa in scena l’essenza del
rock” è il titolo che il quotidiano decide
di dedicare al pezzo. I concerti di
Springsteen sono “una garanzia” che
“difficilmente lascia delusi” si legge
nell’articolo. Il concerto del cantante
statunitense sono “tre ore di buon
rock, con la grinta e la bravura di
sempre”. E ancora: “La carica che
riesce a trasmettere, nonostante i
quasi sessant’anni, è pari alle emozioni
che la musica e i testi comunicano”.
E giù elogi. Ammiccamenti che
sembrano lontani dalle parole che
ancora il cardinale Ratzinger disse
nel 1996: il rock “è espressione di passioni
elementari, che nei grandi raduni
di musica hanno assunto caratteri
cultuali, cioè di controculto, che si oppone
al culto cristiano”.
La riabilitazione più impegnativa
dell’Osservatore è stata probabilmente
quella di Michael Jackson. La vita
sregolata e piena di eccessi dell’autore
di “Thriller” non scalfisce il riconoscimento
artistico che l’Osservatore
vuole tributargli. “'Ma sarà morto
davvero?” si chiede il quotidiano della
Santa Sede lo scorso giugno. E ancora:
“Ci sarebbe poco da stupirsi se
tra qualche anno venisse riconosciuto
in una stazione di servizio di
Memphis, magari assieme all’ex suocero
Elvis Presley, un altro di quei
miti che, come Janis Joplin, Jim Morrison,
Jimi Hendrix o John Lennon,
non muoiono mai nell’immaginazione
dei loro fan. E un mito del pop è
sicuramente Michael Jackson, morto
ieri all’età di cinquant’anni”. L’articolo
fa il giro del mondo. E arriva sulle
scrivanie dei principali attori neoconservatori
americani. Tra questi il
direttore di “Crisis” Deal Hudson
che commenta l’articolo dicendo che
oramai l’Osservatore ha intrapreso
una “spirale discendente”.
Il 2009 è un anno particolare quanto
al rapporto tra Osservatore e musica
rock. In febbraio il quotidiano vaticano
sorprende. A poche ore dall’inizio
del Festival di Sanremo pubblica
un “piccolo prontuario di resistenza
musicale”. Si tratta di un decalogo
formato da una serie di direttive e indicazioni
ritenute utili per difendersi
dalla valanga sonora in arrivo. A essere
proposte come valida alternativa
all’onda canora che “inonderà implacabile
l’etere fino alla prossima estate”
sono pietre miliari della storia
della musica, ossia “alcuni dischi di
cui non si può fare a meno per ritemprare
gli esausti padiglioni auricolari
dell’uomo mediatico”. Al primo posto
della classifica dell’Osservatore, ovviamente,
i Beatles con “Revolver”
(1966), “un Cd che segnò l’inizio di una
nuova epoca musicale, quella contemporanea”.
Al secondo posto David
Crosby con “If I could only remember
my name” (1971), nato dalla collaborazione
con grandi musicisti, come Joni
Mitchell e Neil Young. “The dark side
of the moon” dei Pink Floyd è al terzo
posto del prontuario di buona musica,
mentre al quarto posto c’è “Rumours”
dei Fleetwood Mac (1977). Al
quinto posto ecco “The nightfly” di
Donald Fagen, (1982), mentre al sesto
e settimo posto vengono segnalati rispettivamente
“Thriller” di Michael
Jackson e “Graceland” di Paul Simon.
A chiudere la classifica sono gli U2
con “Achtung baby” (1991), gli Oasis
con “(What’s the story) Morning
glory?” (1995), e “Supernatural” di
Carlos Santana (1999). In coda Bob
Dylan, per la “grande vena poetica
che sconfina spesso nel visionario e,
dopo la conversione, nel messianico”.
O forse, chissà, perché fu una delle
poche star ammesse a cantare davanti
a Giovanni Paolo II.
Non tutta la musica italiana per
l’Osservatore merita d’essere stroncata.
Lo scorso gennaio, infatti, il giornale
vaticano anticipa in pagina un’intervista
a Francesco Guccini che pochi
giorni dopo esce sulla rivista “Vita
e Pensiero”, il bimestrale dell’Università
cattolica del sacro cuore.
L’“agnostico” Guccini, come “in genere”
si definisce lui, spazia sulle pagine
del giornale del Papa dal senso religioso
della vita che “può essere l’avere
una morale che hai assunto fin
da quando eri bambino: poi si è modificato
con certe conoscenze, certi incontri
e certe cose, ma grosso modo è
quello”, alla Bibbia che, dice, “è un
grande libro, assolutamente da leggere”.
Perché? “E’ pieno di storie affascinanti,
di testi poetici. Da ragazzetti
si leggeva soprattutto il Cantico dei
Cantici, che era così erotico. Certo,
quando t’imbatti nel Levitico o in
quelle interminabili genealogie di
personaggi più o meno sconosciuti,
l’entusiasmo tende inevitabilmente a
scemare, e li salti a piè pari. Amo in
particolare, naturalmente, la Genesi e
l’Apocalisse, e sono convinto che ci
possa essere una lettura di questi libri
non necessariamente confessionale”.
Peggior fortuna ha sull’Osservatore
un altro italiano: Giovanni Allevi.
Questi non canta. Non suona musica
rock. Semplicemente compone col
piano. O così sembrava ai più prima
che l’Osservatore dicesse la sua: “Giovanni
Allevi non è affatto ‘strambo’ –
scrive il giornale del Papa –, è costruito
con una cura assoluta ed è la rappresentazione
oleografica del compositore,
così come se l’aspetta chi non
ha molta consuetudine con le sale da
concerto”. E ancora: “Il compositore
marchigiano arriva e offre al pubblico
quello che già conosce. E questa è
la forza culturalmente pericolosa dell’operazione
Allevi: convincerci che
tutto quello che non capiamo non vale
la pena di essere compreso. Rassicurati
sul fatto che ‘non siamo noi
ignoranti, sono loro che non sanno
più scrivere una bella melodia’, potremo
finalmente andare fieri di non
avere mai ascoltato Stravinskij”.
Allevi definisce la sua musica
“classica contemporanea”. E questa,
a differenza del rock contemporaneo,
non piace al quotidiano vaticano. Così
si conclude l’articolo: “In un paese
come l’Italia dove c’è chi, come Alessandro
Baricco, arriva a scrivere e dirigere
film per spiegare che Beethoven
è sopravvalutato, è abbastanza
frequente che si cada nel tranello
dell’artista svagato. Certo non è colpa
dell’artista in questione, ma di un sistema
scolastico fatto di flauti dolci e
Fra Martino campanaro che spesso
non fornisce gli strumenti per distinguere
Arisa da Billie Holiday, figuriamoci
Puccini da Allevi”.
Dall’Italia si torna fuori i patri confini.
Fino in Irlanda, a Dublino, la
città degli U2. E’ Vallini a condurre
un’indagine su Bono. E il risultato
sorprende. E’ Bono a essere uno degli
artisti più credenti, almeno a giudicare
dalla quantità di riferimenti e allusione
ai testi sacri presenti nei testi
che scrive per gli U2. Dice l’Osservatore
che i testi di Bono hanno in più
di una occasione dei risvolti religiosi.
Nel brano “Gloria”, presente nell’album
del 1981 “October”, Bono e gli altri
sembrano essere alla ricerca di
Dio: “I try, I try to speak up / But only
in you I’m complete”. E anche negli
ultimi lavori come in “No Line On the
Horizon”, la valenza liturgica della
band non sembra aver perso forza.
Nella “litaniante” “Magnificent” (che
già nel titolo fa capire l’antifona del
brano) “l’esplorazione sembra essere
andata davvero troppo avanti”, mentre
in “Unknown Caller” “tutto sembra
essere tornato sulla retta via”.
Le pagine dell’Osservatore dedicate
alla cultura sono fatte così: si trovano
tante cose diverse tra loro. Le invasioni
nel campo musicale non sono
capite da tutti ma comunque si fanno
notare. E sorprendono. Come sorprese
nel luglio del 2008 una chicca:
un’intervista a Dolores Hart, che in
“Loving you” fu la prima attrice a baciare
Elvis Presley sul grande schermo
e nel ’63 diede l’addio alle scene
per chiudersi in un convento di clausura.
Il titolo è azzeccato: “Love me
tender di un amore più grande”. E’
l’amore per Dio che porta Dolores a
entrare in clausura. E’ l’amore per la
musica, anche per il rock profano,
che spinge l’Osservatore a scriverne.
© Copyright Il Foglio 1 maggio 2010

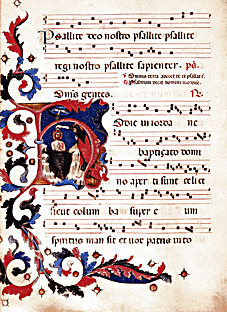
 Nell'istruzione Musicam sacram della Congregazione dei Riti (1967), per l'applicazione delle norme conciliari, si fa presente che "nelle azioni liturgiche in canto celebrate in lingua latina: a) Al canto gregoriano, come canto proprio della liturgia romana, si riservi, a parità di condizioni, il primo posto. Le melodie esistenti nelle edizioni tipiche si usino nel modo più opportuno. b) Conviene inoltre che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici ad uso delle chiese minori. c) Le composizioni musicali di altro genere, a una o più voci, appartenenti al patrimonio tradizionale, o contemporanee, siano tenute in onore, si incrementino e si eseguiscano secondo le possibilità". E ancora, nella costituzione conciliare sulla liturgia si afferma che: "per conservare il patrimonio della musica sacra e per favorire debitamente le nuove forme del canto sacro "si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati e negli studentati dei Religiosi e delle Religiose, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche" (Sacrosanctum concilium, 115), specialmente presso gli Istituti superiori creati a questo scopo". Pertanto, "si incrementi prima di tutto lo studio e l'uso del canto gregoriano che, per le sue caratteristiche, è una base importante nella educazione alla musica sacra" (Musicam sacram, 52).
Nell'istruzione Musicam sacram della Congregazione dei Riti (1967), per l'applicazione delle norme conciliari, si fa presente che "nelle azioni liturgiche in canto celebrate in lingua latina: a) Al canto gregoriano, come canto proprio della liturgia romana, si riservi, a parità di condizioni, il primo posto. Le melodie esistenti nelle edizioni tipiche si usino nel modo più opportuno. b) Conviene inoltre che si prepari un'edizione che contenga melodie più semplici ad uso delle chiese minori. c) Le composizioni musicali di altro genere, a una o più voci, appartenenti al patrimonio tradizionale, o contemporanee, siano tenute in onore, si incrementino e si eseguiscano secondo le possibilità". E ancora, nella costituzione conciliare sulla liturgia si afferma che: "per conservare il patrimonio della musica sacra e per favorire debitamente le nuove forme del canto sacro "si curi molto la formazione e la pratica musicale nei seminari, nei noviziati e negli studentati dei Religiosi e delle Religiose, come pure negli altri istituti e scuole cattoliche" (Sacrosanctum concilium, 115), specialmente presso gli Istituti superiori creati a questo scopo". Pertanto, "si incrementi prima di tutto lo studio e l'uso del canto gregoriano che, per le sue caratteristiche, è una base importante nella educazione alla musica sacra" (Musicam sacram, 52). Ha ragione il Papa quando in più circostanze lamenta il basso livello della musica da consumo, in particolare della musica e dei canti eseguiti nelle chiese in questi ultimi decenni soprattutto da noi in Italia. Ma la causa è l'inadeguatezza dell'educazione musicale. Quello che si fa nelle scuole è troppo poco e le attività alternative o sussidiarie sono solo per pochi fortunati. Nelle parrocchie, poi, almeno in Italia, l'educazione al canto dei cristiani penso sia una delle ultime preoccupazioni pastorali dei nostri parroci e forse anche dei nostri vescovi.
Ha ragione il Papa quando in più circostanze lamenta il basso livello della musica da consumo, in particolare della musica e dei canti eseguiti nelle chiese in questi ultimi decenni soprattutto da noi in Italia. Ma la causa è l'inadeguatezza dell'educazione musicale. Quello che si fa nelle scuole è troppo poco e le attività alternative o sussidiarie sono solo per pochi fortunati. Nelle parrocchie, poi, almeno in Italia, l'educazione al canto dei cristiani penso sia una delle ultime preoccupazioni pastorali dei nostri parroci e forse anche dei nostri vescovi. Cari amici,
Cari amici, 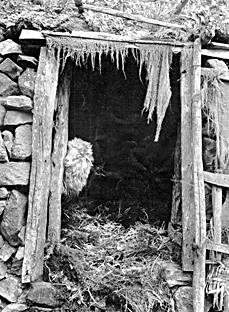
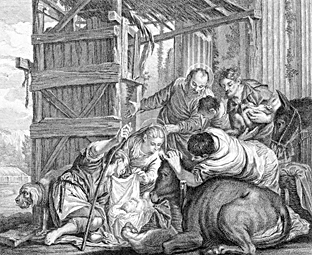 È un Dio bambino che non respinge, quello del Natale. È un Dio che si pone al livello ultimo degli uomini per poter accogliere tutti. È un Dio che entra nella nostra carne così fragile, simile all'"erba che germoglia al mattino: all'alba fiorisce, germoglia e a sera è falciata e dissecca" (Salmi, 90, 5-6). Per questo il Natale deve spogliarsi dell'enfasi, dell'eccezionalità, per essere la celebrazione della quotidianità e della semplicità. Il vescovo e scrittore francese François de Fénelon (1651-1715) in una sua meditazione natalizia affermava: "Ho bisogno della semplicità dei bambini. Mentre il Verbo incarnato, la Parola onnipotente del Padre tace, vagisce, piange e geme, posso io continuare a compiacermi dell'elucubrazione del mio spirito e a soffrire se questo mondo non ha un'idea abbastanza alta delle mie capacità? Ho scelto di essere nel silenzio e nell'oscurità per unirmi all'impotenza e ai vagiti del bambino Gesù".
È un Dio bambino che non respinge, quello del Natale. È un Dio che si pone al livello ultimo degli uomini per poter accogliere tutti. È un Dio che entra nella nostra carne così fragile, simile all'"erba che germoglia al mattino: all'alba fiorisce, germoglia e a sera è falciata e dissecca" (Salmi, 90, 5-6). Per questo il Natale deve spogliarsi dell'enfasi, dell'eccezionalità, per essere la celebrazione della quotidianità e della semplicità. Il vescovo e scrittore francese François de Fénelon (1651-1715) in una sua meditazione natalizia affermava: "Ho bisogno della semplicità dei bambini. Mentre il Verbo incarnato, la Parola onnipotente del Padre tace, vagisce, piange e geme, posso io continuare a compiacermi dell'elucubrazione del mio spirito e a soffrire se questo mondo non ha un'idea abbastanza alta delle mie capacità? Ho scelto di essere nel silenzio e nell'oscurità per unirmi all'impotenza e ai vagiti del bambino Gesù".